«La Libertà, fratelli, non è un vino, né una donna dolce,/ né beni nelle dispense, non è un figlio nella culla;/ è un canto altero e solitario che nel vento muore!». Fin dal proemio della sua Odissea scritta tra il 1925 e il 1938 in sette stesure, Nikos Kazantzakis (Iraklio, 1883 – Friburgo, 1957) – poeta, uomo molteplice e appassionato – dà l’abbrivio a quella che, in ventiquattro canti (come le lettere dell’alfabeto greco), 33.333 versi (in onore della terzina dantesca), è la traiettoria di affrancamento di un uomo, il suo riscatto. Il viaggio di Ulisse narrato diviene una dichiarazione di esistenza di un uomo che ricerca la propria statura di uomo. E la raggiunge. Mentre la vita e letteratura creano aderenze, pori attraverso i quali passa quel fluido che riesce a congiungerle, ossia la verità.
Qual è la verità per Kazantzakis? Quel terribile e limpido processo di emersione di un uomo – Ulisse? Kazantzakis? – da se stesso? Procedimento alchemico. Dove il meno è il più, il niente tutto, il vuoto colmo e ogni cosa pulsa di una vitalità allegra e disperata. La vita danza, quasi sempre a pochi passi da un baratro, e il suo moto non è mai orizzontale. Tutto ha vocazione verticale e l’uomo, per adempiersi, deve raddrizzare la spina dorsale della propria anima.
Combure e nella fiamma trova la Libertà: «Morte, l’Arciere ti ha beffato, ha scialato i tuoi beni,/ le scorie della carne le ha sciolte prima del tuo arrivo,/ ne ha fatto spirito, te le ha sottratte, e se vieni trovi/ soltanto fuochi spenti, carboni e ceneri di carne!» giunge a scrivere il poeta nel XXIII canto. Incontriamo qui Nicola Crocetti, grecista, traduttore, grazie al cui lavoro intenso e rigoroso l’Odissea di Nikos Kazantzakis (Crocetti Editore, 2020) è stata per la prima volta tradotta e pubblicata in Italia.
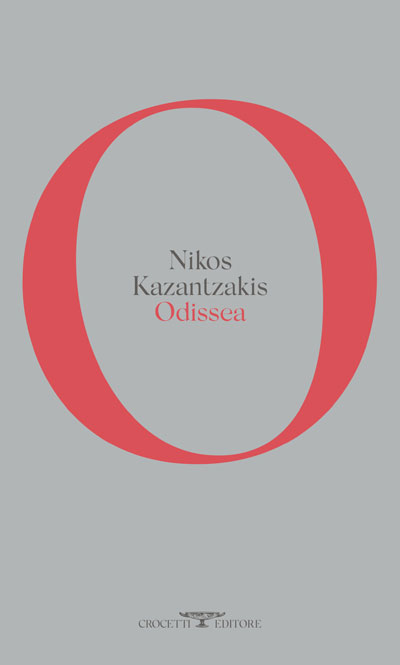
L’Odissea di Nikos Kazantzakis è un poema complesso, polimorfo, dove la poesia nasce dalla perpetua ricerca spirituale, linguistica, umana del suo creatore. Ci racconta la sua genesi?
Kazantzakis racconta nella sua autobiografia spirituale, Rapporto al Greco, la genesi della sua Odissea. Si trova in una casetta su un litorale della sua isola, Creta, quando avverte su di sé l’incombere di un altro corpo invisibile, un corpo più alto e autentico del suo. È il corpo di Ulisse, che gli chiede di essere riportato in vita per indicare una nuova via all’umanità. E quel corpo diventa una nave, su cui Kazantzakis imbarca l’antenato di Itaca, e tutte le parole, le favole e le burle che conosce, gli amici più preziosi, gli uomini più valorosi e i vecchi dèi. E tutti insieme, al comando del coraggioso e scaltro Ulisse salpano. Verso dove? E qual è lo scopo del viaggio? È il periodo in cui un vento di follia soffia sul genere umano, e Kazantzakis si sforza «di prevedere e di incantare con parole armoniose l’uomo, al di là dei massacri e dei pianti, al di là dell’attuale pitecantropo». Tutti i numerosi viaggi che Kazantzakis ha fatto nella sua vita si compendiano e si armonizzano nell’ultimo viaggio di Ulisse, che ha per meta il compimento di un progetto del Destino: liberare l’uomo dalla paura della morte, dalle sue superstizioni e dalle schiavitù ancestrali, renderlo libero da tutto, perfino dalla sua stessa libertà.
«La lingua greca è bella come la Elena di Omero» scrisse Nikos Kazantzakis. E preferì alla lingua katharèvusa – lingua colta ma artificialmente creata – la lingua dimotikì, demotica, la lingua del popolo. Perché lo fece, quali le conseguenze e come ne fu influenzata l’anima del poema?
La lingua, per i greci, è sinonimo di identità. E come tutti i greci, Kazantzakis era innamorato della sua lingua. Ma all’epoca in cui scriveva, in Grecia imperava la diglossia, esistevano cioè due lingue diverse originate dalla stessa matrice. La katharèvusa, la lingua riformata, era la lingua dei pochissimi che avevano studiato, dei giornalisti, della burocrazia ottusa, della classe dominante e del potere assoluto; perciò lui decise di scrivere nella lingua del popolo, la dimotikì, per la quale aveva un amore che sconfinava nell’ossessione. Al punto da fare per molti anni lunghi pellegrinaggi nei paesini sperduti di Creta e nelle isole dell’Egeo, armato di una matita e di un taccuino, su cui trascriveva dalla viva voce di contadini, marinai, popolani spesso analfabeti le parole greche non registrate su nessun vocabolario e quindi a rischio di estinzione. E ha riversato questi lemmi (ne sono stati censiti 7.500) nelle sue opere, in particolare nella sua Odissea, trasformandola così in un’arca di Noè linguistica, salvando in questo modo un patrimonio prezioso e traghettandolo nel futuro. Una parte dell’anima di Kazantzakis e del suo stesso poema è questo immenso patrimonio linguistico.
L’Ulisse di Kazantzakis, pur proseguendo il viaggio dell’Ulisse di Omero, si trasfigura ispirandosi all’Ulisse del XXVI canto dell’Inferno dantesco, non più eroe epico ma quasi mistico, votato a «virtute e canoscenza». Quale è il suo destino, il suo daimon?
L’Ulisse di Omero è un gingillo, quasi un fantoccio, in ostaggio e in balìa del volere degli dèi, che lo sballottano a loro piacimento facendogli impiegare dieci anni per ritrovare la via di casa e approdare infine a Itaca. Kazantzakis, che ha tradotto in greco la Commedia, non solo fa sua la lezione di Dante, ma affida a Ulisse le proprie convinzioni ideali, filosofiche e morali, facendone praticamente un avatar di sé stesso. Kazantzakis si era nutrito della filosofia dei maggiori poeti e filosofi dell’antichità e del suo tempo, dai quali aveva acquisito un grande senso della giustizia sociale. Questo alto senso etico e ideale lui lo trasfonde nel suo Ulisse, al quale affida in sostanza la lezione morale del suo poema: forse non è possibile cambiare la ferocia della natura umana e rimediare alle storture del mondo, ma ogni uomo ha quanto meno il dovere di provarci.
Una profonda e appassionata spiritualità personale permea tutto il poema, prendendo origine dalla molteplice formazione del suo autore. Quale fu il rapporto di Kazantzakis con Dio, la religione e la fede e come plasmò il suo alter-ego letterario?
Fin da piccolo, quando il padre lo mandò a studiare in una scuola religiosa cattolica nell’isola di Naxos, Kazantzakis avvertì fortissimo l’afflato religioso e spirituale. I preti cattolici segnalarono l’intelligenza precoce del ragazzo e la sua forte spiritualità a un cardinale in visita, che lo convocò e gli propose di proseguire gli studi in Vaticano per fare carriera fino a diventare anche lui cardinale. Quando il padre di Kazantzakis venne a saperlo, si affrettò a ritirare il figlio minacciando di dar fuoco alla scuola. Nondimeno il ragazzo conservò a lungo la sua forte spiritualità, tanto che per molto tempo pensò di farsi monaco. Ma un lungo viaggio nella repubblica monastica del Monte Athos lo deluse profondamente mettendolo di fronte all’uso distorto che alcuni monaci facevano della religione. Questo uso distorto e superstizioso della religione Kazantzakis lo mise alla berlina nel suo romanzo più famoso, Zorba il greco. Però lui non perse mai la sua forte spiritualità, che trasformò in uno spiritualismo radicale, e per tutta la vita andò alla ricerca di Dio. Questo spiritualismo lo trasferì in molte sue opere, compresa l’Odissea, e lo trasfuse perfino nel suo Ulisse. Basti pensare che nel poema la parola “Dio” ricorre più di 500 volte.
Prima di scrivere l’Odissea, Kazantzakis scrive un libello filosofico, Ascetica, che nella prima stesura reca come titolo I salvatori di Dio, in cui formula la sua visione del mondo e sostiene che non sono tanto gli uomini ad avere bisogno di Dio, quanto Dio ad avere bisogno degli uomini, e che essi saranno i suoi veri salvatori. Non sorprende che tutto ciò suonasse blasfemo nei primi decenni del secolo scorso, soprattutto in un paese culturalmente sottosviluppato com’era allora la Grecia. E infatti il poeta venne processato e condannato per ateismo, l’Odissea fu messa all’indice dalla Chiesa ortodossa, e quando nel 1957 Kazantzakis morì, fu vietata l’esposizione della sua salma nella cattedrale di Atene e la tumulazione in un cimitero cristiano. E il poeta, deluso, decise che sulla sua tomba disadorna sui bastioni veneziani di Creta, venisse scritto come epitaffio l’epigramma del filosofo Demonatte (II sec. d.C.): «Non spero niente. Non temo niente. Sono libero».
Nel XV canto Ulisse decide di fondare una Città Ideale (ispirata a Platone, Agostino, Tommaso Moro) che, appena costruita, viene distrutta da un cataclisma, inducendo Ulisse a pronunciare una feroce invettiva contro Dio, che non rispetta le opere dell’uomo. Anche se il mondo è ostile a oltranza, si può incidere perché sia all’altezza della Città, secondo Kazantzakis? O è inevitabile rinunciare?
Kazantzakis non conosceva la parola rinuncia, e per tutta la vita condusse una lotta solitaria e disperata in favore di un ideale di giustizia, per l’uguaglianza degli uomini e la loro liberazione dalla schiavitù. Nell’Odissea, Ulisse ingaggia battaglie contro forze preponderanti per liberare gli uomini dal giogo della schiavitù. E come il Mosè della Bibbia, a un certo punto si ritira su un monte per meditare sulla Città ideale che ha in mente di costruire. Quando scende ha chiaro in mente come deve essere questa città: Dio deve essere una fiamma che permea l’universo, e questa fiamma dovrà essere conservata nella Città, la quale sarà governata da leggi severe improntate alla giustizia, e in cui ognuno dovrà svolgere al meglio il proprio compito. Una di queste leggi impone che ciascun figlio debba superare in valore suo padre: in tal modo la società conoscerà un continuo miglioramento.
«Anima, la tua patria è sempre stata il viaggio!» esclama Ulisse nell’“elogio dell’infedeltà” (XVI canto). Dalla sua prima lettura giovanile ad oggi, dopo la convivenza intrinseca all’atto del tradurre, quale è stato il suo viaggio con Ulisse?
Nell’Odissea di Kazantzakis Ulisse è l’alter ego morale dello stesso Kazantzakis, che, come ho detto, gli trasfonde la sua visione del mondo e le sue convinzioni morali. La mia lunga convivenza con questo poema e con il suo autore è stata per me anche una lezione morale ed esistenziale, oltre che una splendida lezione di poesia. E mi ha insegnato, per usare una sua espressione, che esiste qualcosa di più vero della realtà: la fiaba. Perché la fiaba, dice Kazantzakis, «dà un senso immortale all’effimera verità». Seguendo il suo insegnamento, alla parola “fiaba” io ho sostituito la parola “poesia”, alla quale ho dedicato tutta la mia vita.
C’è nel poema una forza morale che lo rende immune al tempo e allo spazio – una sorta di educazione esistenziale di un uomo, di tutti gli uomini. È alla Virtù che Kazantzakis leva un appello nel XXII canto, perché non lasci morire Ulisse. Quale virtù salva l’uomo-Kazantzakis, l’uomo-Ulisse e quale può salvare l’uomo attuale?
Viviamo in un mondo sempre più dominato dall’avidità di denaro e di potere, un mondo inquinato, al pari della natura, dal disfacimento e dalla corruzione. E questo riguarda in modo particolare anche il nostro Paese e la sua classe politica. È un problema non solo nostro, ma globalmente diffuso, così come lo era al tempo in cui l’Odissea fu scritta. Perciò, in una delle parti più belle e toccanti del poema, nel momento in cui Ulisse si avvia al suo destino finale, Kazantzakis – questo poeta grande, immenso – per un momento si astrae dalla sua narrazione e leva un commovente appello alla Virtù, l’Aretè greca, che designa il valore spirituale e la capacità dell’uomo di assolvere bene al proprio dovere, scongiurandola di salvare Ulisse, il «faro luminoso», la «mente insonne e fervida», il «cervello fulgido e disperato», a cui il poeta ha affidato tutte le sue speranze per un mondo migliore. Esiste lezione morale più alta di questa?
Copertina: William Turner, 1829
