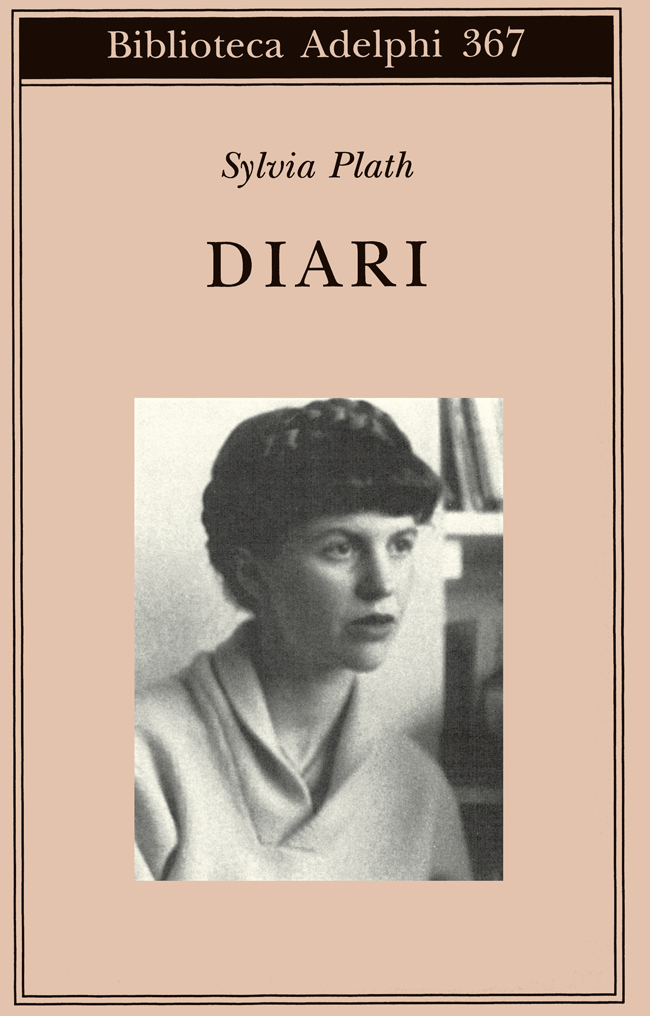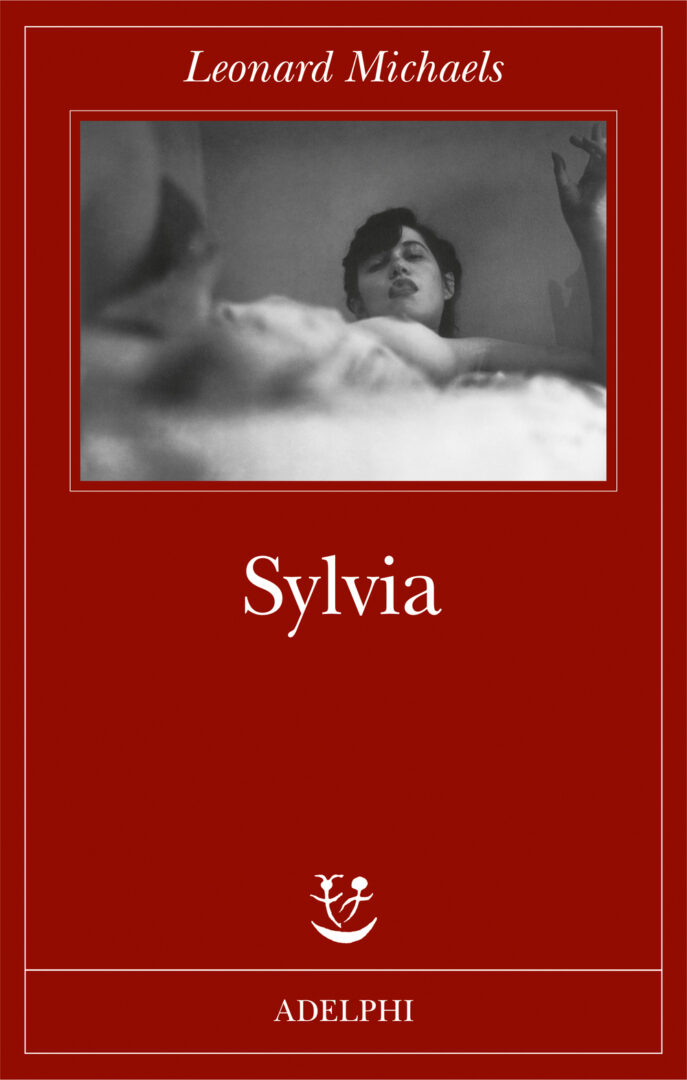Gli anni Novanta sono appena cominciati quando un giornalista, nonché la voce narrante del racconto, incontra una donna, Joséphine, che nel giro di pochissimo tempo diverrà fondamentale per il suo presente e futuro. La traccia del solco lasciato da questo incontro lungo tre anni, dal 7 ottobre 1990 al 26 marzo 1993, è il memoir Joséphine di Jean Rolin, uscito in Francia nel 1994 e portato ora in Italia da Quodlibet nella traduzione di Martina Cardelli.
Se i processi della memoria delimitano la felicità, Joséphine è un racconto purgato dalle macchie scure del male, che ottundono i ricordi solo quando sono più freschi, e che in queste pagine non intaccano l’intensità di un grande amore passato e la leggerezza rapsodica delle vite vissute tra gli anni Ottanta e primi Novanta, quando era ancora possibile perdersi nell’immediatezza del presente.

Sin dall’inizio, Joséphine mi è apparso come il risultato di tanti libri, e tante donne. Una lettura contestuale, il tassello aggiuntivo di un’unica macro narrazione, personalissima, che si accresce negli anni, per caso o per chiamata. (In verità, è così per ogni libro letto, apprezzato o meno, solo che per alcuni, e Joséphine è uno di questi, la fiumana in cui scorrono è impetuosa ed evidente. Se ne vede il principio, la direzione, difficilmente la fine).
Questa volta il contesto si è fatto avanti da sé, una realtà che si apparecchia in anteprima, per stupirci quando tardivamente ce ne accorgiamo. E così è accaduto che, subito dopo la lettura del memoir di Jean Rolin, rileggessi per l’ennesima volta Sylvia di Leonard Michaels (Adelphi, traduzione di Vincenzo Vergiani). Un libro letto, riletto tanti anni fa, che, anche in quella occasione – di nuovo le mani silenziose del destino – si è intrecciato a un altro diario che custodivo gelosamente: i Diari di Sylvia Plath. Subitaneamente, complice l’omonimia, le due Sylvie si sono sovrapposte, intrecciate, contaminate. Entrambe furenti, disperate, piegate su carte la notte e chiuse nelle mura universitarie di giorno, colme di un amore così viscerale da non poterlo sopportare, le due erano diventate una sola Sylvia, una strana Sylvia alla seconda (sarebbe divertente immaginarne i potenziati connotati fisici).
Un simile processo mimetico è avvenuto anche tra la Joséphine di Jean Rolin e la Sylvia di Leonard Micheals, sia per questioni sostanziali sia strutturali e formali che avvicinano le due opere.
A narrare è la voce di chi resta e chi resta è la parte maschile – e ci si chiede: egli sa cosa è l’abisso? «D’altra parte lui è costretto, evita tutte le possibilità di ritrovarsi faccia a faccia con la follia», scrive Joséphine nel suo diario il 28 aprile 1992.
La Storia la fanno i vinti e i sopravvissuti, ed è nella loro sopravvivenza che si trova la maggiore sciagura, perché la scoperta più crudele è rendersi conto che si può sopravvivere a tutto: alla fine di un amore, alla fine di una vita.
La storia di Joséphine non è la storia di Joséphine, è una storia diversa, di qualcun altro, solo parzialmente coincidente. Come la storia di Sylvia non è la storia di Sylvia. Leggiamo i residui dei moti della memoria personale, deformata e deformante. Queste due donne sono parvenze, prive di voce propria, quasi come ostaggi. La voce di Joséphine fa da corredo alla ricostruzione della vicenda solo quando sono riportati dal narratore i frammenti dei suoi quaderni – rari ma preziosi sprazzi, perché è proprio lì che ci si avvicina vertiginosamente alla verità, quando la scrittura è aderente, prende a tal punto il contorno delle cose che anche il tratto ne è coinvolto.
«Sul quaderno nero […] Joséphine – con una scrittura spesso noncurante delle regole grammaticali, ma talmente priva di dissimulazione, di malafede di affettazione, talmente vicina alla sorgente, che oggi mi appare di una bellezza incomparabile, così come quel suo modo di tracciare le lettere e di metterle in fila, ora, quando l’angoscia e il dolore erano insostenibili, quasi disorientato, esploso in tutte le direzioni fino a formare cerchi più o meno concentrici.»
Cos’è quindi reale? Una domanda di cui sappiamo la vanità ma che difficilmente smettiamo di porci, come sgorgasse da un bisogno necessario di incredulità. Ma è un sollievo rammentare che tutte le mancate risposte abbiano composto e continuino a comporre l’intera storia della letteratura. Fa lo stesso sottotraccia anche il narratore di Joséphine che formula la sua domanda in silenzio e ne permea la narrazione. Questa è la sua memoria, la sua versione di un amore, ma proprio forse in quanto amore – e cos’è poi l’amore? – a tratti le realtà coincidono. Tra le pagine del suo diario Joséphine lascia sue definizioni, desideri di amore, «raggiungiamo, credo, un tale livello di somiglianza che ci specchiamo l’uno nell’altra. Questa cosa mi dà le vertigini» e poi «provo a dare una definizione dell’amore: l’amore è la possibilità di dissimularsi in un altro, di dimenticare di esistere», parole più avanti confermate anche dalle impressioni del narratore «mi è sembrato di vedere l’ennesima prova del grado di trasparenza reciproca – di fusione? – al quale potevamo arrivare».
Citazioni che hanno chiamato sulla pagina in modo fulmineo un altro riferimento, questa volta cinematografico, Terrence Malick e il suo To the Wonder. Una magnifica narrazione sotto voce, ma non per questo meno potente, di un amore, quello tra Marina e Neil, che proprio per i toni eleganti e sussurrati si avvicina al tenore del racconto di Jean Rolin. Le immagini si sono ancora una volta sovrapposte, non si era più in qualche caffè parigino ma immersi nella vastità del Mont St. Michel. Due puntini, Marina e Neil, che camminano sulla baia tra il grigio fittissimo e il silenzio, rotto solo dallo scroscio della risacca. E allora la voce di Joséphine, che immagino calda, profonda, suadente, si mescola a quella di Marina, composta ed esitante, e all’unisono si accordano: «There is always this invisible something which ties us so tightly together. I love this feeling, even if it makes me cry sometimes. It so strong, this convinctiont hat i belong to you».
Io e te, tu ed io. Il resto scompare. Ci sono solo Joséphine e il suo narratore; per l’intera narrazione il resto degli uomini e delle donne sono parvenze marginali, sulla pagina fungono da comparse, fanno capolino ogni tanto, privi di nome, presentati solo da iniziali puntate. Quasi a voler compensare questa scarsità di vita umana, di pagina in pagina acquistano sempre più risalto vivifico le piante, gli animali che iniziano a dialogare con la vicenda amorosa. Il paesaggio, in particolare quello delle gite fuori porta – Dinard, La Rochelle, Saint-Martin-de-Ré – prende vita e le aiuole «sembravano lupi». Verso la conclusione, che coincide con la morte per overdose di Joséphine all’età di trentadue anni, le presenze animali diventano onnipresenti e così in qualche modo esaltano la solitudine elitaria della coppia, la vicinanza a una solitudine perenne, siglata dalla scomparsa di Joséphine, e rafforzano il cerchio magico che circonda gli amori più viscerali, quel limite invisibile ma quasi palpabile e invalicabile per chiunque altro.
Gli accenni al mondo vegetale e animale contribuiscono anche a enfatizzare una dimensione favolistica che spesso aleggia. Il libro comincia come un sogno – «Joséphine cammina con leggerezza, quasi in assenza di gravità» – e prosegue come tale. Si procede per frammenti e sospensioni e tutta la narrazione appare come un lungo unico viaggio fatto di singoli momenti dilatati – non importa dove si è ma solo il continuo galleggiare, smaterializzando la geografia, seppur costellata da indicazioni ben precise. Non ci si stupirebbe se la fauna delle ultime pagine a un certo punto prendesse parola e iniziasse a interloquire con i due amanti.
Si compone così un ricordo delicato, dalle tinte tenui, la cui sfumatura parte dai bordi e si dirama verso il centro pagina, intaccando ogni elemento verbale. Di questa leggerezza Joséphine ne è insieme foriera e vittima, pelle diafana capelli corvini, è un’immagine tanto vivifica quanto fantasmatica, complice la sua dipendenza dall’eroina: «Credo di non averla mia vista tanto bella e struggente, così leggera, e quasi imbarazzata da tanta leggerezza – come se persino quella leggerezza fosse troppo pesante da portare -, che sembrava sul punto di cadere, e allo stesso tempo pareva che un filo l’assicurasse ancora alla terra».
La vediamo quasi Joséphine, stampata su una polaroid, con la coda alta calze a maglia zaino e trucco pesante. La sua immagine si sdoppia, triplica. Si può moltiplicare all’infinito, perché la memoria del passato offre un inventario inesauribile e irreplicabile nella sua eterna replicabilità. Si può creare un mondo di ricordi e viverci dentro.
«Joséphine che mi viene incontro in rue Pastourelle (o un’altra strada), è in ritardo, accelera il passo, indossa una giacca col cappuccio, argentata, luccicante, una specie di tuta ignifuga che la fa somigliare a un folletto extraterrestre».
«Joséphine in gonna verde di lamé e body nero, il giorno del compleanno di M. C., poi, più tardi nella notte, avvolta nel suo soprabito di canguro azzurrognolo, sull’esplanade del Trocadéro, infine lungo l’avenue du Président-Wilson, giù verso il ponte dell’Alma, lontano da me (abbiamo litigato)».
«Joséphine in pantaloncini corti e camicia bianca – sempre con la collana di perle -, scarpe da tennis bianche ai piedi, seduta per terra, si abbraccia le ginocchia con un’espressione maliziosa, davanti alla “casa dei vetri” a Saln-de-Giraud, tra le vasche di decantazione».
Rievocare è un atto rassicurante, e ancor più lo diventa quando la memoria si cristallizza nella pagina scritta. Con quel fine, cioè quello di imprigionare l’esperienza, darle dei limiti visibili e dicibili, scrivere diventa una riduzione impossibile, un tentativo già perso in partenza, ma che nasconde un bisogno, quasi estetico, di ordine, di misura. Il bisogno di mettere parola, di provare a dare forma all’informe, al groviglio bestiale di immagini confuse, che fuoriesce da ogni fessura, viscoso e imprendibile come una macchia d’olio. Ma è lì, in quella fessura di scorrimento e di battaglia tra forme e informe, che a volte possono avvenire i piccoli miracoli. Quando non sarà la forma, la parola, ad avere la meglio, anzi essa verrà superata, vinta, e perderà ogni tipo di controllo sulla materia, e sarà lei stessa – la scrittura – che si inchina, si mette da parte al punto da diventare invisibile, fattasi essa stessa macchia d’olio.
Copertina: frame tratto dal film To the Wonder di Terrence Malick