«Sono un anziano, e custodisco la terra. Da ragazzo iniziai a essere consapevole della bellezza del mondo in cui vivevo. Era un mondo di colori intensi – canyon scarlatti e mese turchine, distese verdi e sabbie giallo-ocra, nuvole argentee, montagne che cambiavano dal nero all’antracite, dal porpora al grigio ferro. Era un mondo di enormi distanze. Il cielo era così profondo da non avere confini, e l’aria era attraversata da uno sfavillio di luce. Era un mondo in cui io ero vivo con tutto me stesso. Anche allora sapevo che mi apparteneva e che lo avrei custodito per sempre nel cuore.»
Inizia così L’alba, il capitolo uno di questo memoir spirituale di N. Scott Momaday, intitolato Custode della terra. Riflessioni sul paesaggio americano e pubblicato da Edizioni Black Coffee. Un titolo e un sottotitolo sui quali vale la pena fare una riflessione perché, come accade con la letteratura e la poesia nativa americana, la mediazione della lingua inglese svolge da oltre un secolo un ruolo fondamentale per provare il sentiero dell’empatia, prima ancora che dell’analisi, nell’avvicinare uno spirito così simbiotico con Madre Terra come il loro. Momaday, classe 1934, è autore del leggendario capolavoro Casa fatta di alba (ritradotto e ripubblicato lo scorso anno dallo stesso editore: qui l’ottimo intervento di Sara Reggiani sull’autore per Rai Cultura), il libro che nel 1969 vinse il Pulitzer perché in grado di fornirci una fotografia della condizione universale degli esseri umani, nativi americani e non, di fronte alla frantumazione dell’identità, alla guerra guerreggiata e alla guerra tra culture.
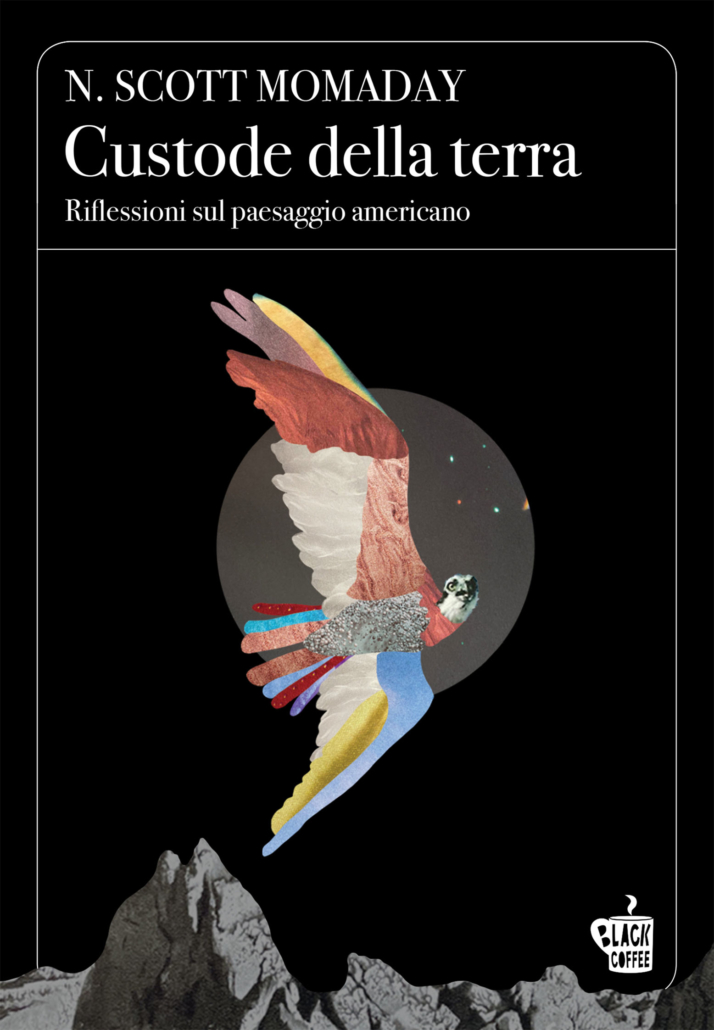
«Il crepuscolo scende sul tardo pomeriggio. Un tramonto fiammeggiante ha ceduto a un cielo d’argento antico che s’abbruna, i profili del paesaggio si ammorbidiscono e a malapena mandano un bagliore. È la fine dell’estate, c’è un tremito su foglie ed erba nella luce che affievolisce. A una vaga distanza un coyote si muove come la lenta ombra di un falco che si libra sulla lunga pianura. La terra riposa.»
Sono sempre stato attratto e mai più abbandonato da questo modo di “riflettere”. Fin da quando decenni fa conobbi e lavorai con Lance Henson, poeta Cheyenne tra i grandi della letteratura nativa contemporanea. Proprio traducendo il suo Tra il buio e la luce, conversando di poesia della Terra e di Terra poetica ebbi modo di entrare su quel sentiero che una volta camminato, non ti fa più girare indietro. La luce per Momaday arriva proprio alle sue spalle, dove si svolge quel presente continuo – passato e presente sono categorie nostre, non dei nativi americani – per farlo sentire saldamente a casa sua. Dove il compito di ognuno è essere earth keeper, custode della terra.
Leggere questo centinaio di pagine leggere come piume pronte al volo nel nostro spirito per arrivare a toccare il corpo intero da dentro, anche attraverso la mente, ci ricorda che la storia delle popolazioni indigene dell’intero pianeta, di giorno in giorno, torna a svelare una contemporaneità e un’urgenza senza precedenti. La consapevolezza del mondo rispetto all’impossibilità di proseguire con la scellerata flagellazione della Terra cresce di giorno in giorno. E come per ogni battaglia perduta, noi ci agitiamo provocando sempre più danni e immaginando soluzioni che in realtà accelerano la piena realizzazione del problema. Perché? Perché non siamo veri custodi della terra e non facciamo nessuna riflessione sul paesaggio – non nel senso di sentircene parte. Siamo ancora troppo positivisti, cartesiani, illuministi. Troppa analisi, poca percezione, conoscenza diretta ridotta ai minimi termini dai troppi numeri e dal poco sentire.
Eppure loro, i custodi della Terra, sono lì: dalle americhe all’artico, dal Pacifico all’Africa, dall’Asia all’Australia ci sono e rappresentano il nostro orizzonte. Con i loro valori, con il rifiuto di interpretare il rapporto con la Terra come un rapporto di proprietà materiale; con la loro spiritualità, la relazione privilegiata che ti fa conoscere i tratti e i contorni della geografia più intima dove si cela l’identità. Momaday scrive come se ci stesse raccontando intorno a un fuoco la propria vita non tanto e non solo per ricordarci che tutto è presente, ma per invitarci a non temere di avvicinarci a ciò che loro hanno sempre saputo. Vuole dirci che loro sono riusciti a salvaguardare lembi importanti di quella geografia intima, per trasformarla in una profondità che va oltre le epoche umane.
Cresciuto nelle riserve Navajo, Apache e Pueblo del sudovest statunitense, ha dedicato la sua lunga vita a essere una forma della (sua) terra. Ogni parola, come nella poetica più vasta che esiste, ha un senso. Non è utilizzata per titillare la ragione, ma per rappresentare un mondo. “Land” viene tradotto in italiano con “Paesaggio”, perché se Momaday sa di scrivere per un pubblico anglofono noi dobbiamo leggere da italiani. Non poteva usare “Landscape”, Momaday perché per ogni indigeno la “Terra” non è “scape” – “panorama, veduta” – bensì “terra; terraferma; terreno; paese; patria; suolo”. Quando ero tra gli Inuit sull’Isola di Baffin, “Land” era come mi parlavano dell’intera regione di ghiaccio (era inverno, la tundra artica era ricoperta di bianco): uscivamo insieme “on the land” perché quella Terra è patria e paese. Il suolo della propria identità, anche quando è ghiaccio. Qualcosa che non può essere disgiunto dall’individuo che compone la comunità per la quale terra, terraferma, terreno, paese, patria, suolo, non sono il luogo dell’individuo che ammira un “landscape”, il paesaggio come lo intendiamo noi e nel quale troviamo la nostra identità.

Per ogni nativo americano, aver trovato le parole significa aver reagito all’orrore dell’assimilazione pensata da Grant dopo la Guerra di Secessione quando Cavallo Pazzo e Toro Seduto erano i simboli della libertà e del linguaggio libero. Serviva allora capire e appropriarsi della lingua dell’invasore, come ha fatto esattamente la generazione dei Momaday, degli Henson, dei Trudell. Che sono riusciti a darci il senso di cosa è “land” per loro e di come dovrebbe essere per noi. Ecco perché non è stato certamente semplice scegliere di tradurre “land” con “paesaggio” (che noi pensiamo in termini di “landscape”), ma è efficace perché non si tratta di un’immagine fotografica, ma di un’identità. La curatrice di Custode della Terra, Laura Coltelli, nella sua preziosa e intensa introduzione scrive: «È un’idea etica della terra da cui prende le mosse un rapporto di reciproca appropriazione: l’uomo investe se stesso nel paesaggio e nello stesso tempo incorpora quel paesaggio dentro di sé».
Non a caso Momaday nella breve nota introduttiva, afferma: «Quando penso alla mia vita e alle vite dei miei antenati, sono inevitabilmente portato a convincermi che io, e loro, apparteniamo al paesaggio americano. Questa è una dichiarazione di appartenenza. Ed è un’offerta alla terra». Un modo anche per dirci che il paesaggio americano non è gli Stati Uniti, ma un continente variegato e molto più profondo e inafferrabile di quello conquistato con la violenza dagli europei secoli fa. È un libro di dettagli, questo, nel quale l’evento quotidiano – il falco che caccia una preda – diventa una cosmologia, perché non viene letto (come facciamo noi), analiticamente spiegando come avviene la caccia e perché. Per Momaday tutto avviene perché così è e in quell’evento tutta la vita – di lui che osserva e dell’uccello che preda – si apre all’universale tanto che l’importante è la chiusura in grado di farsi apertura al quotidiano che si ricrea: «Mi tengo stretta questa visione». Visione in cui si svolge, ininterrotto, lo spaziotempo della vita per ogni popolo indigeno, in quella dimensione che sta oltre le nostre, utilizzare nel nostro paradigma per capire un mondo che più analizziamo e meno comprendiamo perché una relazione di appartenenza non si spiega, si vive:
«L’albero sembrava morto. Ma molto tempo dopo sul tronco carbonizzato comparve il verde di un esile ramoscello, e poi la vita nascosta dell’albero eruppe in un centinaio di foglie. Fu una cosa prodigiosa e io nel vederla piansi. Penso che la terra infuse nell’albero la sua irrefrenabile forza. Come possiamo non esserne grati?»
