Siamo seduti in un anonimo cinema notturno di un quartiere modesto. La sala non é deserta ma neppure affollata, ci sono alcune ombre intorno a noi. Il buio è avvolgente ma interrotto da una lama di luce che si spande su un grande pannello nel centro, dove si susseguono immagini di volti, dai connotati ben scolpiti ma di vaga consistenza: ombre, come noi spettatori. In sottofondo sibilano voci, impercettibili ma costanti, e fruscii di vesti – forse gambe che si accavallano, si piegano in cerca della posizione più comoda.
Leggere James Purdy è una delle visioni cinematografiche più strane. È come guardare la stessa scena, sempre uguale ma sempre irrepetibile, dove non contano il quando, il dove, il chi. Contano solo i nostri occhi fissi nel tentativo di misurare ciò che è silenziosamente immisurabile.

Di James Purdy (1914-2009) possiamo leggere una ventina di romanzi, tantissimi racconti (in Italia negli ultimi anni grazie alle ripubblicazioni di Racconti edizioni) e circa una dozzina di testi teatrali.
Statunitense fino al midollo (nato nell’Ohio, vissuto a Brooklyn, morto nel New Jersey) è stato, come tanti altri, figlio poco amato dalla propria madrepatria. Ma se di fronte alla durezza del proprio genitore molti se ne sono andati lontano, nel continente Europa a cercare conferme in matrigne più gioviali e lungimiranti, Purdy è rimasto attaccato al proprio suolo, cantore cocciuto, una pulce nell’orecchio dei mastodontici e un po’sordastri Usa.
Le opere di James Purdy non sono mai classificabili, strattonano i limiti dei generi e ne recidono con taglio netto le trame di fratellanza. Impossibile rinchiuderle in un canone carcerario o in un trafiletto di quotidiano dal numero di battute stringato. In questa inclassificabilità risiede una delle cause del mancato successo letterario dell’autore americano. Ne è un esempio l’opinione di Susan Sontag, la quale, sebbene il suo giudizio letterario poco interessi a Purdy che la definisce priva di un «background» e di una «soul» per entrare nel suo mondo [1], individua tre alter-ego “purdiani”: lo scrittore satirico-fantastico, l’osservatore gentile della vita provinciale americana, il vignettista dal gusto orripilante che si compiace nel descrivere persone disperate pronte a distruggersi l’una con l’altra.
Ma per comprendere meglio la mancata fortuna editoriale di Purdy, bisogna guardare altrove, nel cuore delle sue opere, dove l’autore svela ciò che spesso le persone non vogliono vedere manifesto. Come scrive Jerome Charyn nella postfazione a Come in una tomba (Se edizioni, traduzione di Maria Pia Tosti Croce) Purdy «mette il dito sulla piaga, affronta le paure della nostra vita notturna, l’aritmetica scabrosa dei sogni». Rende visibili i nostri pensieri striscianti che celano viltà e indifferenze, ma che sanno essere anche la nostra grazia, il nostro marchio di creature umane, fatte non solo di carne e pensiero. Purdy sa guardare con precisione dentro gli anfratti più oscuri della psiche umana. Va alla ricerca della forza sovversiva e distruttiva che si nasconde dentro a ciascuno, e, dopo averla scovata, la porta a galla. È questo uno dei suoi più grandi meriti narrativi ma anche una delle sue più grandi sfortune editoriali. Un certo pubblico americano, la maggioranza, non solo non poteva comprendere quei personaggi e quelle storie, ma ne rimaneva spaventato se non indignato. «I’m a monster» ha detto di sé una volta James Purdy, in risposta a una domanda a cui l’autore – ostile all’etichettabile – non poteva che rispondere con una provocazione: «Are you a gay writer?».

Come si diceva, la produzione di Purdy è vasta e proficua, e, per quanto possa essere possibile rintracciare un fil rouge nella varietà tutta della sua opera, in questa sede ci si soffermerà sulla narrativa breve, a partire dalle recenti ripubblicazioni di Racconti edizioni.
È proprio nella breve battuta – lo spazio di poche pagine – che emergono macroscopici i caratteri abnormi della letteratura purdiana. Il senso della dismisura non si delinea in grandezza ma in incapacità di contenimento. La vertigine del troppo piccolo troppo grande; in quel troppo risiede l’abnorme, lo smisurato.
Le short stories di Purdy sono delle parabole fulminee, lungo le quali camminiamo temendo continuamente il pericolo di una improvvisa concavità. Generalmente in apertura regna una calma sospetta. Il cielo è ancora terso ma si teme una nube che ancora non si vede, come strascico tardivo di un temporale già avvenuto. Su ogni pagina vige l’incombenza di un indefinito elemento disturbante il cui presagio non permette mai un affidamento totale. Ma l’assurdo raggiunge i lettori in sordina. Delle schegge si infilano tra i personaggi, fendono l’aria e creano squarci tanto profondi quanto invisibili. A quel punto la tensione si genera nell’aria e i dialoghi diventano serrati, con uno scambio di battute che si muove su più livelli. Le conversazioni procedono in linea orizzontale ma con un leggero e continuo smottamento verso il basso, in direzione di una materia più profonda, un mistero che i personaggi costeggiano, sempre solo intravvedendolo.
« “Che cosa c’è adesso, piccolo Judd?” Udì la sua voce contro la porta chiusa.
“Ho sparato all’uomo della sabbia e l’ho ucciso” rispose il piccolo Judd. “È tutto coperto di acquarelli e di mosche, e l’ho ucciso io.”
“Ora cerca di dormire un po’.”» [2]
Gli attori si avvicinano al mare nero ma poi indietreggiano, come incapaci di sopportare una visione troppo indecente, volteggiando in una danza di parole logorante, in cui tutto sembra poter essere possibile ma niente in verità accade.
Ed è proprio questo quello che succede nei libri di Purdy: l’incubo avviene, è gia avvenuto, ma niente è cambiato. Si tenta di squarciare il velo del consueto con una realtà violenta, come può essere violenta la vista da parte di una madre della barba troppo nera troppo lunga del figlio ritornato da New York. L’impalcatura cade, si spacca, ma poi magicamente si ricompone, come fatta di piastrine solerti pronte a richiudere le ferite e non lasciare cicatrici. La normalità è intoccabile, il decoro un sacramento.
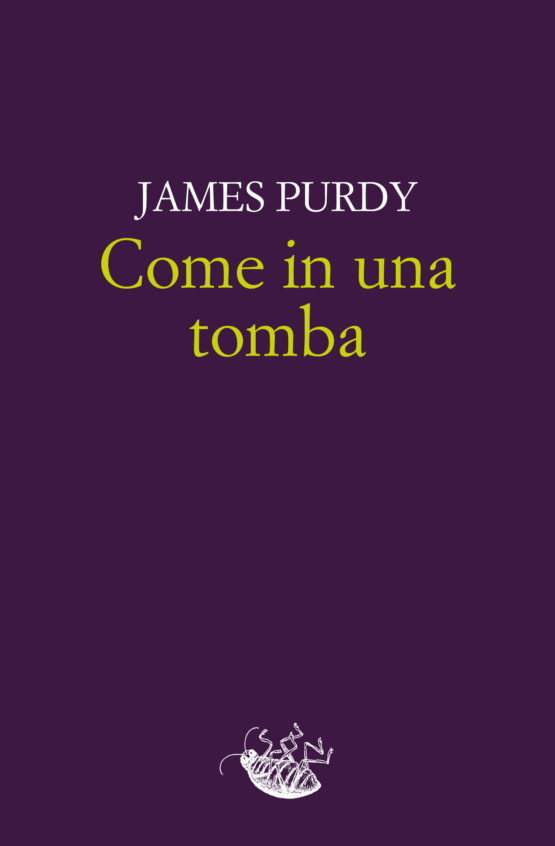
Cosa c’è allora di più violento di una tragedia consumata in sordina all’interno delle mura domestiche? Le ambientazioni predilette per le acri vicende purdiane sono i luoghi chiusi.
Storie claustrofobiche; ma ciò che crea repulsione rimanda attrazione. E i personaggi, pur inalando l’atmosfera nociva delle loro case, appena tentano un passo all’esterno, sono subito richiamati dalle catene alle loro caviglie che tintinnano e li costringono alla trappola del dentro. Ogni movimento verso il fuori o non avrà successo, o, se avverrà, avrà conseguenze nefaste, come quando, nel racconto lungo 63: Palazzo del sogno, Fenton si decide a lasciare la catapecchia abbandonata in cui vive con il fratello minore Claire per un’esistenza più dignitosa. Ne sconta poi il salato prezzo con l’omicidio per propria mano del fratellino. «Preferirei morire piuttosto che andare là», aveva sentenziato funestamente Claire alle insistenze di Fenton per un possibile trasferimento.
Svariate sono le scene in cui i personaggi sono presentati in piedi uno di fronte all’altro, fermi nel tentativo infinito di muovere un passo, senza mai riuscire a spostarsi, come nel racconto La lezione [3]quando in una piscina la sedicenne Polly ha una discussione su un argomento di poco valore con l’istruttore di nuoto, Mr Dhiel. Da un innocuo fraintendimento si genera repentinamente un vortice di tensione, emotiva e sensuale, cha fa scordare il futile motivo della discussione e paralizza i due personaggi: «“Me ne vado, Mr Dhiel” disse lei, ma non si mosse, e lui sapeva da come aveva parlato che non sarebbe andata via. Avrebbero continuato a discutere, lo sapeva.»
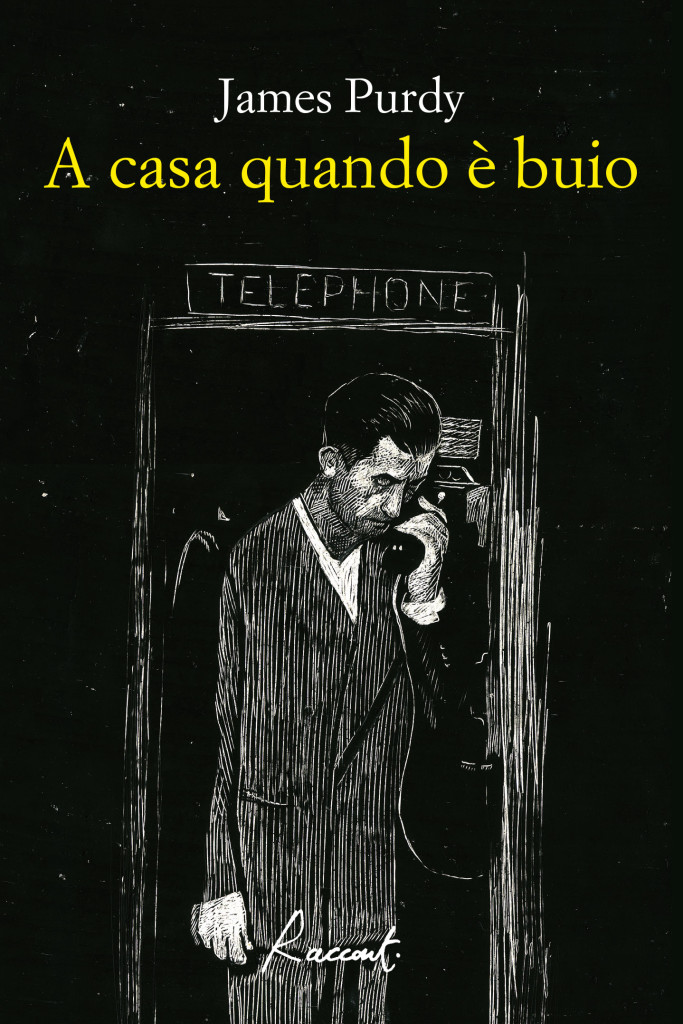
I personaggi sono come vittime, agite da quella forza sovversiva di cui si parlava in precedenza, che l’autore è in grado di individuare e di mettere al centro delle sue storie, pur senza mai mostrarcene il volto. D’altronde è molto più spaventoso e terribile ciò che sappiamo essere nascosto sotto il tappeto ma non osiamo guardare, rispetto all’atrocità esibita. Nel presentare un orizzonte possibile di sovvertimento, tanto allucinante quanto pacato, il tratto di Purdy ricorda quello kafkiano. L’autore opera un processo di “restringimento di campo”, cioè la sottrazione di parti della coscienza dei personaggi [4]. Si crea così nel lettore un effetto di straniamento di fronte alla muta accettazione acritica di realtà immonde.
«Uno alla volta ci sedemmo lentamente al tavolo con i nostri boccali davanti e, meraviglia delle meraviglie, Daventry chiuse gli occhi e cominciò a salmodiare. Il labbro inferiore mi tremava così forte che dovetti tenerlo fermo con le dita.
Stavo per dire: “Tanto meglio se ci buttano fuori” ma era troppo tardi.
Vidi il coltello, e vidi il suo petto nudo senza la camicia che era sparita. […]
Non lo vidi esattamente nell’atto di colpirsi, ma vidi il sangue prima sgorgare e poi schizzare su tutto il tavolo mentre lui si dominava tanto da riempire ciascun boccale col fiotto di sangue che zampillava. Quintus si abbandonò all’indietro sulla sedia e le sue braccia si afflosciarono quasi fossero di paglia.
Ma ogni boccale era ormai colmo di sangue e vino, e l’espressione del viso di Daventry era così terrificante, e il coltello ancora brandito dalla mano sinistra così minaccioso che non restava da fare nient’altro, quando disse “Bevete”, che ingoiare, e naturalmente ero convinto che stesse per ucciderci, e benché tremassi come una piccola quaglia quando la strappano dal nido ero pronto a qualunque cosa ci avesse riservato; Daventry era, penso, la persona che avevo sempre cercato, che mi avrebbe reso ubbidiente, certo era arrivato troppo tardi, ma se era lui che doveva condurmi fuori dalle incertezze e angosce nel regno a venire, tanto meglio.»[5]
Come sonnambuli, i personaggi sono distanti dalle proprie tragedie, anche quando queste accadono sotto il loro sguardo. Contribuiscono ad accentuare il distacco emotivo le frequenti precisazioni del narratore circa le voci atone dei personaggi, spesso in contrato con un contesto che non giustifica la patina letargica: «con il tono assonnato e senza espressione», «con una voce privata di ogni espressività», «con aria assonnata», «disse Polly senza espressione, ripetendo le sue parole con aria sonnolenta».
La letargia intacca anche la lingua, che si fa banalizzata, opacizzata. Resa ancora più pragmatica dalla ricorrenza martellante di parole ordinarie, la cui iterazione svuota di senso e di eccezionalità l’assurdo e lo rende ovvio. Come i personaggi girano intorno a se stessi, così fa la lingua, nella creazione di vortici immobili. Il verbo, come le vite in scena, è vittima del decoro – tra i grandi imputati del tribunale di Purdy – che soffoca ogni voce fuori posto, fuori norma: «ma i suoi pensieri erano molto più violenti di quanto trapelasse dalle sue parole» (da Buonanotte tesoro in Non chiamarmi col mio nome). Le parole sembrano sfuggire ai personaggi, che frugano, frugano ma quella che poi arriva alla lingua è una parola così banale da risultare indecente. Non ci sono chiavi né per accedere all’interiorità dei personaggi né al mistero del reale.
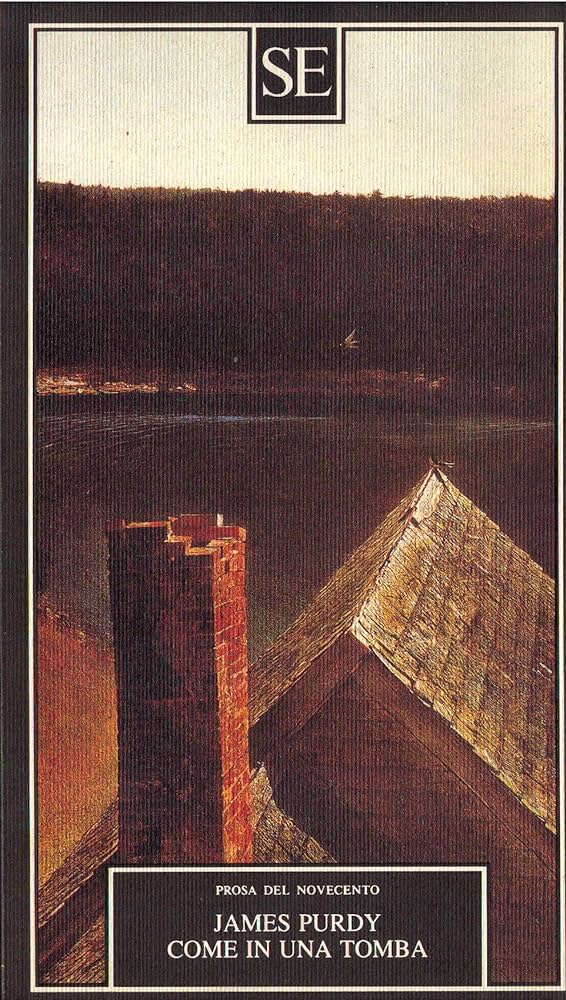
Entriamo allora per capovolgimento in una dimensione di mistero, alla quale la volontà di ragione e spiegazione non hanno accesso. Un segreto che si nasconde sotto il decoro borghese o sotto gli stracci dei più miserabili. Tra la ricca signora borghese di mezza età, imbellettata ma non bella – uno dei “tipi” più ricorrenti nelle opere di Purdy – e l’emarginato che vive ai confini della società, da una parte ammirato come fenomeno da baraccone, un freak alla cui vista i ricchi si sollazzano, ma dall’altra irrevocabilmente escluso dai salotti, non corre grande differenza. Nel rappresentare personaggi tra loro così distanti ma così vicini nell’essere tutti schiacciati da un sistema creato dall’uomo per l’uomo, che si è rivelato tanto nocivo e perverso da diventare penosamente ridicolo, James Purdy manifesta tutta l’umanità della sua scrittura. Purdy sta dalla parte dell’uomo, il più misero, forse anche il più nefasto, che può solo accettare una realtà che pare non possa più essere cambiata, soltanto peggiorata, limitandosi a respirare saltuariamente sprazzi di libertà, a contatto con una dimensione altra, di grazia. Sono momenti in cui il mondo è lasciato fuori e, rimasti spogli, si può dare ascolto a istinti profondi, amare «come un bambino pazzo ama la fiamma e il fuoco»[6]. Come le notti in cui Garnet esce di nascosto dalla propria casa per recarsi in una vecchia sala da ballo diroccata in mezzo al bosco. Come in un sogno – o come in una tomba -, lo vediamo ballare di fronte a noi, goffamente con le braccia all’aria, gli occhi chiusi e un sorriso incosciente. È il suo piccolo segreto, la sua ombra di felicità.
Copertina: James Purdy, 1957. Photo by Carl Van Vechten Collection / Getty Images
[1][1] Per l’opinione di James Purdy su Susan Sontag si rimanda a queste parole dell’autore:
«One of the apostles of the anesthetic way of life, Susan Sontag, said of The Nephew, “Itisdangerouslyclose to sentimentality,” meaningthatlikemost New York critics, shecouldnotenterintothis American experience. Butactuallywhatshewassayingwasthatany book whichdemanded an emotionalresponse from herwastaboo. “I willnotfeel.” That’s the Susan Sontag syndrome. “I willnotfeel. I don’twant to feel, becausethat’ssentimental.” There’sreallynothingwrong with sentimentality. But the book isnotsentimental. Becausenothing I wroteissentimental. Mindyou, I don’tdislikeher or likeher. I just ampointing out thathercommentsaboutmy work are completelyirrelevant, becauseshedoesn’thave the soul and background to enterintomy world. She’sirrelevant and typical of the period.»
[2] Dormi bene in La fiamma dei tuoi occhi
[3] A casa quando è buio
[4]Lo scrittore come animale di Pietro Citati su Linus, n.07, luglio 2023.
[5] Da Come in una tomba, SE edizioni, traduzione di Maria Pia Tosti Croce.
[6]Ibidem
