Raccontare una generazione e nello specifico la propria è un’ambizione che pervade da tempo la letteratura italiana contemporanea, in particolare quella degli ultimi dieci anni. Un movimento che s’incrocia con il tentativo diciamo neo-vittoriano di dare forma ad un grande romanzo italiano.
Della generazione degli attuali quarantenni (o quasi) spicca tra i primi a provarci Paolo Di Paolo, che nel 2011 pubblica il suo secondo romanzo Dove eravate tutti, un testo con una non banale impronta politica che affronta gli anni Novanta e la fine della Prima Repubblica. Seguirà nel 2019, dopo Una storia quasi solo d’amore, il più intimo e famigliare Lontano dagli occhi. Di Paolo si rifà a una narrativa autoriale, ma al tempo stesso popolare. Un fragile equilibrio che sulle orme di Tabucchi e in parte anche di Moravia prova a far convivere sulla medesima pagina storia pubblica e politica con la vita famigliare: elementi che spesso in Italia appaiono quasi indistinguibili.
Lo sforzo di Di Paolo è in parte eroico, perché non è affatto semplice dare oggi forma a ciò che appare sempre più un indistinto, ma senza mai sopravalutare una frammentazione politica ed emotiva spesso imperscrutabile. Ed è forse proprio in questa sfiducia nella frattura del contemporaneo che Di Paolo lascia il segno. Una sfiducia che non ha origine nell’incapacità o nella volontà di evitare lo sgretolamento sociale e in parte umano della società, ma nella sua possibilità di produrre realmente uno stile o meglio una possibilità letteraria.
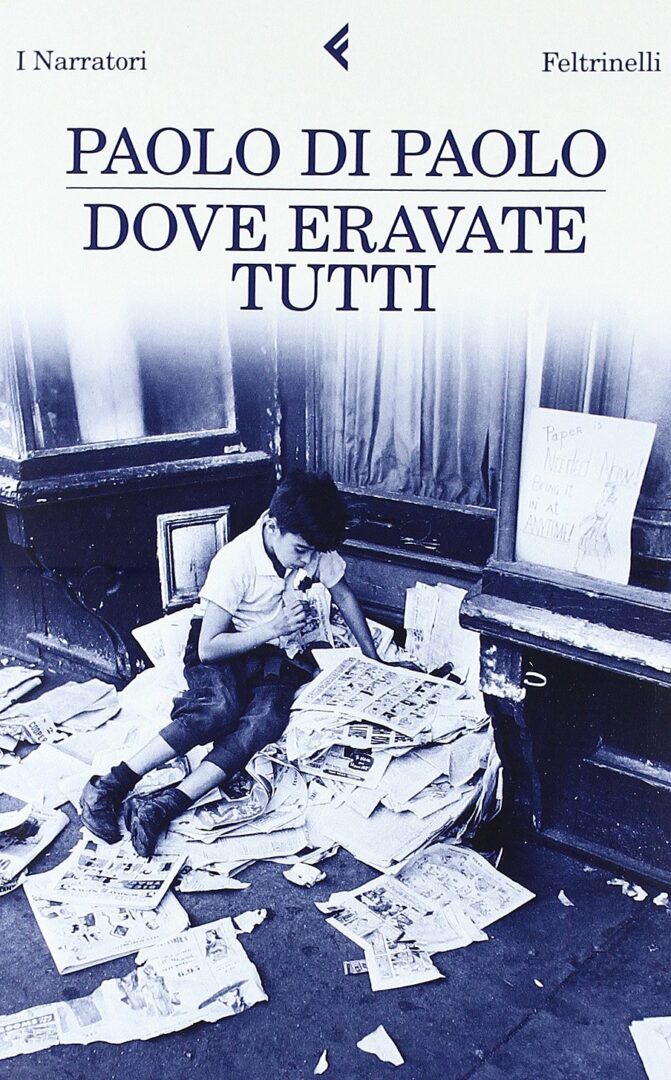
E se Di Paolo appare così scrutare l’orizzonte come un novello Giovanni Drogo che dalla Fortezza Bastiani in forma di un passato Novecento attende le promesse che tardano ad arrivare dal terzo millennio, così – quasi all’opposto – Francesco Pacifico, in particolare con il romanzo Class del 2014, spinge sull’acceleratore di un tempo che può bastare a se stesso. Pacifico con le sue vite di infelici romani in fuga dalla capitale in direzione New York disegna il ritratto di una borghesia che può dare forma ai suoi desideri solo limitando il campo di gioco. Non resta in sostanza che prendere quanto lasciato in eredità, perché proprio l’eredità è l’unica vera certezza per una generazione che si trova senza nulla tra le mani se non l’ombra delle cose già perse per strada.
Di Paolo e Pacifico sono due opposti eccellenti di un discorso generazionale che per forza di cose sconta un aspetto didascalico che è comunque voluto e in parte inseguito dagli autori perché della generazione dei quarantenni quello che manca prima ancora della storia è un tessuto testuale su cui connetterlo, manca – traslando George Steiner – una vera presenza, l’esserci.
Un’assenza di spazio che è assenza totale del campo di gioco e quindi della contesa stessa. Una mancanza che all’inizio proveniva solo dall’alto di un secolo che chiudendosi nel crollo del Muro di Berlino e delle Torri Gemelle rifiutava ogni forma di storia futura, mentre poi si è tramutata in una vera e propria compressione tra un passato remoto impalpabile e un futuro breve che può lasciare indubbiamente anche senza fiato.

Nonostante il tempo sia passato, quello che sta alle spalle è ancora quasi del tutto invisibile e irriconoscibile ed è su questi frammenti di una vera e propria archeologia contemporanea a tratti terribilmente tragica che prova ad agire come un defibrillatore Mario Desiati con il suo nuovo romanzo Spatriati (Einaudi, 2021). Costruito all’interno di una dicotomia che vede alternarsi maschile e femminile nella forma dei due protagonisti Francesco e Claudia, Spatriati indaga partendo da Martina Franca fino all’Europa della mitologia degli anni 2000 di Londra e Berlino, dal liceo in provincia fino alla vita adulta in città, il tempo che sembra più che invecchiare impolverare la testa di chi vive perennemente alla ricerca di una vita che rivela anno dopo anno – nonostante gli incroci che inevitabilmente propone – l’esclusione da ogni passione possibile.
La lingua di Desiati mischia con abilità il senso di un sud solare ed espanso (quello che viene dal pensiero meridiano di Franco Cassano) che si oppone più che al grigiore banale di un nord industrializzato, al colore chimico di un’urbanità priva di tempo e quindi di gusto che prova a giocare a carte scoperte con il mondo globalizzato, ma si ritrova come in un incantesimo nuovamente e inevitabilmente provincia.
Si potrebbe pensare che Spatriati, in quanto romanzo di una generazione che a quarant’anni ha già vissuto le ossa rotte di Genova (e una traumatica e cocente delusione politica), la crisi economica del 2008 e una pandemia tutt’ora in corso, sia più semplicemente l’amara vicenda di una sconfitta peraltro ancora ben lungi dall’essersi conclusa. In verità, la sconfitta si rivela al momento l’unica salvezza possibile. O meglio l’unica immagine comune e quindi lo spazio sensibile dentro al quale potere veramente esistere.
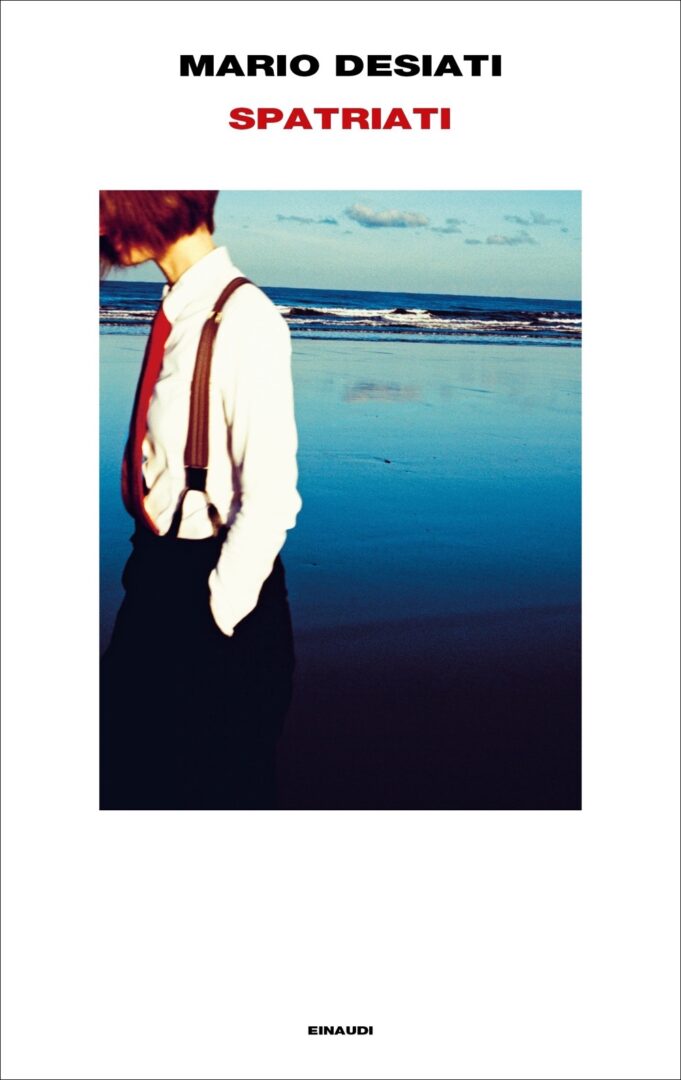
Mario Desiati agisce – è il caso di dirlo con precisione – con vera sapienza narrativa, nel muovere i suoi due personaggi all’interno di uno scacchiere famigliare totalmente esploso. Spatriati agisce infatti come una continua rincorsa all’esperienza e alla vita in generale, sapendo che sarà sempre in ogni caso una possibilità che può durare poco, o peggio ancora facilmente assimilabile ad una triste parodia dell’aver vissuto, retorica del bel tempo che fu.
Così per Claudia e Francesco è stato ed è l’amore, la fede, la fuga e pure la vacanza. Il dramma, la tragedia stessa, si contiene all’interno di categorie facilmente selezionabili, come un catalogo inebria nella sua contemplazione, ma che inevitabilmente consegna il suo lettore alla perdita di senso. Una confusione perenne tra presente e contemporaneo che lascia sul campo l’impossibilità anche del rimpianto e della nostalgia se non nella forma sterile di una ricostruzione post.
La scrittura di Desiati vive nel segno del coraggio, ma il suo strenuo tentativo di dare forma a una storia, e di conseguenza a una memoria anche collettiva, si infrange contro gli stessi stilemi di un tempo che lui ben conosce e che non è possibile in questo modo evitare. Come una barca con la vela strappata, Spatriati si spezza contro gli scogli di un’assenza collettiva e anche ideologica, che priva i suoi protagonisti come chiunque faccia parte di questa generazione di un discorso comune, di una lingua intima e quindi comprensibile al prossimo, a chi è distante.
Si avverte così l’incedere di una narrazione pratica e svelta che si distacca dalla materia sensibile della storia proprio per trovare quasi ossessivamente il modo di dare forma alla storia. Non si tratta però – sia chiaro – di un’occasione mancata: Spatriati è infatti un romanzo anche potente ed emotivamente coinvolgente, ma è obbligato a volare troppo vicino a un dolore che sta tutto nell’indicibile e di conseguenza in parte non può che bruciarsi le ali.
Desiati è ben al di là – per dirla con Walter Siti – dalla letteratura del bene e ancor meno gli appartiene l’idea di una letteratura a tesi, ma ne sconta in parte i medesimi limiti perché pare che solo all’interno di un format che anche Spatriati propone, sembra resistere la possibilità generazionale oggi. E forse non è un caso che di fronte all’indicibile di una generazione in crisi (perenne) a reagire sembrano essere più gli autori (si pensi anche all’imponente Prima di noi di Giorgio Fontana) che non le autrici, che paiono invece capaci di costruire nuovi immaginari tramutando il limite in un’occasione di visione inedita pur utilizzando i medesimi frammenti e gli stessi residui. In particolare penso a Veronica Raimo con Miden, a Claudia Durastanti con La straniera, per arrivare fino ad Ester Armanino con il sorprendente Contare le sedie, che proprio sulla frattura lavora ostinatamente, e a Teresa Ciabatti, che ha sviluppato romanzo dopo romanzo una vera e propria lingua nativa resistente al passato, al punto da poter definire un tempo contemporaneo in cui sia possibile ancora raccontare chi si è e cosa si è vissuto.
Spatriati lotta in ogni caso nella mischia: cercando la storia dove non esiste più, e questo è un merito non da poco, inseguendo le origini dove non sono più distinguibili, e con l’ausilio di due personaggi imprevedibili e comuni al tempo stesso restituisce al lettore l’idea romantica e perduta di una possibilità che proprio perché mai data diviene oggi epica. Un romanzo, infine, che dal quotidiano estrae la leggerezza donchisciottesca di un’illusione perenne e come tale sostanziale e quindi generazionale. Noi c’eravamo, anche se nessuno (di noi) se lo ricorda o lo sa ricordare.
In copertina: Nigel Van Wieck, Walking the Dog
