Un treno, un caldo asfissiante, afoso a un punto tale da rendere tutto sfumato: l’immagine è quella di una pianura, c’è una stazione che «grava come un colosso» su di essa, la ghiaia che luccica tanto da «ferire gli occhi». Arriva un treno, sopraggiunge a «dare una gomitata alla comunità sonnacchiosa», ci sono due figure zoomorfe, due vecchie che sono diventate «passeri su un filo del telefono». La veduta di Dagerman è concreta, sensoriale, se ne sente l’odore inspirando forte, la si percepisce sotto le proprie mani mentre si è comodamente seduti in poltrona.
Ma poi d’improvviso apro gli occhi, mi guardo attorno. Niente di quanto ho immaginato era reale: ho aperto gli occhi, non percepisco più quel caldo, sono a casa mia e sto solo leggendo l’incipit de Il serpente di Stig Dagerman.
In Italia grazie a Iperborea (2021), l’opera, scritta e pubblicata per la prima volta nel 1945, è il libro d’esordio dell’autore di culto svedese. E considerando la morte da suicida che avviene nel 1954, il tempo che Dagerman ha avuto a disposizione per dare luce alle proprie parole non è poi molto. Eppure c’è quel tanto che basta per rendere l’autore indimenticabile, letto, tradotto e apprezzato in tutto il mondo. C’è un motivo se attorno a Matteo Bordone, si sono stretti Antonio Brizioli, Elisabetta Bucciarelli, Fulvio Ferrari, Giorgio Fontana, Valeria Parrella, Marco Peano e Vanni Santoni per dare vita a Raccontami Stig Dagerman, podcast prodotto da Iperborea con il sostegno di Creative Europe in occasione del lancio dell’opera.
Fin dall’attacco pare evidente come la lingua abbia un gusto nettamente diverso, caratterizzato da una figuratività insolita e marcatissima che fa sì che tutto valga come la cosa in sé ma anche come altro da sé. Le metafore non indicano solo connessioni ma altri modi di essere degli oggetti che affollano le pagine. D’altra parte, forse questo è anche il motivo per cui la narrativa di Iperborea ammalia così fortemente i propri lettori più fidati: strettamente legata a immaginari talmente differenti, influenzata da culture tanto distanti da quelle d’abitudine che gli stili generati presentano tratti introvabili persino nelle opere nostrane più ardite.
Dal fascino linguistico indubbio, caratterizzato da un’evocatività unica e che rende la scrittura davvero indimenticabile (tanto più se lo si valuta come l’esordio di un ventiduenne), esperienza curiosa è avvicendarsi per la sua trama.
Ma di quale intreccio unitario si vuole parlare se non si è neanche sicuri di avere di fronte un romanzo? Fulvio Ferrari, traduttore dell’opera, nella postfazione pone il legittimo quesito che probabilmente ogni lettore ha nella propria testa a opera conclusa ma che, come Ferrari asserisce forse provocatoriamente, i critici letterari nel 1945 non si sono posti: ma si deve parlare dei titoli nell’indice come di racconti o come di capitoli di un romanzo? Il punto di vista cambia velocemente, talvolta c’è una narrazione in prima persona e talaltra no; in alcune zone si coglie il legame in maniera più o meno evidente tra le varie parti, ma tante altre il collante rimane oscuro. La struttura lo rende nei fatti impossibile da catalogare, un ibrido, con tante altre opere del Novecento sue compagne.
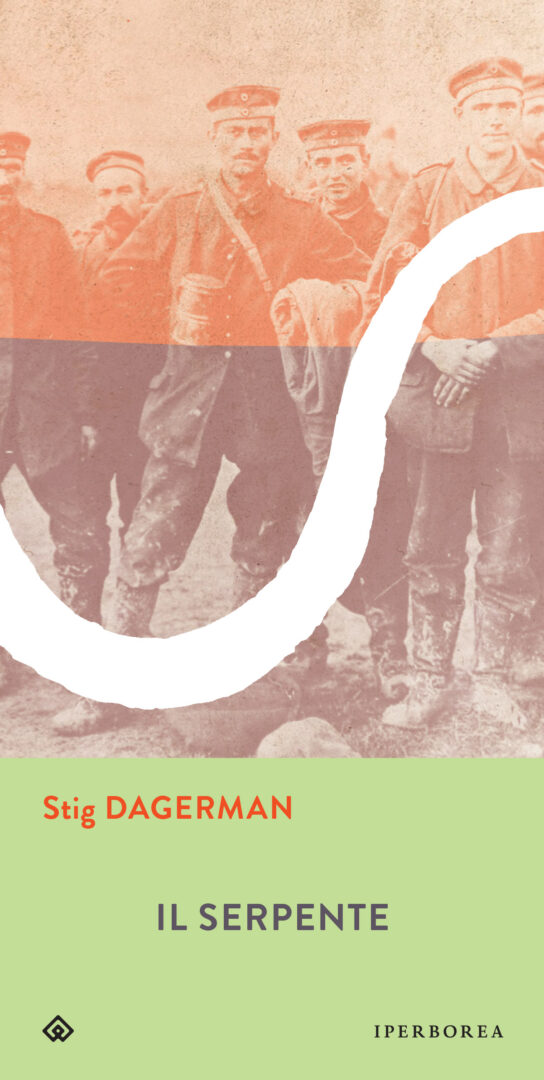
Si è accostato Dagerman a Kafka e Camus a buona ragione: quanto inizialmente appare delineato in maniera chiara e concreta può accadere che spiri gradualmente nell’indeterminato e nell’incerto. Nella prima sezione l’inquietudine prende lentamente il sopravvento, in un vortice di accadimenti violenti e confusi. Poi ritorna la calma. C’è l’immagine di otto soldati che, a turno, si raccontano delle storie a causa della difficoltà a dormire: sono uniti dall’esperienza e lo sono ancor di più grazie alle narrazioni. Qui, in questi racconti di secondo grado, l’abominio della guerra spicca con tutta la sua violenza, ma la realtà che si vedrà in questa seconda sezione, per il resto, sarà un’altra: una verità scomoda, che niente ha a che vedere con la solita propaganda. E cioè che la vita militare è una noia mortale. Che è composta da tante piccole occupazioni senza senso, che si ripetono all’infinito pur di far vedere agli altri che si è impegnati in qualcosa, che non si sta con le mani in mano.
Il serpente, in questo mondo caotico, è il legame che tiene insieme tutto: un animale che si fa spazio piano, silenzioso, che serpeggia tra le pagine proseguendo su un suo proprio percorso, parallelo a quello che compie il lettore attraverso le parole di Dagerman.
«Il serpente, il serpente, il serpente: questo gli passò per la testa, un pensiero infuocato, oppressivo, e tutto il resto sparì, esisteva solo il corpo del serpente, che andava sempre più ingrossandosi».
L’animale rappresenta quanto di più umano esista: la condizione di paura e di terrore perenne con cui ognuno è costretto a convivere, parte integrante del suo stesso essere, inscindibile dalla specie.
«Poi arriva un giorno in cui un serpente sparisce da una stanza. Ci si dispera, lo si cerca, ma non si riesce a trovarlo. Cosa bisogna fare? Allora si capisce che la paura è una malattia che è sempre lì, latente, che cerca di strisciare lungo i più sottili filamenti della coscienza e li punzecchia finché si scaldano e bruciano […] la tragedia dell’uomo contemporaneo è che non ha più il coraggio di avere paura. È una sciagura, perché ne consegue che deve poi anche smettere di pensare.»
Il ruolo dello scrittore e del poeta, in tutto questo caos terrorizzante, non è quello di consolare, alleviare: non è quello di «tranquillizzare, costruire frangiflutti», ma di «inquietare, abbattere argini». E per quanto sia errato e forse anche riprovevole romanticizzare il suicidio di un artista, resta impossibile non pensare che forse Stig Dagerman sia arrivato alle profondità, alle radici più recondite di questa angoscia, abbia tentato di tener fede a quello che egli giudica essere lo scopo della scrittura e che non sia più riuscito a risalire.
