Quando, in passato, mi è capitato di riflettere sul rapporto tra musica e droga, mi sono sempre tornate in mente quelle pagine del terzo libro della Repubblica lette al liceo, in cui Platone parla della musica e della poesia come di arti nocive alla paideia, ossia all’educazione dei fanciulli futuri cittadini di una società perfetta perché ispirata dalla visione iperuranica, ultra-sensibile, delle idee di giustizia, bellezza, verità.
Platone non tratta ovviamente di un eventuale rapporto tra musica e droga – anche se stupefacenti naturali esistevano già nel quarto secolo avanti Cristo, probabilmente usati nei riti iniziatici che si svolgevano a Eleusi, i cosiddetti “misteri eleusini” – ma parla della musica stessa come di una droga.
Questo resta, a mio avviso, un punto fondamentale, se non si vuole analizzare la questione secondo “canoni” banali, costruiti sul connubio tra rock e trasgressione e corroborati dalla ricca aneddotica relativa alle vite eccessive e fragili di Brian Jones e Jim Morrison, di Janis Joplin e Jimy Hendrix, di Kurt Cobain e Amy Winehouse, componenti del cosiddetto “Twenty Seven Club”, immaginario circolo a cui vengono associate le rockstar morte per overdose ancora molto giovani, a soli ventisette anni.
Punto fondamentale perché, se è vero che la musica agisce come una droga, il suo legarsi agli stupefacenti risulta allora artificioso se non posticcio, a meno di supporre che non sempre chi l’ascolta o anche la compone ed esegue a livelli sublimi come i succitati artisti riesce a coglierne lo stupefacente “naturale”.
Ma ciò premesso, da cosa deriverebbe il potere inebriante della musica, nefasta influenza che, secondo Platone, potrebbe sedurre o persino corrompere le giovani anime?
Fino a una decina d’anni fa – quando del rapporto tra musica e umano non avevo ancora colto tutta l’estensione – avrei risposto a questa domanda in modo colto ma insufficiente tirando in ballo Dioniso, la divinità greca del pathos e dell’ebbrezza, della danza e della possessione maniacale. Per Platone divinità ispiratrice di culti e miti che avrebbero minato le fondamenta della “Repubblica”, società giusta in cui il potere sarebbe stato democraticamente suddiviso sotto la guida illuminata dei custodi della ratio filosofica.
L’opera di Platone racconta infatti, nel suo insieme, di un’aspirazione enorme, ossia quella di trasformare la “comunità del mito” in “società del logos”, dove logos è quella nuova sapienza in grado di estromettere o quantomeno controllare il pathos che la musica, appunto, pericolosamente rimette in circolo.
Lo stesso passaggio inaugurato da Platone dalla filosofia come atto di parola a pratica di scrittura, è passaggio da una comunicazione veicolata anche dal corpo a una comunicazione quasi esclusivamente mentale.
In tal senso non è sbagliato riconoscere nel logos organizzato che oggi governa il mondo tramite gli apparati tecno-logici, lo sviluppo estremo – e secondo me perverso – del progetto platonico di controllare il pathos, cioè di ammetterlo solo nella misura in cui non distolga le menti. Salvo che, se per Platone si trattava di non deviarle dalla ricerca di verità e dall’esercizio della virtù, oggi – e qui sta la perversione – è di non distoglierle dall’efficienza necessaria a servire il mercato globale nelle vesti di produttrici o di consumatrici.
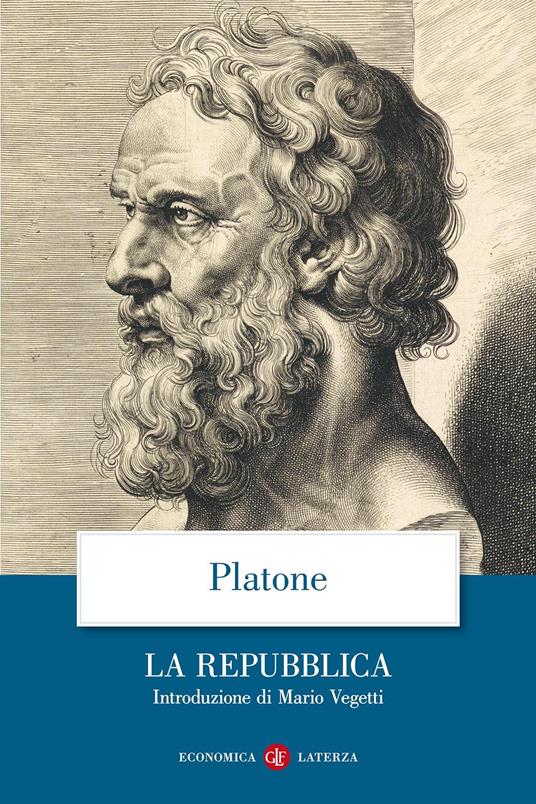
La musica come algo-ritmo del “mercato”
Infatti oggi nessuno si sognerebbe di vietare la musica perché diminuisce l’efficienza: basta entrare in un qualsiasi esercizio commerciale o anche ufficio per sentire musiche diffuse anche ad alto volume che non interferiscono affatto sulla laboriosità di commessi o impiegati. La musica incentiva anzi i loro automatismi, li rende meno pesanti e noiosi. Si tratta però di automatismi e protocolli, non di pensieri o atti creativi.
Ma ecco la domanda: la musica della società tecno-logica, la musica compatibile con l’esercizio del commercio e con il sistema globale del consumo, la musica che agisce come eccitante o sedativo, che rilassa o quantomeno distrae dall’ansia e dalla pena, è sufficiente a renderci felici oppure è una droga che non appaga un bisogno profondo eall’apparenza insaziabile, ragion per cui cercheremo sempre altrove emozioni ed ebbrezze più potenti?
La domanda è ovviamente retorica: la nostra è una società profondamente infelice e tanto più infelice perché restia a riconoscersi tale. Riconoscimento a cui sfugge cercando freneticamente di distrarsi e rinviare così la resa dei conti con sé stessa e con i propri vuoti. Rinvio a cui concorre la diffusione permanente e pervasiva di una musica addomesticata, adattata alle logiche produttive del commercio, così come stato state adattate le droghe. Musica mercificata e perciò privata di un potenziale sovversivo che non riguarda tanto i testi delle canzoni – oggi peraltro patetici nel loro mettere in scena un ribellismo prepotente quanto conforme – quanto la sua capacità di metterci in contatto con dimensioni ancestrali, abissi psichici nei quali dimora l’infinito che ci abita.
E qui arriviamo davvero al punto, al perché l’essere umano ha una profonda relazione con la musica e perché ne ha un così forte bisogno. Ma anche al perché, se ignora l’origine di questa relazione e dunque a cosa lo riconduce ogni volta l’emozione musicale, può accadere che la musica non gli basti e vada a cercare altrove – nelle droghe e negli alcolici, nel sesso e nel possesso, nel denaro e nel potere – emozioni più forti da cui però è destinato a dipendere.
Sì perché la nostra è una società che, tanto si proclama libera e liberista, tanto è, nel profondo, dipendente e condizionata.
Il grembo materno? Una cassa armonica…
Se dunque non possiamo fare a meno della musica è perché noi tutti siamo creature essenzialmente musicali, e lo siamo ancor prima di nascere.
È stato infatti empiricamente accertato dalla scienza che, nel grembo materno, il primo senso a svilupparsi nel nascituro è quello dell’udito. Ciò che però la scienza non sa, non può e non vuole sapere – un illustre scienziato asserì che «non si possono trattare scientificamente i sentimenti», ma su questo torno più avanti – è che attraverso l’udito il nascituro prova emozioni primarie, emozioni che renderanno possibili quelle che vivrà nella sua esistenza separata, scissa da quel grembo che è stato per lui una casa assoluta di cui, senza saperlo, proverà per sempre nostalgia.
Queste emozioni primarie che tutti noi abbiamo provato prima di venire al mondo sono state provocate dall’ascolto del battito del cuore di nostra madre e dall’ascolto della sua voce. Emozioni che, già nel grembo, ci hanno infuso il senso del ritmo e del canto, intendendo per “ritmo” la capacità di vivere in armonia con l’alternarsi dei cicli cosmici – giorno e notte, tristezza e gioia, assenza e presenza, vita e morte – e per “canto” quella di verbalizzare le emozioni, di dare parola agli eventi della nostra vita intima, interiore.
Se insomma la musica è fondamentale è perché di musica siamo fatti.
Chi lo ha capito – forse non è stato l’unico, ma lui ha avuto anche il merito di dirlo in musica come nessuno è riuscito a fare – è stato Franco Battiato. Nel 1971, cioè a soli 26 anni, età dunque rischiosa se diamo retta a mitologie come quella del “Twenty Seven Club”, Battiato compose infatti un disco che, per concezione e realizzazione, era decenni avanti rispetto a quello che si produceva all’epoca in Italia e non solo. Disco che ho scoperto solo di recente, risalendo la mia passione per Battiato alla fine degli anni Settanta, quando, diciassettenne, ascoltai con incredula ammirazione L’era del cinghiale bianco.
Ebbene, ascoltando pochi mesi fa quella precedente meraviglia chiamata Fetus, ho constatato con stupore e commozione che anche Battiato riteneva la vita prenatale decisiva per lo sviluppo di quella successiva, e che forse anche lui aveva individuato nel sentire assoluto del nascituro la radice di quello che con molta approssimazione viene definito “sacro”, aggettivo sostantivato riferito perlopiù all’ambito delle liturgie religiose: «Non ero ancora nato che già sentivo il cuore / che la mia vita nasceva senza amore/ mi trascinavo adagio dentro il corpo umano/ giù per le vene, verso il mio destino».
L’incipit di Fetus mi ha provocato a sessant’anni anni la stessa emozione che provai a diciassette ascoltando un verso de Il re del mondo, una delle canzoni di L’era del cinghiale bianco: «Più diventa tutto inutile, più credi che sia vero. E il giorno della fine non ti servirà l’inglese».
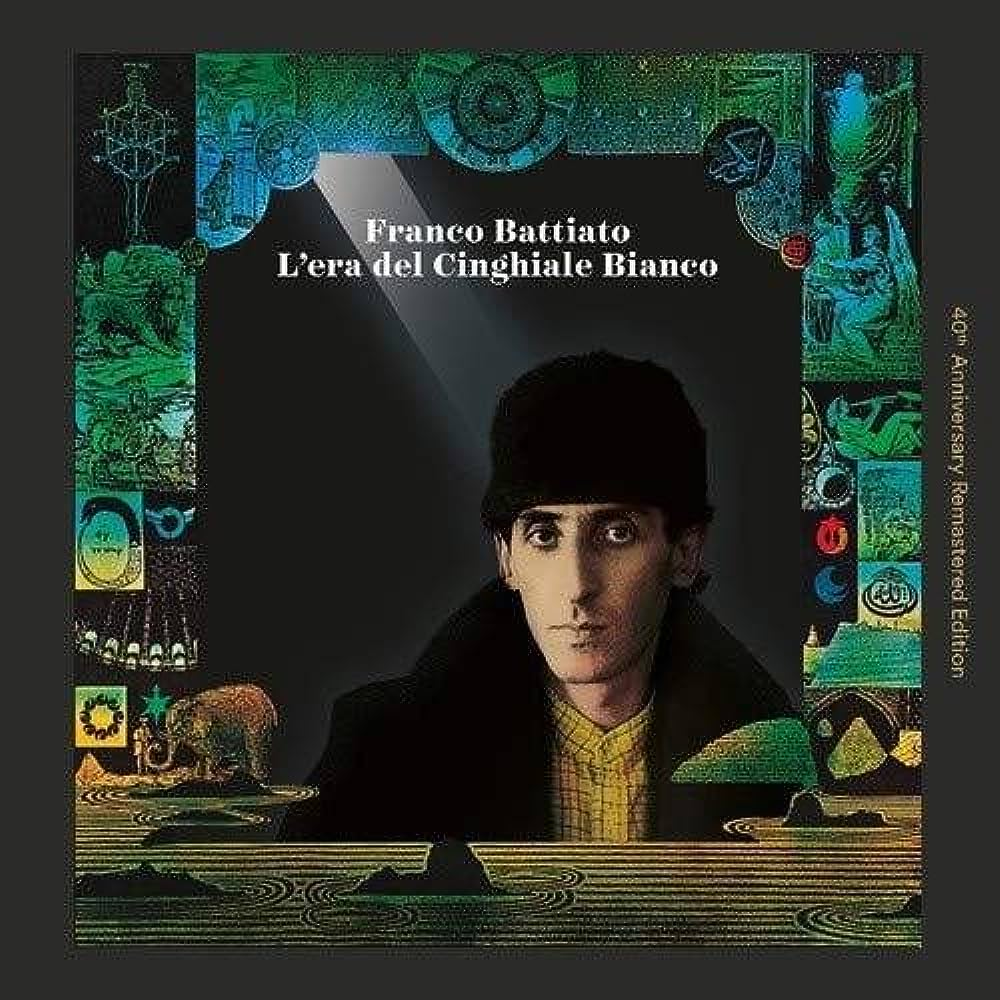
Freud: l’oceano ridotto a pozzanghera
Ancora un excursus prima di tornare al rapporto tra musica e droghe e chiudere la riflessione. Ho accennato a un illustre scienziato che asserì che è difficile, forse impossibile, «trattare scientificamente i sentimenti», come a dire che i sentimenti non possono rientrare in un discorso serio, fondato, verificabile. Quest’illustre scienziato era nientemeno che Sigmund Freud, il fondatore della psicoanalisi.
Quasi cent’anni fa, nel 1929, Freud scrisse un saggio intitolato Il disagio della civiltà, con cui si propose d’indagare le radici del malessere dell’uomo moderno (in un primo tempo aveva scelto la parola ungluck, cioè infelicità, poi ripiegò su un eufemismo, unbehagen, ossia disagio, malessere).
In estrema sintesi Freud individuò la causa del malessere nelle restrizioni pulsionali imposte dalla morale borghese, ovvero, nei suoi termini, nel predominio del “Super-Io” sull’“Es”, del conscio sull’inconscio.
L’Occidente ha preso sul serio la diagnosi di Freud, peccato fosse una diagnosi sbagliata, come dimostra il fatto che il regime di libertà pulsionale di cui oggi gode l’uomo occidentale in base al principio del «se mi piace lo faccio e se mi attrae lo prendo, e chissenefrega delle conseguenze», non lo ha reso più felice, tutt’altro: lo ha reso dipendente dalle sue stesse pulsioni, che, come detto, non trovano mai oggetti in grado di soddisfarle.
Il punto è che Freud era un geniale analista ma col difetto di essere una persona poco “empatica”, limite che, misconosciuto, lo portò a ridurre sentimenti immensi e polimorfi a più misurabili e definibili “pulsioni”. Da cui la convinzione che l’essere umano provi disagio perché assoggettato a morali severe se non “repressive”, mentre la causa della sua infelicità sta nell’ignorare la natura e l’oggetto dei suoi desideri, i quali non mirano ai corpi né alle cose, ma all’infinito di cui siamo fatti e da cui non accettiamo di vivere separati.
Esiste a riguardo un indizio rivelatore e, per me, sconvolgente. All’inizio del saggio Freud cita, ma senza nominarlo, l’amico e scrittore Romain Rolland, premio Nobel per la letteratura nel 1915 – non proprio l’ultimo arrivato, insomma – al quale aveva mandato un altro saggio, da poco pubblicato, intitolato L’avvenire di un’illusione, in cui trattava la religione alla stregua appunto di un’illusione.
Rolland gli risponde per lettera che, se la tesi è in fondo condivisibile, il giudizio sulla religione non tiene però conto della fonte della religiosità, ossia di un sentimento che in lui, Rolland, fa spesso capolino come sensazione di esistere senza limiti temporali né spaziali e che perciò definisce “oceanico”.
Ne Il disagio della civiltà Freud risponde pubblicamente a questo rilievo con le seguenti parole: «Per quel che mi riguarda, non riesco a scoprire in me questo “sentimento oceanico”. Non è facile trattare scientificamente i sentimenti, si può tentare, tuttalpiù, di descriverne gli indizi fisiologici».
Concetto che però, in una lettera privata a Rolland, aveva espresso in modo diretto, con tono scostante e quasi infastidito, scrivendo del “sentimento oceanico” in questi termini: «In quali mondi a me estranei lei si muove! La mistica è per me qualcosa di precluso, come mi è preclusa la musica».
Quando ho letto queste parole sono quasi caduto dalla sedia, non potendoci credere: «Ma come puoi dire che la musica ti è preclusa! Se non entri in contatto con la musica, se non ti abbandoni al suo ascolto, se non le permetti di prenderti e riportarti ogni volta a casa, non sei in contatto con la vita!».
Di colpo si è accesa una luce e mi è parso di capire perché la psicoanalisi freudiana, sempre così distaccata e chirurgica – con Jung è letteralmente un’altra musica, un’altra poesia – non ha ritenuto significativo indagare o almeno immaginare quello che accade nella vita prenatale, dal momento che non si può chiedere a un feto di stendersi su un lettino e raccontare i propri sogni. Anche perché, se potesse parlare, il feto direbbe che i sogni non può raccontarli essendo lui il suo stesso sogno.
Ecco perché la musica è importante al punto da non riuscire a farne a meno: perché risveglia la memoria inconscia e ancestrale della beatitudine prenatale, quando, come scrisse Georges Bataille circa l’esperienza estatica, eravamo «aria nell’aria, acqua nell’acqua». Risveglio che, beninteso, riesce a provocare solo la grande musica, quella scaturita dal bisogno peculiare di ogni grande arte di raccontare o immaginare l’infinito da cui proveniamo e a cui desideriamo tornare.
Ecco allora l’appropriatezza dell’aggettivo “oceanico” assegnato da Romain Rolland a quel sentimento di totalità. Ed ecco, infine, il corto circuito, la disastrosa collisione tra la musica e le droghe pesanti.
Si perché le droghe pesanti sono, nel caso dell’eroina, il più formidabile surrogato della beatitudine prenatale, nel caso della cocaina – ma solo se iniettata in vena come l’assumevo io – il riaccadere della nascita ma in versione esaltante, non più traumatica: si esce dal grembo che ci ha nutrito, accudito e protetto per entrare dritti nel giardino dell’Eden. Dal settimo cielo al Paradiso, insomma. Che poi sia un Paradiso che dura pochi minuti per poi svanire e farci precipitare in un abisso d’angoscia e di panico, poco importa: l’importante è, ogni volta, riprovare l’estasi, giacché di questo si tratta.
Per me tossicomane, il massimo era iniettarmi eroina e cocaina insieme: la cocaina mi proiettava nell’Iperuranio dei sensi e delle visioni, mentre l’eroina faceva da paracadute depositandomi dolcemente a terra. Nel gergo di noi tossici si chiamava “speed-ball”, e William Burroughs in Junkie – tradotto in Italia come La scimmia sulla schiena – lo definisce tramite le parole a Bill, il suo alter-ego protagonista del romanzo: «Se Dio ha creato qualcosa di meglio, se l’è tenuto per sé».

Una tipica “tara” adolescenziale
Come tanti, ho incontrato la musica rock nell’adolescenza perché nell’adolescenza si creano le condizioni affinché la memoria inconscia del sentire assoluto prenatale torni a galla.
Queste condizioni sono date dalla possibilità di restare soli e, una volta posta una distanza tra sé e il mondo, scoprire l’esistenza di un mondo proprio, interiore, nel quale non solo si provano emozioni, ma si è anche coscienti di provarle. Un mondo dove il percepire è al tempo stesso un percepirsi.
Nell’adolescenza si nasce una seconda volta ma da sé stessi e senza traumi, senza la sensazione di essere strappati da uno stato di beatitudine per essere gettati nella gelida vastità del mondo. Sensazione che, dall’alba dell’umanità, ha fatto piangere, strillare e scalciare tutti i neonati venuti al mondo, da che mondo è mondo.
Nell’adolescenza si nasce trionfalmente da sé scoprendosi individui e coltivando perciò la ragionevole speranza di essere destinati a una felicità assoluta, di cui l’ascolto della musica – un ascolto totale e sensuale che coinvolge anima e corpo – rappresenta un formidabile veicolo.
Identificarsi nelle rockstar – e sperare di diventare una di loro – è una tipica tara adolescenziale, preceduta però da una sorta di “casting” tra i tredici e i sedici anni.
Non sempre, infatti, gradimento musicale e identificazione coincidono. Ad esempio al “me” ragazzino, tra i dieci e i dodici anni, piacevano molto i Beatles, certe loro melodie orecchiabili, irresistibili, come quelle di Ticket to ride e di Penny Lane, di Strawberry fields e di Eleanor Rigby. Ma loro mi sembravano troppo puliti, troppo levigati con quei capelli a caschetto e quelle faccette ammiccanti per desiderare di assomigliargli. E poi il mio rapporto con la musica non era ancora sensuale, viscerale: ascoltavo musica ma non la sentivo, l’udito poteva ancora fare a meno del corpo.
Poi, nel giro di due anni, tra i tredici e i quindici, ho scoperto i Rolling Stones, che mi erano stati raccontati come la banda rivale dei Beatles e che in effetti differivano in tutto e per tutto da loro: capelli lunghi e scompigliati, vestiti affascinanti, pose ora sfacciate ora sensuali, e una musica diretta e a volte dirompente, senza fronzoli e coretti, meno accattivante di quella dei Beatles ma più in sintonia con la mia turbolenza preadolescenziale.
Insomma tra Apollo e Dionisio, tra simmetria e disordine, mi sono subito sentito più affine a Dioniso, al disordine.
Ma, contestualmente agli Stones, ho scoperto la musica di David Bowie, il cui volto avevo incontrato già prima, a tredici anni, con turbata fascinazione, raffigurato sulla copertina di un disco di mia sorella, maggiore di me di tre anni. Il disco era Aladdin sane, l’immagine quella, celeberrima – c’è che l’ha definita la “Gioconda della musica pop” – di Bowie pallido, efebico, con i capelli arancioni e una saetta rossa col bordo blu che gli attraversa il viso.
Beh, imbattermi in Bowie è stato scoprire che Apollo e Dioniso potevano convivere in un’unica persona, scoprire che l’uno era il completamento dell’altro e che non era necessario scegliere e, di conseguenza, rinunciare.
Bowie era la “quadratura del cerchio”, la perfezione assoluta: l’essere più affascinante che avessi mai visto, la musica che più di ogni altra mi toccava e sconvolgeva la mente, il corpo, tutto.
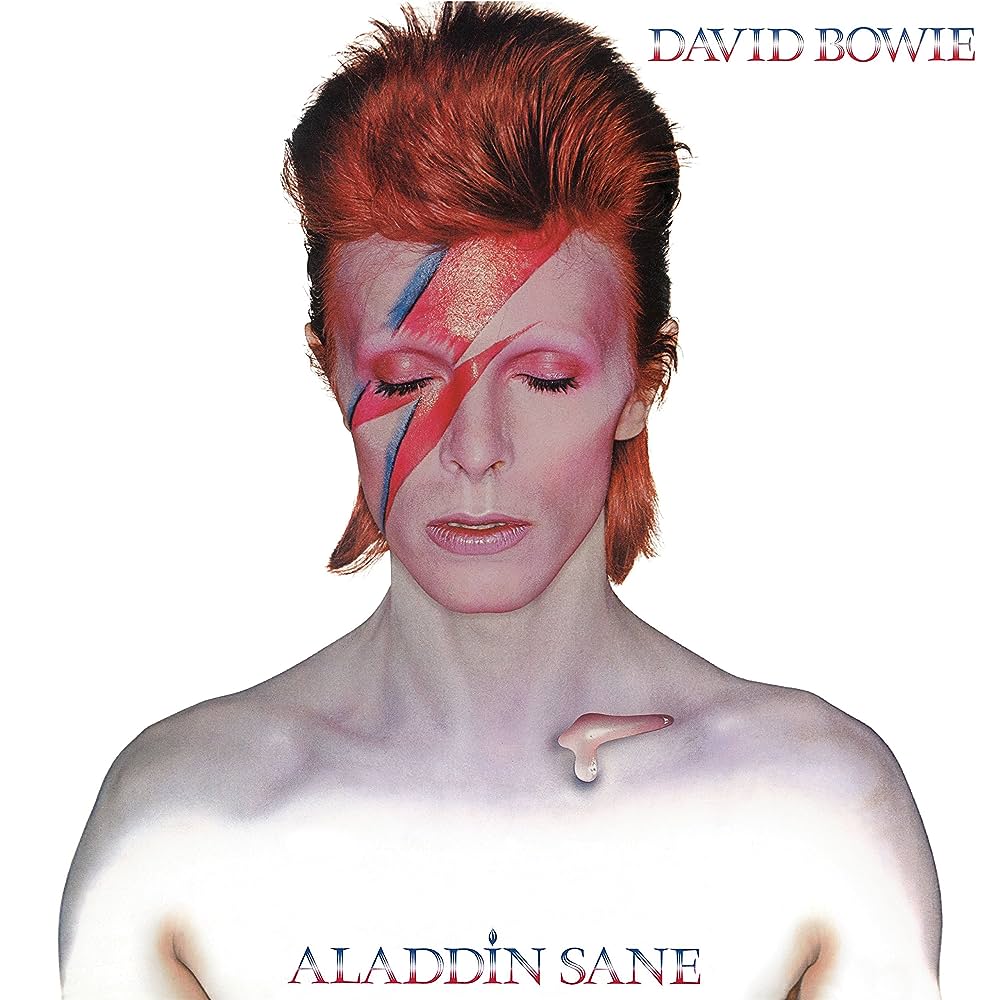
Sentire musica da scorticati
Poi a diciott’anni appena compiuti, il 2 aprile del 1980, ho incontrato l’eroina: sipario, fine delle trasmissioni e degli ascolti.
L’eroina è totalizzante. Sostituisce tutto per darti un Tutto infinitamente migliore, più caldo, più avvolgente, più nutriente. Un Tutto a cui non manca davvero nulla, compresi mantra e ninne nanne che rendono superflua ogni altra melodia.
Eppure la musica è così potente che riuscì a insinuarsi anche nella beatitudine di quel primo amplesso. Ricordo la canzone che scandì quel ritorno al grembo: Broken English di Marianne Faithfull, ex fidanzata di Mick Jagger divenuta tossicomane.
Canzone che tuttora non posso ascoltare senza provare un brivido e supporre che quell’atmosfera cupa, quella voce spezzata, quell’ossessivo giro di basso mi abbiano colpito perché, con il loro incedere da requiem, espressero la verità indicibile di quel momento: mi sentivo bene come mai mi era accaduto, ma quel benessere autosufficiente, imperturbato e imperturbabile, somigliava sinistramente a una morte.
Quel giorno il mio rapporto viscerale con la musica cominciò a sfaldarsi e da colonna vertebrale – oltre che sonora – della mia esistenza, la musica diventò sempre più accessoria, elemento di contorno, rumore di fondo. Quando ero fatto di eroina non me ne fregava nulla di ascoltare un disco, di vedere un film, di leggere un libro.
Ricordo però che quando, al secondo giorno della prima crisi di astinenza, il malessere si fece così acuto da farmi sentire come scorticato, senza più filtri né difese – e gli odori, i rumori, la stessa luce del giorno divennero aggressori da cui era impossibile fuggire – mi alzai dal letto e tremante, grondante sudore freddo, misi sul piatto del giradischi un disco che mi ero appena procurato, in un sussulto d’interesse per le cose del mondo.
Era il mese di ottobre del 1981 e quel disco era Tattoo you dei Rolling Stones – il loro ultimo davvero grande, secondo me – e l’ascolto di struggenti ballate come Waiting on a friend e Worried about you mi commosse quasi fino alle lacrime e per qualche minuto dette tregua allo sfacelo psicofisico, alla consapevolezza che quel primo tentativo di smettere con l’eroina era avviato al fallimento così come avrebbero fallito i successivi. Ma insieme mi fece intuire, quella commozione effimera ma carezzevole, cosa mi avrebbe fatto perdere l’indissolubile matrimonio con l’eroina, la sua incompatibilità con ogni altra passione.

Per fortuna è stata una frattura solo provvisoria, quella con la musica. Arrivato infatti a San Patrignano il 15 ottobre 1983 – fra un mese e mezzo saranno giusto quarant’anni – scoprii sbigottito che in quel luogo era vietato l’ascolto personale della musica: quindi niente registratori portatili, “walkman” o simili.
Decisione che il fondatore e capo della comunità, Vincenzo Muccioli, aveva preso l’estate prima notando come l’ascolto solitario o appartato della musica, provocasse negli ospiti un trasognamento che gli appariva non molto diverso da quello dell’eroina: «Se volete uscire dalle vostre storie bisogna che impariate a essere presenti a voi stessi e alla vita. Quindi da oggi niente più musica in camera. La musica la suonate e la cantate in gruppo, con le vostre chitarre, la sera o nel fine settimana, quando ci prendiamo una pausa dal lavoro» aveva sentenziato il capo.
Quella scoperta fu per me insieme una doccia fredda e un colpo basso. Vada per la rinuncia all’eroina, alla cocaina, agli “speed ball” – rinuncia temporanea o definitiva, chi poteva dirlo? – ma perché anche la musica?
Mi sembrò insomma un inutile accanimento, quello di vietarci l’ascolto della musica, e invece Vincenzo aveva colto il punto: la musica era per noi una sorta di metadone, di pallido surrogato dell’eroina. Tanto l’avevamo snobbata quando eravamo tossici a tempo pieno, tanto ora ci sembrava un necessario unguento per lenire l’angoscia di un vuoto incolmabile, per rinverdire il ricordo di un amore assoluto, ineguagliabile.
Poi, però, arrivò l’estate del 1985 e si diffuse in comunità – che allora contava già più di cinquecento ospiti – la notizia che a Londra si stava organizzando il più grande concerto di tutti i tempi per raccogliere fondi per l’Africa più derelitta, un concerto che sarebbe durato un’intera giornata, a cui avrebbero partecipato tutte le rockstar e che sarebbe stato trasmesso in diretta dalle tv di mezzo mondo, compresa la Rai.
Una delegazione di “veterani” si recò allora da Vincenzo per informarlo della diretta in mondovisione del “Live Aid” e chiedergli, data l’eccezionalità dell’evento, una pietosa sospensione del divieto di ascoltare musica.
Vincenzo fu molto saggio e scaltro: disse che il divieto sarebbe stato sospeso a patto che il concerto lo avessimo guardato con lui nel cinema-teatro della comunità, appena costruito. Voleva capire dal vivo che cosa provocava in una massa di tossici più o meno avviati a nuova vita l’ascolto e la visione dei loro idoli sul palco di Wembley, davanti a un pubblico di 72mila persone.
L’esame andò bene, anche perché la percepibile presenza di Vincenzo in sala c’indusse a contenere reazioni di esultanza venate peraltro da un mesto dispiacere: per la maggior parte di noi il fatto di non essere là, tra il pubblico londinese, era la prova più inoppugnabile dell’avere sbagliato direzione.
Fatto sta che da allora la musica fu di nuovo permessa, a patto che la ascoltassimo insieme, la sera in teatro, e con la vigile supervisione di una regia che selezionava i brani escludendo quelli che alludevano o apertamente celebravano un’esperienza tossicomanica: da Brown sugar degli Stones a Heroin di Lou Reed, passando per Cocaine di J.J. Cale e I’m waiting for the man dei Velvet Underground.
Ma da allora fu anche permesso, a chi era avanti nel cosiddetto percorso di recupero – parola che detestavo e continuo a detestare perché chi la utilizza ritiene che la società impegnata a recuperare pecore “nere” o “smarrite” sia il migliore dei mondi possibili – di riprendere un contatto personale, privato, con la musica, come accadde a me quando, ripresi gli studi e passato con sei anni di ritardo il cosiddetto esame di maturità, Vincenzo assecondò il mio desiderio di continuare e mi mandò a Bologna, dove aveva affittato una grande casa per ospitare una decina di studenti universitari della comunità.
E lì, a Bologna, ho avuto un’ulteriore dimostrazione della potenza della musica e di quanto profonda sia la sua relazione con la nostra psiche.

E la musica, infine, tacque…
Dal 1986 iniziarono infatti ad arrivare in comunità persone non solo contagiate dal virus Hiv ma in uno stadio avanzato della malattia, l’ormai famigerato Aids, e Vincenzo non poté fare altro che mandarle nel luogo dove avrebbero ricevuto, se non cure all’epoca del tutto inefficaci, almeno un’assistenza medica all’altezza, ovvero il reparto “infettivi” dell’Ospedale Maggiore di Bologna, il più grande della Regione.
Noi studenti universitari decidemmo così di dare una mano organizzando un’assistenza giorno e notte per far sentire meno soli quegli sventuratissimi compagni di sventura. I quali venivano ricoverati con diagnosi di “Aids conclamato”, come lo definivano i medici, benché le loro condizioni non facessero pensare a una malattia allo stadio terminale: si nutrivano e camminavano da soli, sia pure con sforzo, giocavano con noi a carte o discutevano di calcio, di basket, delle “top model” ritratte sulle riviste patinate. E, soprattutto, volevano la tv sempre accesa su “Videomusic”, il primo canale in Italia a trasmettere solo videoclip.
Tale “routine” poteva andare avanti per settimane e a volte mesi, finché non si manifestava una di quelle che i volonterosi ma impotenti medici chiamavano “infezioni opportunistiche”. Mali che ricordavano bruscamente ai pazienti il motivo per cui erano lì e mutavano la loro relativa serenità in una serrata, angosciata resistenza a cui il virus rispondeva passando dal fioretto al bazooka e portando a termine in pochi giorni la sua devastante opera.
L’ho ancora ben impressa, quella spaventosa prova di efficienza: ai malati s’imbiancavano le ciglia e la pelle diventava trasparente. Nel contempo smettevano di parlare e, lo sguardo perso nel vuoto, ci facevano cenno di spegnere il televisore e abbassare le tapparelle.
Luce e musica: segni troppo evidenti e dolorosi della vita che li stava abbandonando.
Sì, perché la musica può, se non tutto, molto: lenire ferite, amplificare gioie, innescare immaginazioni malandrine o sogni proibiti.
Ma anche la musica avverte la maestosa regalità di quel ritorno al sacro che chiamiamo morte e ne osserva in disparte lo svolgersi: soggiogata, intimorita, infine silenziosa.
Immagine copertina: illustrazione di Mara Melis
