In un capitolo di Pensieri della mosca con la testa storta (Adelphi, 2021), Giorgio Vallortigara spiega perché il solletico funziona solo se fatto dagli altri. La ragione è legata alla copia efferente (o scarica corollaria), quel segnale motorio di input che informa il sistema sensoriale dell’azione che è in fase di svolgimento. Quando ‘ci solletichiamo’, la copia efferente cancella il segnale sensoriale che ci stiamo provocando; al contrario, durante la ‘gargalesi’ (il solletico propriamente detto), le sensazioni tattili non sono annullate. Il solletico, dunque, è uno dei luoghi misteriosi dell’esperienza cosciente, sospesa e liberata, addirittura prevista, dal cervelletto, o desiderata, come dimostrano alcuni esperimenti sui ratti, in cui l’attività dei neuroni nella regione della corteccia somatosensoriale (che rappresenta la zona stimolata) aumenta ancor prima della stimolazione stessa. Un esempio, quello del solletico, che, in piccola parte, restituisce la complessità della comprensione di che cosa sia l’esperienza cosciente, «l’emergere della meraviglia».
In questa intervista, ho avuto la fortuna di ragionare con Giorgio Vallortigara riguardo il rapporto tra coscienza umana e animale, sulle differenze che, a oggi, in base allo stato dell’arte, possiamo riscontrare tra “noi” e “loro”, e, più in generale, su cosa quale sia il legame tra coscienza, linguaggio e pensiero (anche negli animali) in base alle più recenti scoperte scientifiche. Una lunga chiacchierata che sottende l’hard problem che ricorda Antonio Damasio in Sentire e conoscere (Adelphi, 2022) – «perché, e in che modo, i processi fisici che hanno luogo nel cervello danno origine all’esperienza cosciente?» – e che ci interroga sulle nostre competenze innate, l’argomento dell’ultimo saggio di Vallortigara, Il pulcino di Kant (Adelphi, 2023).
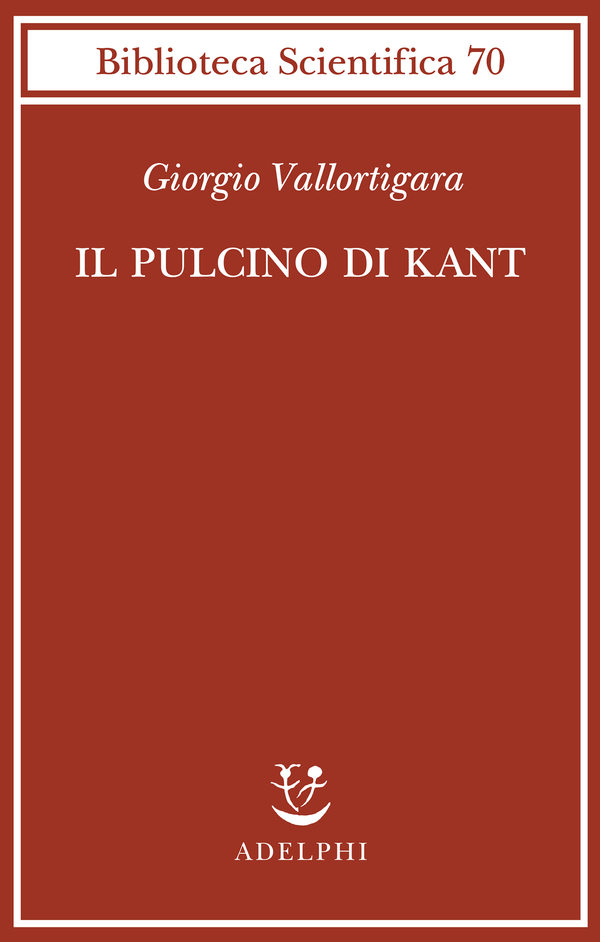
Vorrei partire dal concetto chiave di «funzione sociale dell’intelletto». In che termini questa ipotesi ha a che fare con il problema dell’esperienza cosciente?
In origine l’idea che la vita di relazione abbia promosso la complessità dei processi mentali della nostra specie era stata usata da Nick Humphrey per sostenere l’origine sociale della coscienza. Io credo che i due problemi siano diversi. Avere esperienze (come sentire dolore o piacere) non è legato al fatto di avere una vita relazionale complessa. È vero, però, che possederla è associabile al linguaggio: gli esseri umani sono in grado di comunicare agli altri i contenuti delle loro esperienze. Tuttavia, non penso che il mistero della nascita dell’esperienza dipenda dal linguaggio. La condivisione, i contenuti dell’esperienza cosciente, sono secondo me uno step successivo, forse unico della specie umana, che avviene tramite il linguaggio. Ma il primo passo è la comparsa dell’esperienza, il fatto di sentire qualcosa, di provare qualcosa – che sia comunicabile o meno.
Un’abilità connessa al linguaggio, studiatissima, che lei cita nel saggio, è la cosiddetta Theory of Mind (ToM): la capacità di attribuire agli altri degli stati mentali. Quali evidenze abbiamo che gli animali posseggano questa competenza? Se è così, ciò suggerisce che la ToM sia un’abilità specializzata (alla Fodor) o una proprietà emergente?
Credo che le evidenze nelle scimmie antropomorfe e nei corvidi siano abbastanza convincenti, soprattutto gli studi più recenti che usano la misurazione della fissazione oculare riproducendo in forma non verbale i risultati di test classici condotti sui bambini. Un esempio è quello del test di Sally e Ann. In breve: vengono presentate due marionette, Sally e Ann. Sally colloca una biglia in un cesto e poi si allontana; Ann prende la biglia e la colloca altrove all’insaputa di Sally. Si chiede al bambino o a un altro animale (per esempio misurando dove guarda) dove Sally cercherà la biglia una volta che sia tornata, ovverosia se cercando la biglia nel posto originario Sally mostri di possedere una falsa credenza. Dai risultati sembra che la capacità di attribuire stati mentali agli altri (avere una ToM) sia una capacità specializzata, un modulo in senso Fodoriano. Infatti, i suoi meccanismi costitutivi, per esempio la capacità di distinguere le cose animate dagli oggetti inerti e la capacità di cogliere che certe entità sono agenti dotati di scopi e intenzioni, si possono rintracciare in una varietà di specie sociali, e i processi nervosi in cui sono incarnati iniziano a essere compresi.
In Linguaggi animali (Nottetempo, 2021) l’antropologa Eva Meijer problematizzava l’assunto che le proprietà del linguaggio umano (riassumo) non si trovino in quello animale, il primo un sistema aperto, creativo, il secondo chiuso. A oggi, il linguaggio resta la prerogativa biologica (se così la vogliamo definire) che separa cognitivamente il mondo umano da quello animale?
La parola linguaggio sussume una pluralità di capacità distinte. Alcune sono presenti anche in altri animali oltre all’uomo, per esempio la referenzialità (la presenza di segnali arbitrari che ‘stanno per’ oggetti o eventi), la capacità di convogliare questi segnali in maniera intenzionale, la capacità di riferirsi a eventi dislocati nello spazio e nel temo. Altre, invece, come la produttività – la capacità di combinare infinitamente segnali finiti – sembra non avere al momento analoghi nelle altre specie. Il dibattito su questi temi è comunque acceso. Consideriamo ad esempio il problema della ricorsività linguistica che si manifesta nelle frasi cosiddette ‘annidate’. Quando comprendiamo una frase come 1) Il cantante che la giornalista inseguiva da giorni è l’autore della canzone la proposizione annidata è la giornalista inseguiva da giorni. Con le parentesi scriveremmo: [Il cantante (che la giornalista inseguiva da giorni) è l’autore della canzone]. Recentemente, alcuni studi mostrano come delle cornacchie addestrate a beccare secondo una sequenza ricorsiva due coppie di simboli come [ ( ) ], alla successiva presentazione di nuove coppie di parentesi, con colori e fogge differenti, producevano sequenze ricorsive più spesso di quanto non producessero sequenze non ricorsive, come ad esempio [ ] ( ). Per capire se davvero questi risultati indichino che non vi sarebbe nulla di speciale nel linguaggio umano, e che la ricorsività che osserviamo per esempio nelle frasi annidate sarebbe rivelata negli altri animali in differenti domini, bisogna però considerare che la nozione di dipendenza sintattica è qualcosa di più sofisticato degli annidamenti che sono stati studiati nei corvi, che secondo alcuni studi potrebbero essere il risultato di processi di memoria anziché di ricorsività. In ogni caso, se davvero gli animali non umani possono maneggiare il processo della ricorsività la domanda è cosa se ne facciano, considerato che non sembra che la usino per comunicare.

Al convegno Syntax Meets the Brain, il linguista Andrea Moro asseriva che gli animali, nonostante non posseggano alcuna sintassi, chiaramente pensino, a dimostrazione che linguaggio e pensiero vadano distinti. In che modo gli animali pensano?
Sono d’accordo con Andrea: non serve possedere un linguaggio (una sintassi) per pensare e ragionare logicamente. Direi comunque che gli altri animali pensano nello stesso modo in cui pensano gli esseri umani. I meccanismi precisi non li sappiamo ancora descrivere nei termini di eventi neurali, ma possiamo osservare nel comportamento che, ad esempio, creature che non posseggono sintassi come i pesci, le vespe o i polli possono condurre inferenze transitive, come per esempio se A>B e se B>C allora A>C.
Tra le pagine di La mosca con la testa storta suggerisce che l’abbondanza di neuroni serve per gestire una grande mole di dati, ma non per pensare; i mini-cervelli degli insetti hanno cioè un deficit rappresentazionale. Che legame c’è tra la capacità di ‘vedere’ e l’abilità di generare delle rappresentazioni mentali?
Per condurre il riconoscimento di un volto, discriminando supponiamo una fotografia della mia faccia dalla sua, le api richiedono solo poche prove di addestramento. Anche semplici reti neurali artificiali possono fare lo stesso con appena qualche centinaio di unità. Diversa è la richiesta computazionale se devo tenere in memoria a lungo termine una rappresentazione di queste facce, la mia, la sua e poi quelle di molti altri individui. Gli esseri umani, si stima, possono riuscirci tranquillamente con varie migliaia di volti. Questo perché la nostra vita sociale è largamente dipendente dal riconoscimento individuale su base visiva. Ma un’ape non ha bisogno di far questo e non ha ovviamente i neuroni per farlo.
Dunque, nei cervelli più piccoli, la potenza di calcolo è sopperita dalla specializzazione a livello neurale (come sostiene Dunbar)?
Un modo per sopperire al deficit di memoria conseguente ai limiti nella capacità neuronale è di sfruttare in modo diretto la cognizione senso-motoria. Questo è quello che fanno gli insetti con movimenti di scansione che consentono un campionamento attivo della struttura dell’ambiente. Forse ciò spiega perché in animali come i vertebrati sia possibile ottenere informazioni da singole istantanee a prima vista (quello che in inglese viene chiamato ‘at a glance’), mentre i cervelli con pochi neuroni hanno in generale meno capacità di condurre elaborazioni dell’informazione off-line (perché queste richiedono un significativo ritardo nei segnali neurali). Insomma, gli animali con cervelli piccoli devono stare sempre in contatto col mondo, facendo dell’interazione col mondo la loro memoria.
Dai risultati dell’esperimento condotto su un esemplare di mosca Eristalis tenax, sembra che l’evoluzione della locomozione negli animali abbia determinato la necessità degli stessi di discriminare tra «tra il sé e il non sé». Usando le sue parole, «è la copia efferente che permette di sentire la sensazione». In che modo la coscienza è connessa a questa intercapedine che lega la sensazione al sentito e la distingue dal percepito?
Conosciamo il meccanismo della copia efferente da molti anni. Fu ipotizzato, ben prima dell’esperimento di von Holst, da Purkinje, von Helmholtz, von Uexkull e Steinbuch tra i tanti. Io nel mio libro ho provato a immaginarne una variante che potesse rendere conto della necessità dell’esperienza. L’idea è semplice. Immaginiamo che in origine la risposta degli organismi agli stimoli avesse la forma di una reazione locale del corpo. Questa reazione corporea locale con il movimento attivo si è trovata a essere accompagnata da una copia efferente. Diversamente dal modello convenzionale, tuttavia, io ipotizzo che sia questa copia efferente della reazione corporea locale che è confrontata con i segnali di movimento di tipo attivo, producendo, quando questi sono presenti, quello che il filosofo Thomas Reid chiamava percezione (c’è un oggetto là fuori) oppure, quando non lo sono, quello che Reid chiamava sensazione (c’è qualcosa che capita a me, che io sento, un’esperienza).
Una teoria tanto accreditata quanto discussa della coscienza concerne la cosiddetta informazione integrata dell’esperito; a oggi, però, come ricordato anche nell’ultimo saggio di Christof Koch Sentirsi vivi. La natura soggettiva della coscienza (Cortina, 2021), essa non è sostenuta da solide evidenze empiriche. In La fonte nascosta. Un viaggio alle origini della coscienza (Adelphi, 2023) di Mark Solms, il neuroscienziato sostiene che la teoria non funzioni perché primo non spiega l’esperienza cosciente non considerando l’aspetto dei sentimenti (le emozioni primarie), e, secondo identifica la zona corticale errata: l’origine della coscienza si situerebbe in una piccolissima zona comatogena situata nel tegmentomesopontino superiore, una struttura antichissima, che abbiamo in comune con moltissimi mammiferi e perfino con i pesci. Insomma, l’idea centrale di Solms, che si rifà alle tesi di Karl Friston, è che la coscienza sia un processo omeostatico: percepiamo l’aumento o la diminuzione di errori predittivi in riferimento a una condizione di equilibrio. Cosa la convince e cosa non di queste due ipotesi?
Condivido totalmente l’idea che l’esperienza non origini nella corteccia. In realtà sospetto che il genere di circuiteria che sostiene la coscienza sia presente in organismi che posseggono sistemi nervosi anche molto diversi dai nostri. Preferirei però usare la parola ‘esperienza’ o ‘senzienza’ anziché coscienza, che veicola una varietà di significati. Per me il problema è spiegare perché, quando e in che modo gli organismi abbiano iniziato a sentire qualcosa. Questo sentire è ovviamente connotato affettivamente. La teoria di Giulio Tononi mi pare si occupi di tutt’altro, perché la sua è una misura dell’informazione mentre il problema della coscienza è intrinsecamente connesso a quello del significato. Come origina il significato per gli organismi? Deve essere stato qualcosa di assai semplice all’inizio, un riconoscimento legato a una interazione come quella che avviene quando un sito recettoriale ‘riconosce’ la sua proteina perché ha la forma giusta per quel sito e quindi è qualcosa che conta per quell’organismo. La trasformazione di questo contare in un sentire deve essere accaduta per evitare la possibilità dell’equivoco: come distinguere il genuino incontro con la proteina dal suo mero occupare il sito?

Ringraziandola, la vorrei salutare usando le parole di Daniele Del Giudice, «bisogna fare conoscenza, prima di tutto» dice ne Lo stadio di Wimbledon. Mi ricorda l’asserzione di Lorenz «Life itself is a process of acquiring knowledge». Ecco: da dove nasce questa esigenza di sentire? In altri termini: è stimulus based o, al contrario, higher ordered?
Penso sia stimulus-based nel senso che ha a che fare con il modo in cui gli organismi biologici formano il significato a partire dall’incontro attivo con le cose dell’ambiente, gli stimoli. Però ha una componente di memoria, di brevissimo momento. Nel libro impiego una metafora per rendere l’idea, il brano di Borges in cui si dice che l’esperienza estetica (l’esperienza tout court nel mio caso) corrisponderebbe all’«l’attesa di una rivelazione che non si produce». Sospetto che il tempo denso e breve del nostro sentire abbia questa qualità appunto, di attesa di una rivelazione che non si produce, ma in senso fisiologico.
Ma forse non dobbiamo prenderla troppo sul serio, citando ancora una volta Del Giudice da Atlante Occidentale: «L’importante non era scriverla, l’importante era provarne un sentimento».
In copertina:
Frans der Mijn, Donna in un paesaggio con mosca sulla spalla, 1742
