«Nella vita vince chi resta. E Fa quello che serve» Michela Murgia resta – o resterà, secondo il futuro senza margini che le ha consegnato Chiara Valerio e che le molte persone che l’amavano hanno fatto proprio – nella sua statura di scrittrice elegante e consapevole, prima di tutto. Nella qualità abbacinante delle immagini di Accabadora o di Chirù, persino di L’inferno è una buona memoria. La lingua (il suo sardo, ma anche l’italiano) maneggiato in punta di pennello. Resta come un’eredità di antichi saperi, una storia da riscrivere e consegnare alle figlie di domani. Un’epica, persino, possibile, di quello che siamo state e potremmo essere. Questa è, non a caso, l’ultima pagina che – nella composizione del figlio d’anima Alessandro Giammei, Murgia consegna di sè, ripescata dal cassetto di una delle sue prime prove da scrittrice formalmente identificata come tale (anche se chi ha potuto leggere, ad esempio, le pagine con cui giocava di ruolo nell’universo fantastico di Lot giura che la Murgia scrittrice sia nata in realtà molto prima). Una sorta di canto delle radici, la consegna di una leggenda, di una genealogia della Sardegna, ma piuttosto dell’umanità tutta, trasmessa per voce di donna, che pare recuperare liberandone le possibilità le pagine più liriche del Sergio Atzeni di Passavamo sulla terra leggeri. Come quelle, anche in quel caso le ultime di una vita poi perduta in mare, quelle di Murgia sono le parole di un lascito, consegnato all’orecchio scelto di chi è chiamata a farsene carico, come una figlia. Ma a sceglierlo, perché – se c’è qualcosa che Murgia ha insegnato fin dalle sue prime righe e fino agli ultimi istanti, e che la Sardegna consegna da secoli come insegnamento al continente – è che l’essere figli ha a che fare solo con la disponibilità a scegliersi, e a farsi carico nella misura del prendersi cura. Si intitola Altre madri, e fa sintesi, a ben guardare, di tutta una vita, e risulta, forse una delle pagine più luminose della Murgia scrittrice, e si potrebbe dire una delle più sincere, se sincera non fosse stata la sua intera esistenza, fino alla messa in pericolo di sé. Una delle più schiettamente personali, forse, non a caso mediate dalla letteratura, per una donna che ha scelto, invece, da un certo punto in avanti, la misura chirurgica del saggio. Perché ogni urgenza ha la sua parola, quella e non un’altra, e spesso la metafora, anche la più raffinata, perde di forza per dire quello che serve. E quello che serve, in tutto l’ultimo tempo che la vita le ha dato, Michela Murgia lo aveva evidentemente chiarissimo, e gli ha dato forma, con una chiarezza e un coraggio commuovente, con le ultime forze a disposizione. Voleva parlare di donne e di famiglie, di maternità e di corpi. Voleva, in fin dei conti, mettere a disposizione la propria credibilità per chi aveva meno voce di lei, far da scudo con il proprio corpo (martoriato e bersagliato da un odio durato anni, di cui in molti si sono già troppo facilmente dimenticati e discolpati) a corpi non riconosciuti, non tutelati, costretti a farsi scegliere da altri, dal potere, dal silenzio delle leggi che non ci sono e non si vogliono creare, e anche dal preteso buonsenso di chi parla senza sapere di vite che non sono la sua. Dare la vita, insomma, lo stesso titolo del pamphlet uscito per Rizzoli all’inizio del 2024. Dentro cui c’è tutto, il riannodarsi dei fili che aveva cominciato a tessere proprio nelle prime pagine di romanziera, su altri legami possibili, relazioni oltre i ruoli e maternità libere dai lacci del sangue, che ne percorrono carsicamente esistenza e opera e di cui ha stretto le maglie nei saggi, nelle dichiarazioni pubbliche e poi in questo pugno di pagine densissime. La traccia evidente di un dialogo costretto a restringersi laddove avrebbe potuto e voluto, e forse avuto bisogno di esorbitare in un numero di pagine, interventi e discorsi enormemente più grande, qui reso affannoso dalla fatica e dal tempo stretto cui la costringeva il suo corpo, eppure limpido e preciso anche grazie alla lucidità (non che le fosse mai mancata) e soprattutto all’assenza di remore che – come ha ripetuto spesso nelle ultime interviste – proprio quella sua condizione le concedeva. Quella che Michela Murgia fa in Dare la vita è, nei fatti, una pratica della soglia, tra passato e presente, fra corpi e possibilità. Ma è soprattutto, una pratica della soglia come atto politico, che nella lingua che ha trovato, fatto propria e mutuato dagli studi precedenti, traduce col termine queerness, che accoglie il cambiamento come strutturale. È un dato di fatto, del resto, che oggi, soprattutto grazie a lei, il termine queer sia entrato anche in contesti dove fino a sei mesi fa sarebbe stato impensabile, non per farne un elemento prescrittivo o peggio ancora folkloristico o banalizzante, ma per rimettere al centro l’altro significato della lettera Q, ad esempio, all’interno dell’acronimo LGBTQIA+, che oltre a queer sta per questioning. Anche dalle pagine di Murgia si conferma che una domanda vale più di cento risposte, e il suo potere è quello di non esaurire mai gli interrogativi. Se la famiglia queer, di cui tanto ha parlato nell’ultimo anno, non è che una famiglia libera da vincoli biologici, la stessa che aveva sperimentato sulla sua pelle e poi nei suoi romanzi in veste di «figlia d’anima», nata due volte (chi non avesse letto le prime pagina di Accabadora lo faccia, lasciandosi catturare dall’immagine e dal suono, prima ancora che dal messaggio: ne resterà folgorato).

Praticare la soglia, per Murgia, significa però rifiutare ogni tipo di suddivisione binaria, ogni bianco o nero. Sia per la società che per se stessa. Parlando apertamente di sé, spiega, come accettare che l’indeterminatezza, quando è programmatica e vissuta in riflessiva condivisione, sia una condizione di libertà, una bandiera, che assomma le altre, un metodo possibile per trovare uno spazio altro all’interno del binarismo. Non solo mettere in evidenza la miopia talvolta grottesca dei vincoli giuridici, ma anche alcuni degli assunti su cui si reggono.
La fedeltà, ad esempio, a cui si sostituisce piuttosto una logica di reciproca affidabilità, contro l’obbligo intrinsecamente violento, sostiene, della reciproca promessa di vita: promettersi amore eterno significa – dice Murgia – prendersi l’impegno irrealistico di non cambiare, e la fedeltà non è che «l’arma con cui il binarismo patriarcale controlla la vita delle persone, specie di quelle che chiama donne».
È sul corpo delle donne che si gioca, a ben vedere, l’intero pamphplet, alla sua origine pensato come un saggio sulla Gestazione per altri. Un tema, questo, di cui Murgia stessa non nega la complessità, assumendo una posizione programmaticamente personale (acute, ad esempio, le riflessioni anche linguistiche sul termine surrogacy, serissime e puntuali quelle sull’aspetto economico del percorso. L’aspetto fondamentale e poco o nulla praticato altrove, della sua riflessione, è però l’accuratezza nel riportarlo non alla mistica del materno e alle sue radici etiche ma, invece, al corpo delle donne. La GPA, spiega Murgia, sarebbe in questo senso accostabile all’aborto, sul piano della legge: se deve essere garantito il primo (e ci si augura che non se ne dubiti) per quale motivo non la seconda? Se si disciplina il diritto a interrompere una gravidanza, per quale motivo non si dovrebbe farlo con chi di fatto non fa altro che scegliere di non interromperla? Anche perché – e su questo all’opinione di Murgia vengono in soccorso decenni di studi su tutti gli ambiti in cui è applicabile l’antiproibizionismo: nessun divieto eradica un fenomeno, fa solo in modo che si verifichi con meno tutele, economiche e giuridico sanitarie. Le pagine di Murgia studiano senza ipocrisia un fenomeno su cui sarebbe qui fuorviante soffermarsi oltre, ma che rimangono preziose per chi sia seriamente intenzionato a interrogarvisi.
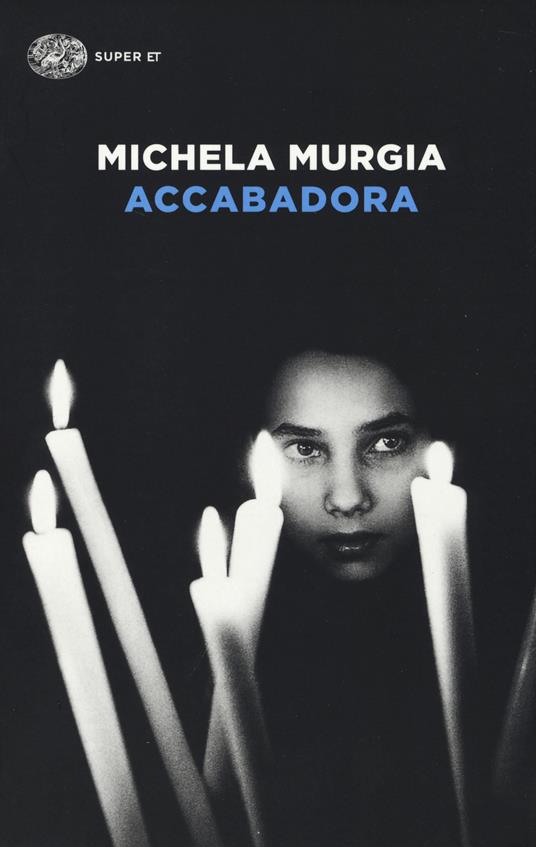
In generale, se di un’eredità sola di Michela Murgia si può parlare, è quella di chi assume la postura dell’intellettuale, non rifiuta mai una presa di posizione, sia essa sulle migrazioni e le negazioni dei diritti umani (come fa fino alle ultime ore di vita) o sulle ombre di un fascismo di ritorno le cui pratiche sono, persino nei pochi mesi successivi al dieci agosto scorso, diventate tanto abituali da scomparire quasi allo sguardo. La voce di Murgia, che resta e resterà, è però, prima ancora, una voce che restituisce alle donne il diritto di parola (esclusivo) su ciò che le riguarda, direttamente e individualmente. Consapevole attraverso il proprio corpo in quante maniere si può dare la vita, Murgia puntella infine le polemiche politiche sul materno e sul ruolo della donna nella società con una sintesi lapidaria. «Le donne italiane ricominceranno a dare la vita quando per farla venire al mondo e crescerla non sarà più necessario amputare la propria».
Un’eredità che ha generato anche in questi mesi un odio violento, tanto quanto tuttavia è stata travolgente l’ondata di gratitudine e senso di appartenenza che ha spinto – e sta spingendo, oltre l’ondata momentanea dell’elaborazione del lutto, molte e molti ad un’autentica nuova consapevolezza. Perché, se l’ultima consegna al futuro di Murgia è: «la mia anima non ha mai desiderato generare né gente né libri mansueti, compiacenti, accondiscendenti», non resta che appoggiarsi alle sue parole, di autrice e di portatrice di pensiero, per continuare un dialogo, franco e se occorre polemico, ma sempre generativo. Capace, come lei, di «dare la vita».
Copertina: Michela Murgia per Vanity Fair
