Uno studio filologicamente attento della prosa di Platone finirebbe verosimilmente per far luce su alcune direzioni appena intraprese e poi smarrite nel discorso filosofico occidentale. Potrebbe altresì rivelare alcuni esiti teorici presenti già nel pensiero platonico, e che solo secoli dopo sarebbero stati recuperati, presentati come fossero la novità più pura. Frigidità della traduzione, che sacrifica sugli altari del significato tutte le sfumature del significante – di necessità virtù, come sempre si fa.
Atopos è una delle parole più interessanti e germinali che la prosa platonica letta in originale sa restituire. Un alfa privativo, lo stesso –topos che è alla radice di utopia – di questi tempi ci vuole un niente per fare un’etimologia. “Senza-luogo” o forse più propriamente “senza-centro”, senza fissità –nomade? sarebbe già un’interpretazione. Per contestualizzare e collocare una parola che allude proprio a una feconda de-localizzazione, si tratta di uno degli aggettivi con cui più spesso Platone tratteggia la figura del suo maestro Socrate, a volte per bocca di Socrate stesso. Parola quanto mai cara, quindi, a chi scriveva.
Le traduzioni italiane non rendono, o almeno non rendono appieno. Ad esempio, all’inizio del famoso passo del Teeteto che spiega il senso della prassi filosofica di Socrate in termini di maieutica paragonandosi a sua madre levatrice, il filosofo premette all’amico: «in realtà, che io possiedo quest’arte l’ho tenuto nascosto: [gli Ateniesi], non sapendolo, non dicono di me questo, bensì che sono un uomo stranissimo e che metto in imbarazzo gli altri», si legge nell’edizione dei dialoghi platonici curata da Giovanni Reale. L’inevitabile traduzione camuffa due termini quanto mai pregnanti nel greco dell’originale: atopos, al posto di “stranissimo”, e aporia, al posto di “imbarazzo” – tant’è vero che altre traduzioni riportano “genero solo perplessità”, forse con più pertinenza. Anche il Simposio definisce Socrate atopos, per bocca di Alcibiade stavolta, e specifica pure le ragioni di questa atopia: «sia per quello che lui stesso è, sia per i discorsi che fa» non c’è «neppure uno che gli si avvicini, né fra i contemporanei né fra gli antichi, a meno che non lo si paragoni… ai Sileni e ai Satiri».

Questo passo del finale del Simposio è particolarmente noto, ma vale la pena ripercorrerlo perché ha il pregio di illuminare come quello di Atopia sia uno di quei concetti logici che assorbono a un livello strutturale il loro significato, tanto che ogni volta che emergono si apre un piccolo buco nero di linguaggio: infatti, come Alcibiade specifica nelle righe che seguono, non solo Socrate assomiglia, fisicamente e caratterialmente, a quelle curiose figure caprine che sono i sileni, ma vi assomigliano anche i suoi discorsi – questo, come complimento, è ancor più paradossale. Ascoltati distrattamente, magari da un passante, Alcibiade sa che i discorsi di Socrate superficialmente «potrebbero sembrare del tutto ridicoli», ma, «se uno li vede aperti ed entra in essi, troverà che… sono divinissimi e hanno in sé moltissime immagini di virtù». Solo uno sguardo approssimativo e viziato dalla tradizione cristiana potrebbe scambiare satiri e sileni per dèmoni: si tratta di esseri buffoneschi ma profondi, suonatori di flauto sessualmente sfrenati. Certo, anche loro sono senza casa, se vogliamo senza-luogo: la maggior parte delle rappresentazioni, sia iconografiche che letterarie, li mostrano vivere nei boschi, o seguire i cortei dionisiaci.
Tentiamo adesso un salto in avanti di un paio millenni. «“Fa parte della mia fortuna” scriveva Nietzsche nella Gaia scienza “non possedere una casa.” E oggi si dovrebbe aggiungere: fa parte della morale non sentirsi mai a casa propria» commentava Adorno nei Minima Moralia. «Questo dice qualcosa del difficile rapporto in cui il singolo si trova con la propria proprietà, finché possiede ancora qualcosa» era la sua conclusione, certo legata anche alle sue vicissitudini personali di ebreo tedesco espatriato negli Stati Uniti. A questa morale del non sentirsi mai a casa propria Adorno continuò a essere fedele per tutti i suoi scritti del dopoguerra, nel sistematico rifiuto di ogni sistema, passando dalla struttura aforistica che è la cifra degli stessi Minima Moralia fino alla ricerca di una Dialettica Negativa che sottragga al pensiero occidentale certe sue certezze logiche e soprattutto la sua irritante positività.
La linea atopica rivendicata da Adorno è tutt’altro che isolata nelle filosofie del Novecento. Nietzsche per primo aveva riaffermato la necessità di un nomadismo della filosofia, in evidente antitesi con l’accademismo che sempre presuppone una sede, un’università – ma la rivoluzione concettuale avviata dal filosofo dello Zarathustra arrivò, nel secolo che lui non poté vedere, a mettere in discussione la logica profonda del discorrere filosofico.
In principio fu Freud. Per quanto ampiamente contestata fino alla parodia, la teoria sessuale che fa sfondo alla prima delle psico-analisi tentate e codificate nel corso del Novecento postula un principio di atopia che ha avuto ampi echi sulla stessa filosofia, in particolare in ambito francese. Fu infatti Freud a sdoganare un ancora ininterrotto discorso, a tratti pruriginoso, sulle zone erogene, sancendo in maniera epocale la mancata equivalenza tra genitalità e sessualità tout court. Delocalizzare il piacere sessuale dai meri genitali per evidenziare – segreto di Pulcinella – come esso fosse diffuso e presente anche su altre parti del corpo fu un primo passo per attestare una definizione ad ampio raggio di sessualità, in cui corpo e psiche risultavano coinvolti in uno stretto dialogo.
Se il tedesco espatriato Adorno, rifacendosi anche al vissuto millenario di diaspora del popolo ebraico, a partire dalla Seconda guerra mondiale avrebbe propagandato un ideale di filosofia volutamente precaria, monadica, il cui nomadismo doveva valere come ascetica attestazione di indipendenza dai poteri gerarchici sempre inclini al totalitarismo e al sistema, è alla filosofia francese che si deve la maggiore pratica atopica e il maggior numero di riflessioni riconducibili all’atopia. Si potrebbero scomodare diversi nomi per diverse ragioni – Foucault, Lévinas, un nietzschiano come Klossowski, magari anche Barthes – ma l’esito più estremo dell’indefinibile linea atopica del pensiero novecentesco fu verosimilmente nella filosofia di Gilles Deleuze, o meglio nella prosa comune di Deleuze e Guattari. Con l’instancabile duo si arriva veramente ai confini stessi del linguaggio – e non è detto che il risultato sia costantemente apprezzabile. Si tratta altresì di un limite che codifica se stesso, che si riflette nelle analisi dei testi altrui, che offre con sorniona autoreferenza. Ora, è vero che Deleuze ha affermato, frase pure interessante, che «quando scrivo su un autore, il mio ideale sarebbe di riuscire a non dire nulla che potesse rattristarlo, o, se è morto, che potesse farlo piangere nella tomba»; ma al tempo stesso è difficile non scorgere a volte una pressoché totale sovrapposizione, per non dire sostituzione, tra l’autore di cui Deleuze scrive e Deleuze stesso, o Deleuze-Guattari quando sono in coppia.

Questo vale in modo particolare per quei passi di Kafka. Per una letteratura minore in cui Deleuze & Guattari parlano della deterritorializzazione, come nell’analisi di La metamorfosi. Nella deterritorializzazione di Gregor Samsa che diventa-animale, si risveglia scarafaggio, c’è un mero riflesso granulare di quel grandioso processo di «deterritorializzazione della bocca, della lingua e dei denti» che Deleuze e Guattari riconoscono all’opera in Kafka al livello di linguaggio. Kafka è il Paradosso. Ma non solo il paradosso cocente e per certi versi teologico, quel senso di scacco che costantemente avvertono tutti i suoi protagonisti – quello se mai è l’apice della riterritorializazione, dell’occlusione, della prigionia che in K. avvolge ogni uomo. Ebreo ceco di famiglia yiddish, Kafka è anche il paradosso di una lingua imprigionata in un linguaggio che proprio attraverso fantasie di scacco esprime la sua insofferenza radicale: «impossibilità di non scrivere, impossibilità di scrivere in tedesco, impossibilità di scrivere in un’altra lingua» dicevano Deleuze & Guattari.
Atopos non è un concetto che sembra far parte esplicitamente del ricco lessico deleuziano, ma nella deterritorializzazione che il duo postula nel Kafka e che aveva un ruolo maggiore anche in Mille piani non è forzato leggere un’ideale traduzione del concetto, più che del termine, greco – in un certo senso un primo passo, quell’essenziale sradicarsi che può poi portare a un’effettiva atopia. Non per nulla, l’atopia implica entro una certa misura un’universalità: e il suo inevitabile scacco, dalla morte di Socrate al fallimento della deterritorializzazione di Gregor Samsa che «si fa ri-edipizzare dal lancio d’una mela» scagliatagli dalla sorella gelosa «e non gli resta che morire», è sufficientemente universale perché, trasposto in materia narrativa, i racconti di Kafka risultino perfettamente comprensibili e perfettamente empatizzabili anche per un lettore che ignori la situazione specifica linguistica e sociale degli ebrei di Praga di inizio secolo.
Da Platone all’èra contemporanea, l’ideale atopico è uno dei concetti più pertinenti e peggio evasi tra quelli che la filosofia occidentale ci ha messo a disposizione per il tentativo, sempre un po’ incauto, di capire il nostro mondo. La ragione principale della stringente attualità di ogni atopos sta inscritta nel supporto stesso di cui mi servo per strutturare questo articolo: l’èra in cui viviamo, l’èra del digitale, abbandona i luoghi e la spazializzazione a favore di un regno virtuale, di una superficie. Il digitale è intrinsecamente atopos, fluido, ubiquo. Basta accendere il nostro cellulare per entrare in un mondo digitale: ma il Digitale in sé e per sé non ha luogo o localizzazione. E non c’è bisogno di Byung-chul Han per constatare che esso implichi un cambio di paradigma vertiginoso a livello psichico, sociale, topologico, mentale. Il digitale è, tra le altre cose, una silenziosa rivoluzione psicologica i cui effetti risultano al momento incalcolabili. E potrebbero arrivare a lambire, non per forza in male, la stessa logica occidentale.
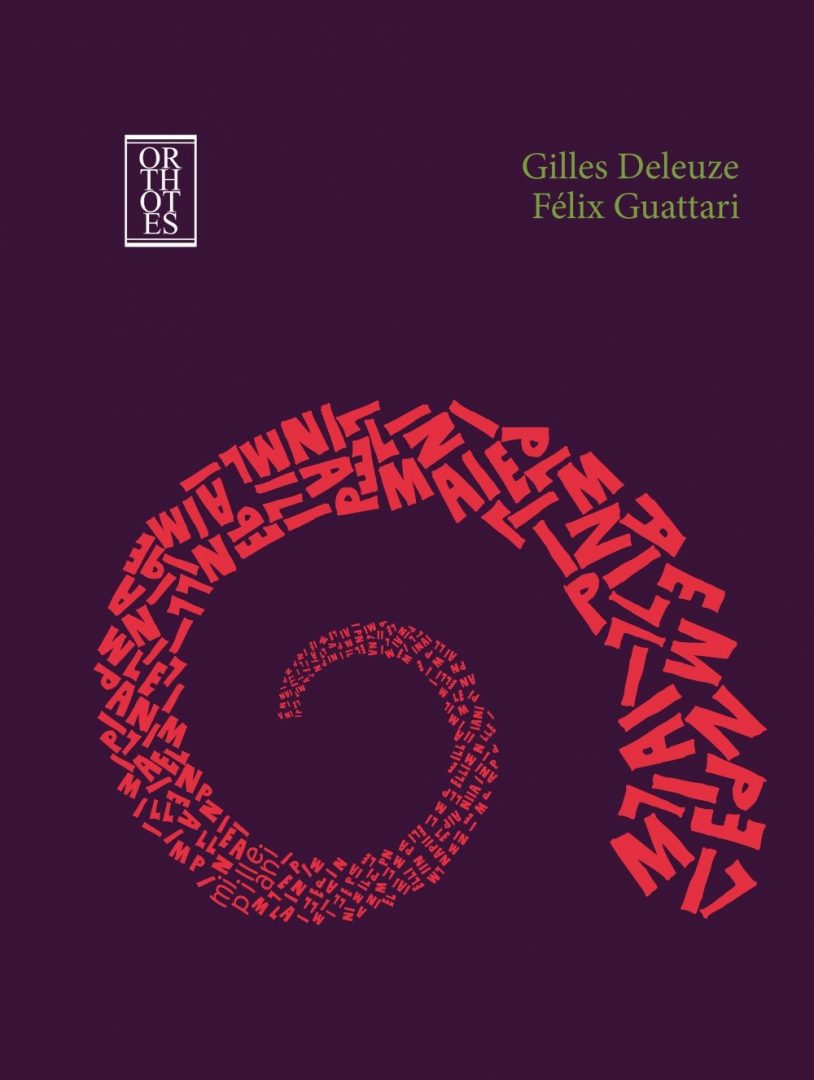
Rifiutando nella maggior parte dei casi Freud, ma appoggiandosi implicitamente su alcuni degli assunti che lui per primo ha riportato alla luce, sono alcuni movimenti queer del contemporaneo a rappresentare, forse, le più recenti ipostasi del concetto fluttuante di atopos – concetto esso stesso privo-di-luogo, conseguentemente al suo etimo. Nel rifiuto dell’eteronormatività che è la base ideologica di molti di questi movimenti di opinione e politici, si riconosce il convergente rifiuto di un ancoraggio – fisico, sessuale, corporeo, desiderativo, e quindi anche psichico – alla ricerca di una sessualità non definitiva e non definitoria. Siamo al tempo stesso in una linea genealogica diretta e in un certo scarto esistenziale rispetto alle lezioni di Foucault sul corpo – quanto una libertà sessuale che mette in discussione la tradizione normativa fino al suo approdo nel pansessualismo è effettivamente liberatoria e autentica? Quanto invece non può essere, Pasolini suffragante, un nuovo colpo di coda di un biopotere intenzionato a passare dalla repressione a un liberalismo cogente? Ciò che è atopos provoca, non sempre si sente tenuto a dare spiegazioni. Ciò che è atopos – da Socrate a noi – inquieta e affascina, ma spesso si appoggia su una logica binaria, benché accogliente: o con noi o con loro, sempre pronti però ad accettare i transfughi. Ciò che è atopos vuole essere compiaciutamente contraddittorio, certo che una contraddizione formale dell’antisistema spingerà le contraddizioni strutturali del sistema out of the closets, fuori dagli armadi. The Joke is on you.
Dall’Atene del V secolo a.C. fino alla nostra società contemporanea, digitale e delocalizzata tanto sul piano dell’industria quanto a un livello sociale e forse non più comunitario, l’atopia resta un ideale che si nega, che non si definisce, che sfugge volutamente alle sue stesse definizioni. Ciò che non ha luogo non ha categoria, non ha confini e proprio per questo non ha – o non crede di avere – paure e preconcetti. La verità o meglio la struttura è generalmente più complicata e ambigua di quello che si crede – Socrate era per certi versi manipolatorio nella sua maieutica, se vogliamo problematizzare. Al tempo stesso, proprio perché rappresenta un’antitesi radicale a quella logica delle categorie che, già presente in Platone e nello stesso Socrate platonizzato, è il fondamento del discorso occidentale, ma non per forza del pensiero – l’ideale atopico può restare un segnavia e un modello tanto per la filosofia quanto per il pensiero tout court.
«Don’t be-long, don’t be-long… please don’tyou be very long / or I may be asleep» cantava con voce sonnecchiosa il George Harrison del Magical Mystery Tour, giocando splendidamente, come solo tra i Beatles si sarebbe potuto concedere, col doppio significato omofono di be long, “fare tardi”, e belong “appartenere”. Se da questo gioco di parole si deduce arbitrariamente che appartenere significhi fare tardi, ci si ritrova a leggere in Blue Jay Way un monito estremamente risonante.
Quelli in cui Harrison cantava erano agli anni della Contestazione, di un marxismo oltremodo rigido, dell’occupazione di luoghi fisici e altamente simbolici. Erano anche anni di disimpegno, di psichedelia e di alterità, nei molteplici e a volte minacciosi sensi che il termine può assumere. Erano – a patto di non idealizzarli troppo – anni sospesi tra il rivoluzionario e l’atopico, due parenti strette della libertà che non sempre coincidono. Quella di appartenere è una scelta in linea con tutta la tradizione, con tutto ciò che si può dire sul nomos della terra, con la retorica delle radici – anche quando ci si strappa dalle proprie radici di provenienza per procurarsene di nuove, e non mi riferisco per forza solo alle “ideologie”. Più radicale sarebbe una scelta di nomadismo puro e autentico, di sradicatezza, di estraneità nel senso raramente fecondo della parola. Se appartenere volesse davvero dire “fare tardi”, in quest’epoca digitale certo nomadismo sembra essere il modo giusto per stare al passo, se non in anticipo, sui tempi – con tutte le contraddizioni che l’assenza di radici comporta.
Volenti o nolenti, una certa vaghezza atopica ci sospinge da più parti – ontologicamente, con l’avvento del digitale; politicamente, con il movimento queer, e una non cessata dialettica tra l’assenza di individuazioni e un mero moltiplicarsi delle possibilità di scelta tra diverse definizioni e diverse identità. La dimensione digitale stessa ci impone nuove categorie e nuove strutture di pensiero. Il fantasma di Socrate, che ha infestato la filosofia occidentale per tutta l’età antica e che è ritornato nella forma di moderno parresiastes alla Foucault, alla Deleuze, o alla Pasolini, resta severo e sornione nell’attesa che si recuperi il nucleo vitale del suo insegnamento, prima delle Categorie secche di Aristotele, e prima delle stesse idee platoniche. Nel concetto di atopia, il piano logico, nel senso tecnico del termine, il piano esistenziale e il piano politico coesistono fino a confondersi: anche per questo, proprio per questo atopos risulta un intraducibile ma fecondo buco nero del linguaggio, se non del pensiero stesso. Una descrizione ma al contempo un monito, del/per il mondo in cui viviamo.
Illustrazione copertina di Ludovico Cantisani
