Un paio di scarpe appaiate vicino all’uscio e una vaschetta di macinato a scongelare nel lavello, i Sorrisi e Canzoni sotto al televisore, i libri di Sveva Casati Modigliani e la Settimana Enigmistica, le soap opera e i Bellissimi di Rete 4. Ogni lutto è accompagnato da un inventario, da un catalogo di oggetti lasciati intoccati, più che effetti personali veri e propri amuleti, tracce ultime di un passaggio sulla terra, unici punti di congiunzione tra la vita e la morte.
Chi assiste alla morte e vi sopravvive custodisce oggetti, parole, fotografie e scampoli di memoria per tenere viva e vicina la persona perduta. Quando tutto finisce, sopravvivono le cose. Anche se impolverate, anche se impoverite dall’entropia, le cose sopravvivono e si fanno testimoni del tempo. Le case resistono alla fine di chi le ha costruite e così diventano gli unici appigli, l’unica prova di un’esistenza ormai passata. Così, nelle prime righe di Diario di un dolore, C.S. Lewis scrive: «Ho il terrore dei momenti in cui la casa è vuota». Tutto in quella stanca dimora parla della moglie defunta: ogni oggetto, ogni angolo di luce, ogni stanza. E a lui, vedovo e superstite, non resta altro che riempire gli spazi senza contaminarli o mistificare gli umori della moglie.
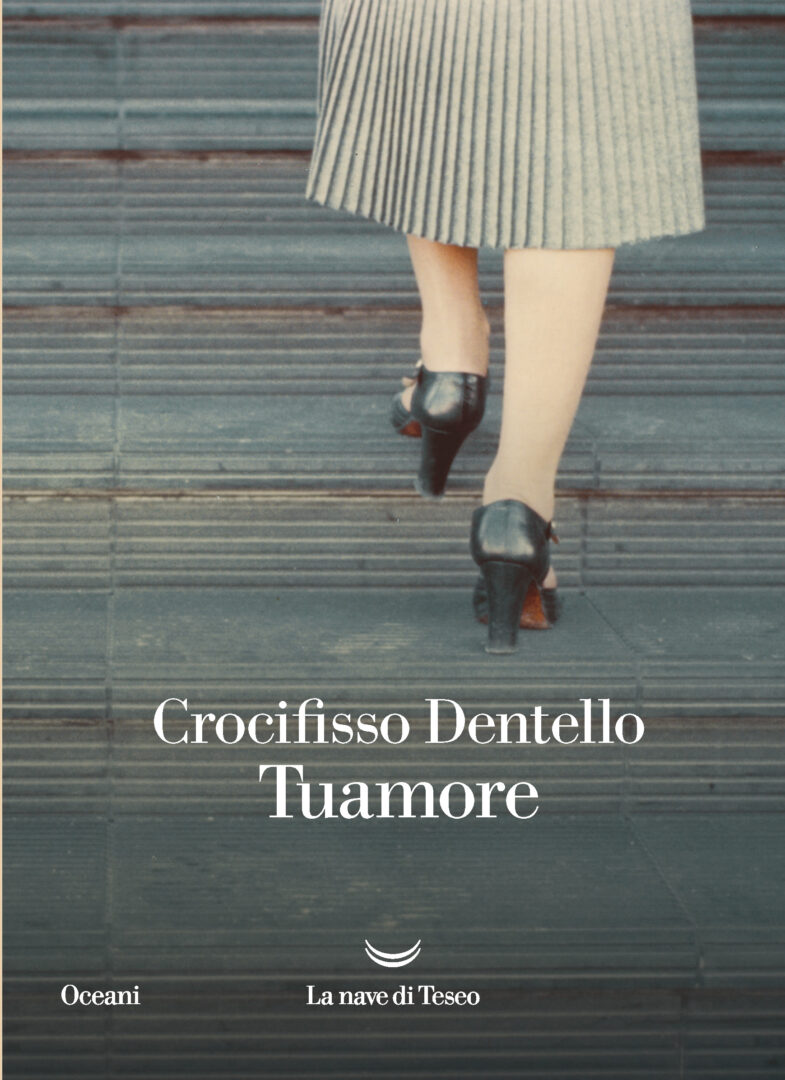
Allo stesso modo, Crocifisso Dentello in Tuamore (La Nave di Teseo) fotografa le stanze della sua casa per catturare e custodire l’armonia lasciata dalla madre. Ogni cosa al suo posto, un ordine immutabile, una geometria riconoscibile, tutta una geografia di passi e movimenti che dà l’illusione di mantenere Melina ancora in vita, ancora un po’, ancora lì in quelle stanze, che sono il palcoscenico della sua persona nonché il proscenio di una storia famigliare. Melina, al secolo Carmela, è la madre dell’autore e dei fratelli, genitrice attenta e devota. Cresce nel profondo Sud intriso di quella rigidità patriarcale che la consegna all’altare giovanissima, incinta di Crocifisso, il primogenito al quale spetta il nome del nonno in segno di una devota adesione al lignaggio tipica di un’Italia che, anche se non sembra, sopravvive. Melina è la madre dell’Italia proletaria degli anni Settanta, la donna che si reinventa, che dimette i panni della casalinga per dedicarsi al lavoro e alle faccende remunerative. I soldi non bastano mai e Melina allora piega la schiena e ruggisce contro i politici di destra che sente dal televisore. Con coraggio e ironia, accanto a un uomo che c’è ma vive defilato, cresce i suoi figli e custodisce la casa, le chiavi di quel nido famigliare intinto di nebbia brianzola. Nei brandelli di tempo libero, Melina scherza e ride fragorosamente, prende in giro figli e marito, si commuove davanti ai classici del cinema e gioca con i nipoti.
Una vita come tante, in fondo. Se felice o no non possiamo dirlo noi, però una vita comune a tanti, comune a tante. Poi un giorno la diagnosi di cancro al seno e tutta l’estenuante trafila che ne consegue: terapie, ospedali, aghi, interventi chirurgici, degenze, il corpo che cambia, il corpo che si avvizzisce, il seno che sanguina, il respiro che si affanna. Quella con il cancro è una lotta durata anni, una lotta che Melina non ha mai terminato, che anche oggi continua. Dentello afferra la penna e combatte, compie il miracolo di rendere eterna sua madre, trasformandola in un personaggio letterario. Bonaria e metistofelicamente simpatica, Melina è una Santa e una Madre Coraggio, un po’ Elena Fabrizi e un po’ Francesca, la protagonista di I ponti di Madison County.
La scrittura, come sempre, ha il potere dell’astrazione e dell’assoluto. Tutto permane tra le parole, tutto sopravvive e si fa esperienza comune, immaginario collettivo, sentimento condiviso. Così Melina, grazie alle parole del figlio, rimane accanto a lui, rimane tra noi, nell’appartamento di Cesano Maderno che l’ha vista spegnersi e perdere controllo del proprio corpo, delle proprie gambe, della propria uretra. Sempre lì con il televisore acceso a scongelare il macinato, a sbeffeggiare il figlio e a bisticciare con il marito. E così, con le stesse parole, il dolore di Dentello – un dolore assoluto che mette in dubbio il senso stesso del vivere – rimane personalissimo e al tempo stesso si fa universale. È il dolore della perdita, la sofferenza che va di pari passo con lo smarrimento del non sapere che indirizzo dare all’amore.
Tuamore è una tanatografia in cui ogni grafema ha il potere di piegare il reale, per quanto si possa, per quanto si riesca. E per quanto si riesca, ogni grafema esiste per battagliare contro la morte. Il tumore non esiste più, esiste il tuamore. Una lettera, la prima delle vocali, cambia la morfologia di una parola e la risemantizza. Una sola lettera non sconfigge la malattia, ma forse contribuisce a esorcizzarla, ad accettare l’inaccettabile. La malattia cede il passo all’amore che è stato, che sarà per sempre. L’amore di una madre per il figlio, quello di un figlio per la madre, l’amore per un corpo appena nato e quello per un corpo malato, livido e malconcio. Persino l’amore per un corpo esanime.
Nel rendere conto dello spegnimento di Melina, Dentello si racconta e racconta il bambino, poi il ragazzo e l’uomo che è stato. Timido e lontano da ogni socialità, dedito all’affetto di una madre con la quale condivideva il suo spazio-tempo e tutta la sua vita, nonostante incomprensioni e scarti culturali. E scrivendo della fine, Dentello scrive anche dell’inizio, della spaccatura da cui tutti nasciamo e in controluce, di rimando, racconta qualcosa che riguarda tutti noi. Tuamore è un omaggio e un grido ostinato, il simbolo di una rivolta, un gesto d’amore inarrivabile.
Photo credits
Copertina – Victoria Strukovskaya tramite Unsplash
