«[…] le foglie presero a sollevarsi dall’erba e a rincorrersi nell’aria in raffiche ordinate come sotto il getto di una pompa da giardino: si levavano e planavano e ancora si levavano in un’infinità di motivi, e tutto era incantevole e bellissimo e proprio come dovrebbe essere».
(H. Garner, Piccoli preludi)
Si apre con un’ecfrasi Piccoli preludi, il secondo romanzo di Helen Garner, pubblicato per la prima volta in Australia nel 1984, e finalmente tradotto in italiano per nottetempo da Milena Sanfilippo, a cui dobbiamo anche la traduzione dell’esordio del 1977, Come piombo nelle vene, uscito l’anno scorso sempre per nottetempo. È l’ecfrasi di una fotografia che ritrae il poeta vittoriano Alfred Tennyson insieme alla moglie e i figli nel giardino della loro casa sull’isola di Wight: un ritratto di famiglia che Dexter, uno dei numerosi protagonisti di Preludi, ha affisso alla parete della cucina, luogo reale e simbolico in cui si svolge la maggior parte della storia. La fotografia «è lì da tanto ormai. Non fa che sfaldarsi, oscillare sbilenca, penzolare da un angolo. Ma ogni volta, proprio quand’è sul punto di cadere, qualcuno la salva, qualcuno la riattacca». La fotografia è uno specchio in cui Dexter e tutta la sua famiglia – moglie e due figli, proprio come il poeta – può riconoscersi; un’immagine rassicurante che rappresenta un passato a cui tenersi ben ancorati, e «Dexter per il passato ci andava proprio matto». Ma per quanto ancora resisterà attaccata al muro, offrendosi come un monito? Non è piuttosto quel suo penzolare presagio di un cambiamento imminente?
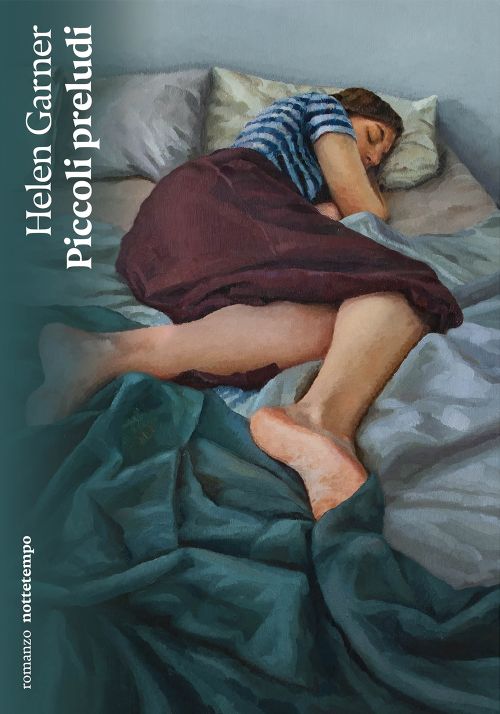
La voce narrante in terza persona la definisce «un’immagine spiazzante per l’osservatore odierno»: forse per l’immobilità impacciata delle figure umane tutte avvolte, tranne il poeta, in «paralizzanti indumenti»; o forse per «la tragicità dei volti dei genitori»; o ancora per la distanza della figura paterna dal resto del gruppo; tutti dettagli che ritorneranno nella novella, intrecciata a tal punto alla fotografia da apparire una naturale prosecuzione delle traiettorie meste e perse degli sguardi di Tennyson e i suoi familiari. Eppure all’inizio del libro Dexter e Athena Fox sembrano una coppia felice che ama passeggiare insieme la sera, dopo aver messo a letto i figli, e godersi finalmente il tempo per chiacchierare e raccontarsi la propria giornata. Anche la casa in cui vivono, seppure minuscola e sgangherata, è una tana accogliente e felice. Ma se la felicità di una famiglia, come suggerisce il celebre incipit di Anna Karenina, è facilmente riconoscibile – «le famiglie felici si assomigliano tutte» – più difficile è coglierne l’infelicità.
In che modo la famiglia Fox sia infelice lo scopriamo nel momento in cui Dexter incontra, dopo vent’anni, la vecchia amica Elizabeth. Morty, come la chiama Dexter, irrompe nella vita dei Fox, spazzando via ogni certezza; non a caso la voce narrante ci fa subito sapere che Elizabeth detesta il passato. Attraverso lo sguardo impietoso di Elizabeth veniamo innanzitutto a conoscenza della disabilità di Billy, uno dei figli di Dexter e Athena, affetto da una grave forma di autismo che ha minato l’equilibrio familiare, e soprattutto ha scardinato il sistema di accudimento materno fino a svuotarlo: «Un tempo», dichiara Athena, «pensavo che intrappolata dentro di lui ci fosse una creaturina selvatica, buona, con cui cercavo di comunicare. Ma adesso so che…» Si bussò sulla fronte con le nocche. «… non c’è nessuno in casa».
Per colpa di Elizabeth Morton dentro la piccola cucina dei Fox fanno irruzione anche la sorella minore, Vicky, rimasta sola dopo la morte della madre, e l’ex amante Philips con la figlia Poppy. Otto personaggi, dieci se contiamo i genitori di Dexter: tante voci da gestire nello spazio di un romanzo breve, qual è Piccoli preludi, con il risultato voluto e finemente ricercato di mettere in scena uno spazio claustrofobico, in cui sembra impossibile fuggire nonostante ognuno cerchi di farlo; in cui tutto viene messo in piazza e l’intimità è continuamente violata. Ma non è spesso così che funzionano i legami familiari, e più in generale i legami che ci fanno sentire protetti e forti e nel contempo fragili e scoperti?
Con una tecnica che ricorda il tunneling process di Virginia Woolf, Garner entra nei pensieri dei suoi personaggi, scava caverne scoprendone i nervi, mostrando il baratro che si nasconde dentro ad ognuno, complice una lingua lapidaria, che non fa sconti. L’unico lirismo concesso è nelle descrizioni dei cieli, del vento, delle nuvole, di quel “fuori” in cui i personaggi, soprattutto Athena, cercano una boccata di ossigeno, una fuga. Un “fuori” diverso da quello tentatore rappresentato invece dal concerto rock in cui Athena viene invitata da Philip, mentre Dexter invece si rifugia nell’abitacolo della macchina aspettandola; o il fuori rappresentato dalla città di Sidney, in cui Athena si ritrova a camminare da sola, dopo aver seguito sempre Philip (del quale si è nel frattempo invaghita) rischiando di perdersi. Ma forse Athena si era già persa: la corazza dell’antica dea non le è servita a proteggersi, semmai a chiudersi ancora di più dentro un silenzio impenetrabile. E però Garner ci conduce dentro i suoi pensieri più reconditi, come nel passo in cui Athena legge gli annunci esposti nella vetrina di un’agenzia immobiliare sognando altre vite possibili:
«Athena abitava, almeno il tempo di leggere un annuncio, in ciascun cottage assolato, affascinante appartamento vecchio stile, casa ariosa, pittoresca villetta a schiera, ampia camera con balcone e camino, alloggio collettivo dagli orti rigogliosi. I suoi figli si smaterializzavano, suo marito moriva di morte indolore precipitando da una montagna. E che tende che avrebbe cucito! L’ordine privato che avrebbe stabilito e mantenuto, i fiori che avrebbe sistemato a manciate dentro i barattoli di Vegemite, il sonno dolce e profondo di cui avrebbe goduto, e tra lenzuola così fresche!»
Nonostante il romanzo sia corale, è Athena il fuoco di Piccoli preludi. È lei che suona i piccoli preludi di Bach, il Bach che si dà ai bambini per cominciare a suonare, appunto Children’s Bach, che è poi il titolo originale del romanzo (la stessa Garner aveva iniziato a suonare il piano con quello spartito a quarant’anni). Ma «Preludi a cosa, poi? Persino sotto le sue dita inesperte quei semplici accordi suonavano come un grido di trionfo, e lei si precipitava a infilare il viso accaldato fuori dalla finestra». Preludi e fughe si alternano continuamente nel romanzo.
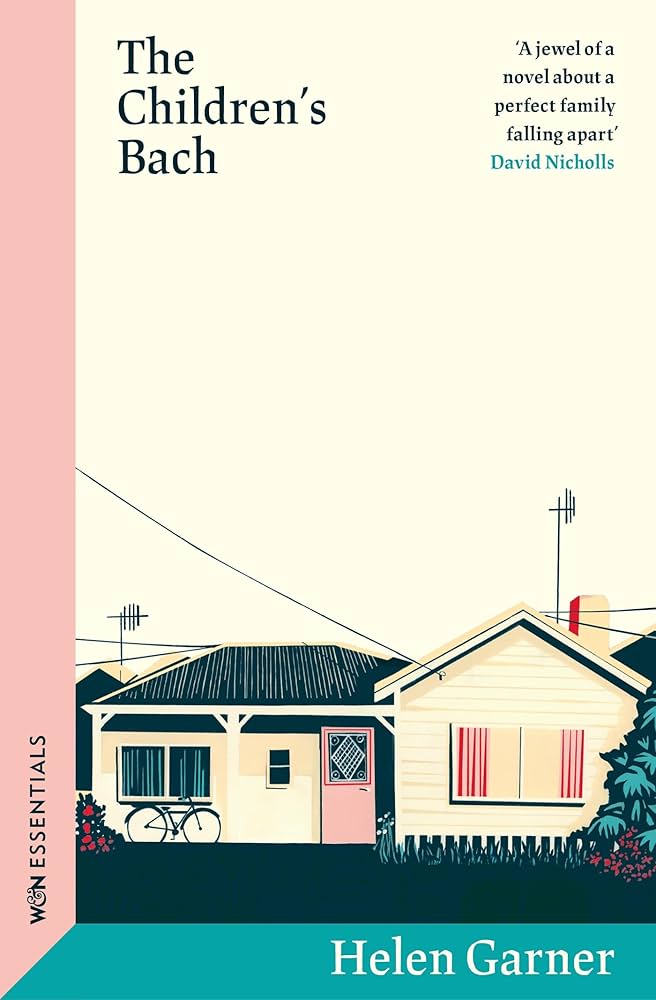
Quando Elizabeth invita Athena a suonare, a mostrarle come «padroneggia» Bach, Vicky interviene osservando che «suona come un topo». Athena difatti non padroneggia Bach e tuttavia sarà proprio Elizabeth a incoraggiarla ricordandosi una frase che la propria madre ripeteva spesso: «il bosco sarebbe molto silenzioso, se a cantare fossero solo gli uccelli che cantano meglio». Un invito di Elisabeth a perseguire i propri desideri, nonostante i risultati, a non vergognarsene? In effetti Elizabeth sembrerebbe non conoscere il pudore… La musica pervade la novella, diventa una metafora: la musica classica versus quella rock, l’antico versus il moderno, il passato versus il presente. Garner gioca con queste dicotomie, ribaltandole continuamente, così come il personaggio di Athena viene costruito come l’opposto di Elizabeth, sebbene i ruoli si mostrino imprevedibili e reversibili, tanto che alla fine del romanzo la terribile Morty ci appare la più sobria della compagnia.
In realtà tutto è più difficile di quello che sembra, e la scrittura di Garner ci restituisce la complessità: il bianco e nero non esistono, e neppure i buoni e i cattivi; i contorni sono sfumati, i confini porosi. La stessa Athena all’inizio ci appare una custode perfetta del focolare domestico a cui i suoceri regalano un bel ferro da stiro nuovo, nonché una donna equilibrata e protettiva che Vicky sogna come madre, ma poi, procedendo nella lettura, affiorano i desideri più profondi e irrazionali che la agitano. E negli occhi della moglie di Tennyson «incastonati in orbite profonde» riconosciamo quelli della moglie di Dexter.
Athena rifugge l’accudimento, come si è già potuto evincere dalle parole riservate al figlio Billy, ma in Garner il giudizio è assente. Se il domestico è il regno di Athena, è vero anche il contrario: la casa rappresenta un riparo, ma pure una prigione. Nella scelta di Athena e Vicky di abbandonare il coniglio, che i Fox tenevano in una gabbietta vicino al bagno, possiamo allora leggere il rifiuto dell’accudimento ma anche l’impossibilità di ritornare alla “libertà”, una volta che si è stati addomesticati. Il coniglio sul prato, che vuole ritornare nella sua gabbietta invece di fuggire, riflette la condizione esistenziale di Athena: l’infelicità del coniglio è l’infelicità della stessa Athena.
Gettarsi nelle braccia di Philip, lasciarsi andare al desiderio amoroso che divampa incendiando ogni cosa, non risolve i conflitti interiori. Se è vero che «Uno non dovrebbe vergognarsi di desiderare l’amore», come si legge in Come piombo nelle vene, il desiderio rimane un’arma a doppio taglio su cui la scrittura di Garner continua a interrogarsi.
«Amore!” tuonò Dexter. «Allora io non sono mai stato innamorato. Amour. Non so neanche cosa significhi. Che c’è di tanto divertente?»
«Un giorno lo scoprirai,» disse Elizabeth.
«Non capisco perché la gente creda che trovare l’amooour sia inevitabile,» replicò Dexter. «Chiunque lo vedrebbe come una specie di piaga, o di malattia. Le persone si innamourano solo perché ne hanno letto in qualche giornaletto di cartastraccia americano, perché lo desiderano, perché s’annoiano e non hanno di meglio da fare. Io non voglio, pertanto non lo farò».
«E di Athena non ti sei innamorato?» disse Vicki, scandalizzata.
«No,» fu la risposta di Dexter. «Non con quel tormento di cui leggete voi».
Vicki lanciò un’occhiata ad Athena, temendo che l’avesse ferita, invece lei sorrideva e ascoltava.
immagine di copertina creata con AI
