Sarà pur vero che oggi più che mai viviamo in un’epoca in cui solo la tecnica potrà finalmente offrirci la consapevolezza della fragilità nostra e del nostro pianeta, ma sarà ancora una volta la letteratura a renderne disponibile il racconto. Sentiamo da due anni almeno, come voci di Cassandra, gli uni e gli altri, raccontarci la “svolta” delle nostre vite con l’avvento dell’intelligenza artificiale, in ogni campo dello scibile umano, in ogni parte dell’umano senza alcuna distinzione tra anima e corpo ma questo di Labatut è il primo libro, almeno per me, a tentare una genealogia appassionante di tale rivoluzione tanto cruenta quanta necessaria, per capire da dove si era partiti.
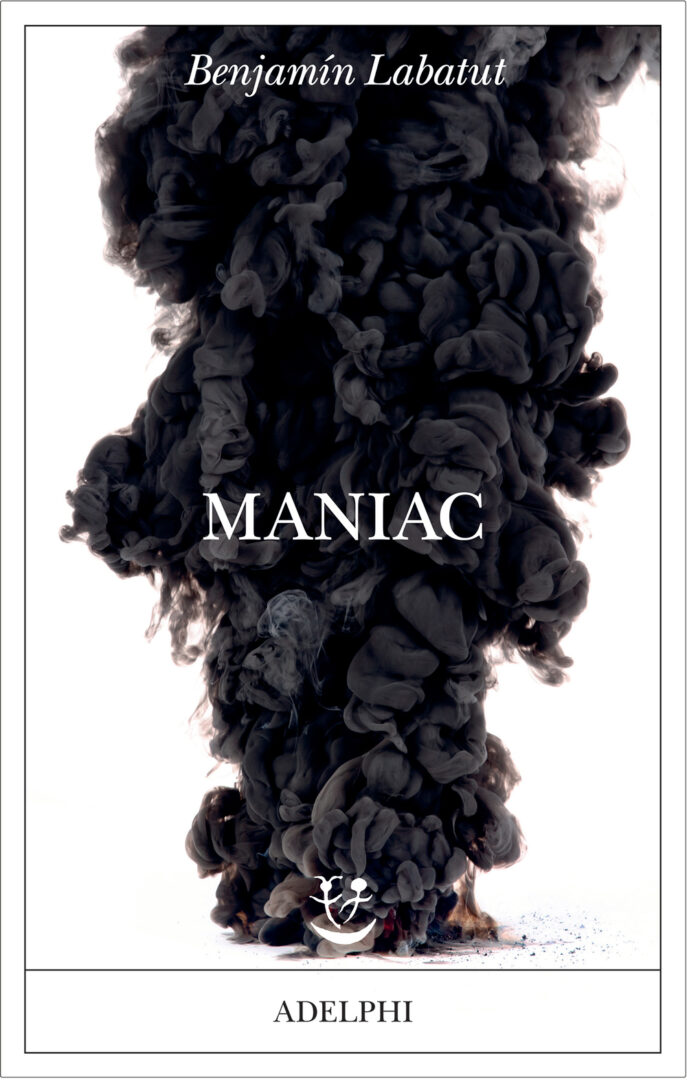
Dalle prime pagine di questo romanzo (Maniac, Adelphi, nella traduzione di Norman Gobetti) vivamente consigliatomi dall’amico Miguel Gallego, sentiamo una profonda tensione tra vita e tecnica, una guerra senza esclusione di colpi, combattuta da eroi, generalmente scienziati, alle prese con le scoperte che hanno cambiato la storia dell’umanità, con tanto di nome e cognome e fatti che potremmo definire storici.
«Tutto ebbe inizio con un telaio meccanico, e devo dire che si trattava di un apparecchio mostruoso. Sembrava proprio la macchina sognata da Franz Kafka nel suo racconto Nella colonia penale, quella che incide sul corpo del condannato il comandamento che ha trasgredito: un gigantesco insetto metallico con diecimila zampe, che ingurgitava istruzioni e secerneva fili di seta come un vecchio ragno deforme. Papà l’aveva portato a casa per farcelo vedere.»
A pagina settanta di questo “curioso” libro di Benjamin Labatut si racconta della scoperta, fondamentale per il celebre matematico von Neumann, di un telaio a schede perforate. Sono andato a riprendere l’incipit del racconto in questione e un dubbio non affatto inessenziale è sorto su come fosse stato tradotto in due versioni differenti. Poiché si trattava di un’opera in tedesco ho chiesto lumi alla mia amica Silvia Bortoli, germanista:
Silvia cara assai, mi servirebbe una piccola tua consulenza traduttoria. Nel racconto La colonia penale di Kafka, l’incipit in francese dice “c’est un appareil singulier”, in quella italiana credo, perché ho consultato una versione on line pirata, “è una macchina veramente curiosa”, tu come l’avresti tradotto?
Io avrei tradotto “è un apparecchio singolare”. È una versione fedele. Così lo traduce anche Andreina Lavagetto (Feltrinelli), ma Anita Rho, grande traduttrice della generazione precedente, che traduceva con maggior libertà e maggiore attenzione all’efficacia narrativa, ha tradotto con “è veramente una macchina curiosa”, e ritmicamente è migliore di quella che hai trovato tu, che pure le assomiglia.
Apparecchio, che come ci ricorda la Treccani è “nell’uso tecn. e scient., complesso di elementi di varia natura, meccanici, elettrici, ecc., coordinati in modo da costituire un dispositivo atto a un determinato scopo”.
Apparecchio dunque ma anche congegno narrativo, dispositivo, telaio, trama, ordito, filo, per rimanere alla “macchina” che strega una delle menti più brillanti del secolo breve, come ci viene raccontato da Eugene Wigner, Premio Nobel per la fisica nel 1963.
“Ho conosciuto Planck, von Laue e Heisenberg. Paul Dirac era mio cognato, Leo Szilard e Edward Teller sono stati fra i miei più cari amici, e anche Albert Einstein era un buon amico. Ma nessuno di loro aveva una mente rapida e acuta come quella di János von Neumann. L’ho affermato diverse volte in loro presenza, e nessuno mi ha mai dato torto.
Solo lui era del tutto vigile.”
Leggendo capitolo dopo capitolo questa incredibile prova di Labatut non si può non pensare al grande Marcel Schwob, e in particolare a due opere. Sicuramente, Vite immaginarie, e a seguire La crociata dei bambini. Il primo per la dimensione programmatica della bio-fiction, vero e proprio manifesto su come “romanzare” la vita degli altri, famosi o meno che siano; il secondo per aver saputo come pochi illustrare quello strano episodio del 1212, all’insegna del frammento di Eraclito tra i più oscuri e sorprendenti: «Il tempo è un bambino che gioca, che muove le pedine; di un bambino è il regno».
Scrive Schwob:
«Ed è proprio su questo che si fonda l’arte del biografo: sulla scelta. Non deve essere vero; deve creare una congerie di tratti umani. Leibnitz dice che per creare il mondo, Dio ha scelto il migliore tra i mondi possibili. Come una divinità inferiore, il biografo è in grado di scegliere, fra i possibili umani, ciò che è unico. Non deve ingannarsi sull’arte, non più di quanto Dio si sia ingannato sulla bontà. È necessario che l’istinto di entrambi sia infallibile. Pazienti demiurghi hanno raccolto per il biografo certe idee, certi movimenti fisiognomici, certi fatti. La loro opera è sparsa nelle cronache, nelle memorie, negli epistolari e negli scolii. In mezzo a questo arruffio il biografo sceglie ciò che gli serve per dare vita a una forma che non somiglia a nessun’altra. Non serve che essa sia simile a quella che fu creata un tempo da un dio superiore, basta che sia unica, come qualsiasi altra creazione.»
La sensazione che si ha leggendo Maniac è che Benjamin Labatut abbia seguito alla lettera le indicazioni di Schwob, programmando la sua makina anagramma di maniak ben al di là della bibliografia proposta nelle ultime pagine, esplorando ognuno degli interstizi offerti in quell’immensa documentazione a disposizione.
In altri termini non commette l’errore di molti biografi di credersi storici privandoci, per quella strana ambizione alla scientificità del dato oggettivo, di quanto v’è di più essenziale nella vita e soprattutto nell’arte del romanzo:
«E così ci hanno privato di mirabili ritratti. Hanno creduto che solo la vita dei grandi uomini potesse interessarci. L’arte è estranea ad analisi di questo tipo. Agli occhi del pittore il ritratto d’un perfetto sconosciuto, fatto da Cranach, ha lo stesso valore di quello di Erasmo. Non è grazie al nome di Erasmo se quel quadro è inimitabile. L’arte del biografo dovrebbe consistere, piuttosto, nel dare lo stesso risalto sia alla vita d’un povero attore che a quella di Shakespeare. È un bieco istinto che ci fa constatare con piacere la contrazione del muscolo sternomastoideo nel busto di Alessandro, o il ciuffo in testa nel ritratto di Napoleone. Il sorriso di Monna Lisa – per quanto ne sappiamo potrebbe anche essere un uomo – ha un che di ben più misterioso.»
Enfant prodige
In ognuna delle tre parti che compongono il polittico immaginato da Labatut troviamo la parola Wunderkind.
«Quindi c’era un alieno in mezzo a noi, un vero Wunderkind, e a scuola tutti parlavano di lui. Dicevano che aveva imparato a leggere a due anni».
Per il piccolo von Neumann, che ebbe un ruolo fondamentale nella costruzione della Bomba Atomica prima e nella rivoluzione informatica poi, risuona nel lettore il frammento eracliteo, del bambino preso dal suo stesso gioco, come quando, da adulto bambino è alle prese con il MANIAC, ovvero la loro macchina Mathematical Analyzer Numerical Integrator And Computer.
«Se ne sta acquattato come un ragno ingordo sulla tela che unisce tutti gli interessi militari e governativi.
Uno dei suoi insulti meno pesanti.»
I protagonisti vengono descritti, raccontati, messi sovente a nudo, da quanti ne costituiscono il vero mondo di relazioni sociali e vitali: qui è la moglie che lo racconta, la prima o la seconda, un collega di laboratorio, un concorrente, l’amico anche se è il più delle volte dai nemici che arriva al lettore il tassello decisivo. Come nella Crociata dei Bambini di Schwob, il nudo fatto si veste delle narrazioni di ognuno dei protagonisti o semplici testimoni dei fatti: il goliarda, il lebbroso, i bambini, il Papa, il mendicante o la piccola Allys.
Sappiamo da Klára Dán von Neumann, dopo un esilarante scambio di vedute del suo John con Albert Einstein e di cui lasceremo al lettore la scoperta, come per lui la vita fosse soltanto un gioco, un terribile gioco da prendere sul serio. Ed è grazie ad uno dei suoi eccessi che scopriamo la più insostenibile delle verità con cui uno scienziato deve misurare la propria coscienza. Non è allora questione di agire nel mondo con una doppia morale, come nella recente opera cinematografica dedicata a Oppenheimer da Christopher Nolan, ma di ammettere una volta e per tutte che quando si fa una scoperta non è possibile tornare indietro.
«Quello che stiamo creando» disse «è un mostro la cui influenza cambierà il corso della storia, sempre che una storia continui a esserci! Ma sarebbe impossibile non andare fino in fondo. Non solo per ragioni militari, ma anche perché non sarebbe etico, da un punto di vista scientifico, non fare quel che sappiamo di poter fare, per quanto le conseguenze possano essere terribili. E questo è solo l’inizio!».
È un passaggio chiave a mio avviso perché permette di capire cose altrimenti insostenibili dal punto di vista etico. Ricordo perfettamente quando in una piacevole conversazione con un mio compagno di liceo diventato medico, in cui gli raccontavo dei miei studi sulla “questione della colpa nella Germania Nazista”, mi parlò del suo manuale, credo di fisiologia, se non ricordo male – ma non ne ho trovato conferma in rete – del Favilli, che riportava a proposito delle conoscenze della medicina sull’ipotermia come queste fossero state acquisite sulla pelle dei deportati nei campi di concentramento.
Ricordo allora la stessa domanda – ma non le risposte – sulla legittimità di tali scoperte, su come si potesse “approfittare” di tale abominio. Non è affatto un mistero che il peggiore istinto dell’uomo, nell’esercizio dell’arte della guerra, abbia nella storia prodotto invenzioni micidiali, armi terribili, con il solo scopo di dominare la vita degli altri, ma un mistero rimane su come le stesse abbiano provocato come effetti collaterali beni preziosi per l’umanità. Le prime riprese cinematografiche dei Fréres Lumière, come ci ricorda la studiosa Violaine Challéat, facevano riferimento a scene militari, così l’energia atomica o la stessa Rete Internet, inventata in piena guerra fredda. Von Neumann ci dice che sarebbe perfino non etico rinunciare alla verità di una scoperta, a prescindere dalle idee e azioni che l’hanno resa possibile. MANIAC è figlio delle menti di Los Alamos, l’IA la piena realizzazione dell’avventura.
« “Con la creazione della bomba atomica i fisici hanno conosciuto il peccato, ed è una conoscenza che non possono più perdere”. Questo aveva detto Oppenheimer.»

Un gioco da ragazzi
Grazie a Labatut scopriamo che a Los Alamos coloro che avrebbero fabbricato il più grave assalto al cielo da che storia era storia giocavano spesso a scacchi prima di lasciarsi sedurre da un altro gioco più antico e importato dall’oriente, il GO. E scoprirà il lettore l’incredibile storia della famosa partita dell’Atomica, quella giocata dall’allora campione in carica di GO, Utaro Hashimoto, contro lo sfidante Kaoru Iwamoto, il 6 Agosto del 1945 a Hiroshima.
«Nel go tutti i pezzi hanno lo stesso valore; non ci sono pedoni o torri, cavalli o alfieri, re o regine, solo pietre bianche e nere che contano tutte allo stesso modo.»


Se nel primo capitolo abbiamo seguito, passo dopo passo, la parabola tragica di Paul Ehrenfest, il primo ad aver sfidato la tirannia del Logos, pioniere della meccanica quantistica, è nella lunga parte centrale dedicata a von Neumann che accade l’inevitabile anche se il lettore potrà sedersi davvero al tavolo di gioco soltanto nel terzo capitolo. Per la terza volta l’autore impiega la parola Wunderkind:
«AlphaGo era il parto della mente di Demis Hassabis, un Wunderkind della zona nord di Londra che aveva quattro anni quando vide il padre – un cantautore nonché proprietario di un negozio di giocattoli greco-cipriota – giocare a scacchi con lo zio. Chiese loro se gli potevano insegnare a muovere i pezzi sulla scacchiera, e un paio di settimane dopo nessuno dei due era più in grado di sconfiggerlo.»
Nelle ripetute sfide tra giocatori in carne e ossa e macchine pensanti raccontate con estrema grazia da Labatut – splendidamente tradotto da Norman Gobetti – si rimane davvero incantati come quando si assiste ad un gioco che non si conosce affatto ma che ci coinvolge attraverso l’estrema precisione con cui i giocatori lo vivono. L’illusione – stare nel gioco, in ludum – sembra moltiplicarsi da sé, il gioco vivere di vita propria, come nel racconto poco noto di Walter Benjamin Rastelli racconta…

Rastelli è un mago che ha un solo numero, semplicissimo e meraviglioso, che consiste nel far eseguire a una palla movimenti e volteggi con le sole note di un flauto dotato di poteri sovrumani. Quando viene presentato alla corte di un sultano che nulla perdona e molto offre a chi fosse stato in grado di divertirlo, accade il fatto. Nessuno sapeva il trucco del mago, che consisteva nel dirigere la palla grazie a un nano che, in una simbiosi perfetta con la sfera e le note del suo padrone, invisibilmente creava quel gioco. La sera del tanto temuto spettacolo Rastelli, pur avendo percezione di qualcosa di terribile, esegue alla perfezione il suo numero riuscendo così ad avere salva la vita e ottenere un lauto premio dal committente. Quando all’uscita del palazzo attende il complice nano per felicitarsi, accade che al posto di questi si presentasse trafelato un messaggero che quasi lo assale in mezzo alle guardie:
«”Vi ho cercato dappertutto, signore, – gli disse. – Ma Voi avevate lasciato le vostre stanze anzitempo, e non mi è stato concesso di accedere al Palazzo”. Ciò dicendo mostrò una lettera autografa del nano. “Caro maestro, non siate in collera con me, – c’era scritto. – Oggi non potete esibirvi dinanzi al Sultano. Io sono malato e non posso lasciare il letto”».
Appassionante l’ultima sfida all’ultima pietra, tra il Wunderkind Lee Sedol e AlphaGo. Quando la macchina ha sfidato il bambino e ha vinto, quando abbiamo scoperto che Dio stava per tornare sulla terra.
