Lo schwa (/ə/) non è tra i trenta fonemi con valore distintivo in italiano, anche se è utilizzato, per esempio, in alcune varietà dialettali dell’italiano standard: in napoletano, come desinenza, e in piemontese, in posizione intervocalica. È un fonema dell’IPA (International Phonetic Alphabet) e indica una vocale media centrale del quadrilatero vocalico; per capirci, è il suono iniziale dell’inglese about. In italiano è stato introdotto/proposto da circa tre anni per superare il binarismo del genere grammaticale italiano (maschile vs femminile), e garantire cittadinanza (grammaticale) a tutte le persone non binarie.
Negli ultimi tempi, il dibattito attorno al fonema ha assunto toni da stadio e/o da inquisizione. Se lo usi sei un amante del politicamente corretto, se lo critichi sei un misoneista, un conservatore della prima ora. Discorsi che lasciano il tempo che trovano: potrei usare lo schwa per paventare il mio progressismo e riempire Instagram di insulti omofobi con un profilo fake. In questo senso, lo schwa non ha alcun valore, non rilascia nessuna patente di inclusività. Va analizzato il piano (socio)linguistico per capirci qualcosa, costi e benefici, e se per caso esistono soluzioni linguisticamente migliori. Teniamo a mente: è un significante (lo schwa senza il suo significato), che è solo un intermediario del significato (ciò che le parole, i suoni, le lettere vogliono dire), nonostante abbiano un rapporto indissolubile (il fenomeno dell’isologia); caricarlo di un valore semantico a priori è problematico. In ogni caso, è il rapporto tra linguaggio, identità, società/realtà che dobbiamo rimettere al centro del discorso, non le tifoserie, non opinionisti e opinioniste. Mi sembra sia la stessa intenzione di Così non schwa. Limiti ed eccessi del linguaggio inclusivo (Einaudi, 2022), il recente saggio del linguista Andrea De Bendetti, con il quale ho avuto l’opportunità di discutere dell’intento – senza dubbio nobile e, secondo me, da condividere – dello schwa e dei “danni” linguistici che, a suo parere, si porta dietro.
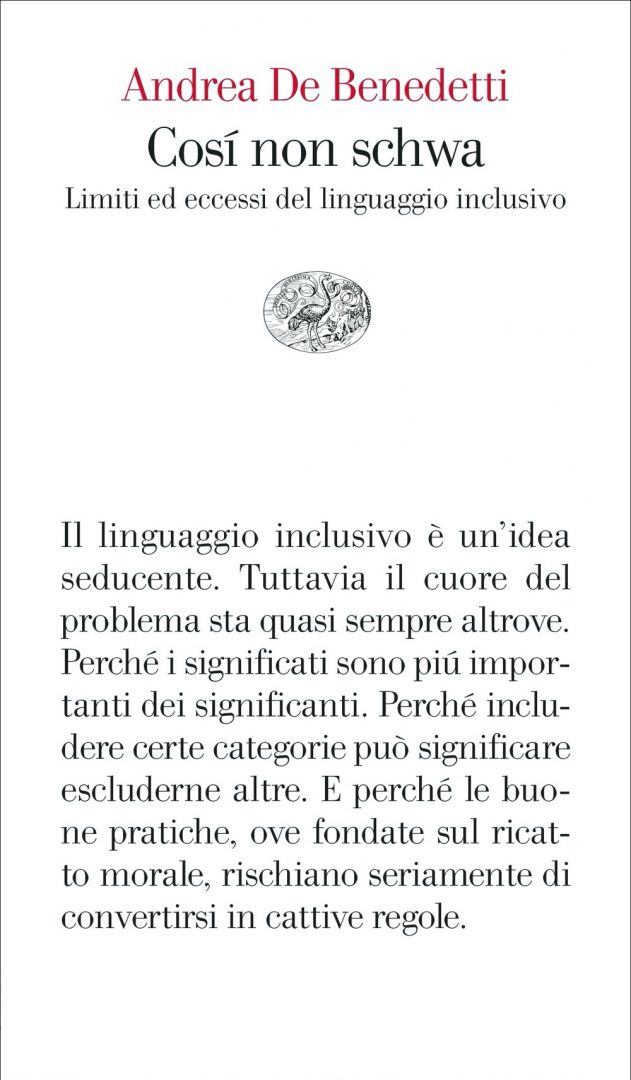
Ci può riassumere, dal suo punto di vista, quali sono le criticità irrisolvibili che determina l’utilizzo dello schwa a livello morfologico e perché ritiene che il meccanismo dell’accordo grammaticale – che in italiano è un fenomeno pervasivo per quasi tutte le classi di specificatori, cioè articoli, dimostrativi, possessivi[1] – sia tra queste?
Dal mio punto di vista, una dei problemi linguistici che determina l’utilizzo dello schwa è la (re)introduzione del neutro in una lingua, l’italiano, che l’ha perso, com’è noto, nell’evoluzione dal latino volgare. Dunque, una forma di regressione – seppur alle nobili origini latine – della lingua a uno stadio più complesso, quello a tre generi grammaticali. Ma le lingue, una volta in mano ai parlanti, tendono al contrario a semplificare, in nome del cosiddetto principio di economia formulato da André Martinet; ed è, in effetti, ciò che se ci pensiamo è accaduto alla storia dell’italiano, che nel suo percorso evolutivo dal latino alle lingue romanze ha perso, oltre al genere neutro, per esempio una coniugazione verbale o il complesso sistema dei casi. Insomma, i parlanti semplificano per diminuire il carico cognitivo che serve per parlare/comunicare. In questo senso, lo schwa – che non si userebbe solo coi nomi ma anche con gli aggettivi, gli articoli, i pronomi, le preposizioni ecc. – determinerebbe una ristrutturazione completa della codifica dell’accordo del genere che, assieme a quella del numero, è tra le più complesse a livello di acquisizione linguistica, com’è dimostrato, per esempio, dagli studi di Maria Chini; c’è il rischio concreto che la platea di persone con accesso limitato alla lingua (penso agli stranieri – in Italia sono sei milioni – ma anche ad esempio alle persone dislessiche), che quindi sarebbero escluse da questa ricablazione linguistica, sia numericamente più grande della platea di persone che lo schwa includerebbe.
Del manuale fondamentale Linguaggio e genere (Carocci editore, 2006), ricordo che il sistema del genere, nella fase più antica dell’Indoeuropeo (da cui deriva anche l’italiano), prevedeva due classi: animato e inanimato; la formazione di un terzo genere o classe, quello dei semianimati, che poi sarebbe diventato il femminile, è successiva. L’evidenza di tale ipotesi è che «i nomi femminili sono in buona parte caratterizzati dalla presenza di un suffisso, mentre maschili e neutri non lo sono». Ora: il fatto che il genere femminile sia una «costola» di quello maschile, come scrive lei stesso, è una prova in quale direzione? Glielo chiedo provocatoriamente: la lingua è uno strumento ontologicamente patriarcale?
È possibile che sia così, entro certi limiti, e non per tutte le lingue, ma credo possa valere per quelle di origine indoeuropea. Dopodiché, mi permetto di dire, che dobbiamo fare? Smontiamo tutto? Inventiamo da capo una lingua che non lo sia? Perché se il principio da seguire è di rimuovere tutte le tracce linguistiche del patriarcato, la conclusione è che serve una lingua nuova. Credo, parallelamente, una volta riconosciute queste tracce – ed è importante – si debba anche comprendere che si tratta, come nel caso della gemmazione del femminile, di un “banale” fenomeno linguistico. Nel saggio faccio l’esempio del cosiddetto singular they, la soluzione – qui i benefici superano i costi: non stravolge la morfologia, non modifica le abitudini dei parlanti, non fa riferimento al sesso – che è stata adottata in inglese per riferirsi alle persone non binarie; tuttavia, they deriva da un pronome, l’antico norreno peir, che in origine era maschile, eppure in questo caso nessuno ne tiene conto, e anzi il pronome è usato per rompere le barriere di genere. Mi sembra, quindi, che non conta ciò che le parole significano, ma conta ciò che, in una determinata narrazione – quella non binaria – devono significare. Solo che la lingua non funziona così.
Altrettanto interessante è la questione delle lingue prive di genere grammaticale: «Hai voglia a ricordare che in molti Paesi dove si parlano lingue prive di genere grammaticale, per esempio Turchia o Iran, le donne se la passano abbastanza peggio rispetto allo omologhe nostrane». Insomma, un conto è l’uso del linguaggio, un conto il linguaggio?
È così: un conto sono i significati, un conto sono i significanti, le rispettive connotazioni culturali e le intenzioni con cui li utilizzo e in quale contesto. Dare troppa importanza ai significanti può far pensare che sia la lingua a determinare l’identità, ma non è così, eventualmente la rispecchia, la codifica.
L’italiano – lo sostengono personalità autorevoli, come per esempio il linguista Paolo D’Achille, accademico della Crusca – ha già la sua soluzione per un linguaggio inclusivo: il maschile non marcato o sovraesteso. Lei, a riguardo, scrive: «Secondo una diffusa corrente di pensiero, questo [il maschile non marcato] costituirebbe un privilegio, una forma di discriminazione nei confronti di chi non è maschio, in realtà è semplicemente un dispositivo morfologico del tutto desemantizzato che aiuta i parlanti a gestire in maniera snella il sistema degli accordi». Dunque, ritenere che la relazione «tra lingua e società va[da] in una direzione […], dalla società alla lingua, non viceversa[3]» è erroneo? Lo è in egual misura, supporre che il linguaggio sia «in grado di escludere della società determinate persone semplicemente non nominandole[4]»?
Che piaccia o meno, e se sia determinato dal patriarcato o no, l’italiano ha grammaticalmente un genere prototipico che è il maschile, ed è un tratto che nel corso del tempo si è progressivamente desemantizzato. Per cui se il mio vicino sta male in aereo e chiedo “c’è un medico a bordo?”, sono sicuro che anche una donna risponderebbe all’appello.
Riguardo al rapporto tra società e linguaggio, sono stati versati fiumi di inchiostro e mi sembra si tratti di discutere se sia venuto prima l’uovo o la gallina. Io non nego il fatto che la lingua possa dare forma al mondo, ma credo che le cose iniziamo a nominarle nel momento in cui esistono. Voglio dire, il nome precede la cosa, non può essere altrimenti, le cose nascono prima delle parole, mi sembra incontrovertibile. Però, è altrettanto vero che contribuiamo a dare forma al mondo nel momento in cui associamo dei significati a dei significanti, che in certi casi possono portare fuori strada, dare vita a stereotipi. Questo è il problema. Ma non sono le parole di per sé a creare queste realtà; noi non creiamo le persone non binarie dando loro una desinenza, loro esistono già e per fortuna si fanno sentire, perché si sono aperti degli spazi, non perché è stato introdotto lo schwa.
Uno degli studi più interessanti citati in Così non schwa è quello di Chiara Cettolin, docente dell’Università di Trieste. Riassumo lo studio. Cettolin ha proposto a un campione di 150 persone un questionario per valutare l’uso del maschile non marcato e la sua influenza sulle rappresentazioni mentali delle persone; le consegne erano, per esempio, «Elenca tre conduttori tv» e/o «Elenca tre conduttori o conduttrici tv». Cettolin, data la predominanza di persone di sesso maschile nelle risposte, asserisce che siamo più portati «a immaginare persone di sesso maschile», anche laddove il quesito è sdoppiato. Da ciò, Lei ne ricava che «evidentemente non è tanto questioni di desinenze, ma di stereotipi, di imprinting culturali». Le chiedo: lo studio di Cettolin è una (ulteriore) piccola prova che l’ipotesi Sapir-Whorf[6] – nota come relativismo linguistico, secondo cui, in estrema sintesi, il modo di parlare influenza il modo di pensare la realtà – non funziona?
Lo studio è molto interessante, ma credo che non se ne possa ricavare un’unica conclusione; ciò che si evince di sicuro è che i maschi hanno più spazio nel dibattito pubblico. Io ho riproposto l’esperimento in classe con la parola «cantante», ambigenere, e i cantanti maschi citati sono comunque stati più numerosi. Il punto, credo, è che ci vengono in mente più maschi non per il genere grammaticale della parola, ma per la loro visibilità sociale. Pensiamo al femminile di medico. Dovrebbe essere medica, ma è usato pochissimo; ciononostante, in Italia, le donne che svolgono la professione di medico hanno sopravanzato i maschi. Questo per dire che non è vero che se non c’è un nome non esisti.
Questa è la citazione di Tiziano Scarpa che chiude il saggio: «Le parole non ci rappresentano. Nessuna parola, mai. Nella diffidenza verso le parole, lì sta il nostro posto nel mondo: che non è dentro le parole, ma nell’ombra che le parole gettano di fianco a se stesse». Quindi, con Wittgenstein, ogni problema filosofico non è un problema linguistico?
No, io credo che sia anche un problema linguistico, perché è difficile dire le cose, qualunque cosa. È difficile raccontarsi, identificarsi, spiegarsi. Quello è il problema: riuscire cioè a far coincidere ciò che pensiamo con ciò che diciamo, e non ci riusciamo mai. È sempre un lavoro che procede per approssimazione, ma è una frattura che vale qualsiasi sia l’identità di genere in cui ti riconosci.
Vorrei salutarla e ringraziarla chiedendole una sorta di prescrizione, come si fa dal medico. Ho letto ad amici e amiche quel passo del suo saggio in cui sostiene che se si asseconda la sperimentazione dello schwa, allora qualsiasi altra sperimentazione simile futura, proposta da una nuova minoranza che non si sente rappresentata dallo schwa (né dal maschile né dal femminile) dovrà essere accolta. Un meccanismo per lei – per molti – impensabile, e, senza dubbio, problematico. Tuttavia, la riposta di molti amici e amiche attiviste è stata che accogliere ogni minoranza, ogni input inclusivo, è proprio ciò che dovremmo fare; a noi che importa se un fonema aiuta a far sentire riconosciuto qualcuno? Dunque, Le chiedo, da linguista, qual è la strada – se c’è e se ha senso percorrerla – da intraprendere per rendere l’italiano più inclusivo?
Penso si potrebbe introdurre – come buona pratica e non come regola – un pronome – loi, lai, qualcosa del genere – che, come nell’esempio inglese, il sistema linguistico potrebbe reggere senza grossi problemi. Però, ripeto, senza che diventi un pretesto per “multare” le persone. Se io mi dimentico di usarlo non significa niente. Bisogna sempre considerare che uno si può sbagliare in modo del tutto preterintenzionale. Ultimamente, invece, si attribuiscono cattive intenzioni a cose che non ce le hanno affatto. In alcune università americane ci sono addirittura degli uffici deputati ai pronomi, che sanzionano chi non usa quelli giusti. Un’idea che sembra partorita da Orwell in persona.
Bibliografia
CETTOLIN C. (2020), Ma se parlo al maschile, le vedi le donne? Maschile non marcato e visibilità femminile, in https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/31186/1/2_italiane-italiano.pdf
CHINI M. (1995), Grammatiche a confronto: la categoria grammaticale del genere nella competenza di nativi italofoni e nelle interlingue di apprendenti dell’italiano come L2, in L’universo delle lingue e grammatiche nella scuola (pp. 277-94)
LURAGHI S., OLITA A. (2006), Linguaggio e genere, Carocci editore, Roma
MARTINET A. (1966), Elementi di linguistica generale, Laterza, Roma-Bari
GHENO V. (2021), Chiamami così, Il margine, Trento
RENZI L. (2012), Come cambia la lingua. L’italiano in movimento, Il Mulino, Bologna
SAPIR E. WHORF B. (2017), Linguaggio e relatività, Castelvecchi, Roma
[1] Andorno C., Accordo di genere e animatezza nell’uso del sistema pronominale italiano: ipotesi per uno studio, in Linguaggio e genere (pp. 124-142)
[2] V. Gheno (2021), Chiamami così, Il margine, Trento
[3] Ibidem
[4] Cfr. Sapir E. Whorf B. (2017), Linguaggio e relatività, Castelvecchi, Roma
Photo credits
Jason Leung tramite Unsplash
