«È impossibile leggere una riga di Kleist senza pensare che si è ucciso.
È come se in lui il suicidio avesse preceduto l’opera.»
(Emil Cioran, L’inconveniente di essere nati)
«Il suicidio ci obbliga a trovare la nostra posizione individuale sulla questione di fondo: essere o non essere. Il coraggio di essere (come ci si compiace di dire oggi) non significa semplicemente scegliere la vita nel mondo. La vera scelta è scegliere sé stessi, la propria verità individuale.»
(James Hillman, Il suicidio e l’anima)
«La domanda infatti non era: perché si è ammazzato?
La domanda era: perché vivete ancora?»
(Lukas Bärfuss, Il Koala)
Nel 2011, per ben due volte, Lukas Bärfuss, scrittore, saggista e drammaturgo svizzero, si ritrova su un treno che lo condurrà nella sua città natale; in entrambe le circostanze l’occasione del viaggio è la stessa, ossia un suicidio: prima quello del poeta tedesco Heinrich Von Kleist, avvenuto nel 1811 a Berlino, sul quale era stato invitato a tenere una conferenza, e poi, a distanza di soli sei mesi, quello del proprio fratello, soprannominato Koala, «appellativo segreto e totemico» che Bärfuss sceglierà come titolo del suo originale e intenso romanzo autobiografico uscito nel 2014 e da poco pubblicato in Italia dalla casa editrice L’Orma nell’attenta traduzione di Margherita Carbonaro.
«L’avevo chiamato un paio di settimane prima per informarlo della mia visita», scrive l’autore nella prima pagina del libro riferendosi al fratello maggiore, «benché fossi certo che il contenuto della mia conferenza, l’opera oscura e talvolta del tutto incomprensibile di un poeta tedesco della fine del Settecento, l’avrebbe interessato poco». Sono righe che risuonano come un oscuro presagio, soprattutto quando, appena qualche pagina dopo, apprendiamo del tragico gesto del fratello. Così appare e resta inquietante e insieme incomprensibile il legame che si instaura tra i due suicidi: d’altra parte non è lo stesso suicidio un gesto indecifrabile?
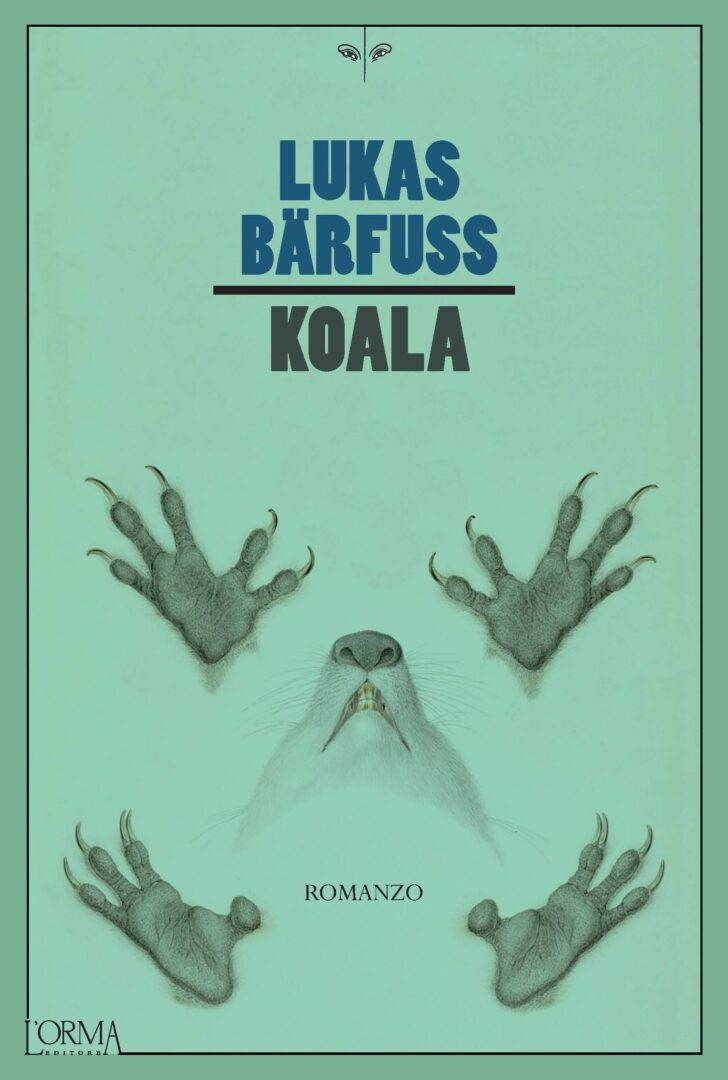
L’esperienza della morte, essendo sempre morte dell’altro, è di per sé impossibile. In più, se già la morte ci spinge a rileggere la vita della persona scomparsa nel tentativo di comprenderla fino in fondo, a rivedere al rallentatore i frammenti di una esistenza rimontandone i pezzi al contrario, come suggerito dal passo di Cioran posto in esergo a questa riflessione, la morte per suicidio sembrerebbe indurci, più delle altre morti, a rinvenire tracce, che svelino e persino giustifichino un gesto spiazzante e scomodo, ritenuto da molti addirittura empio perché infrange la sacralità della vita su cui la nostra società si regge.
Di fronte al suicidio del fratello, con cui lo scrittore ha un rapporto sporadico e principalmente fatto di silenzi, Bärfuss raccoglie e accosta indizi, disseminandoli sapientemente nel testo, in modo da suggerire allo stesso lettore legami inaspettati: «Ogni parola deve essere riesaminata, ogni parola deve essere soppesata». Sin dall’inizio chi legge è coinvolto, direi trascinato in questo processo, spinto a osservare tutti i segnali, a soffermarsi su ogni singolo dettaglio evocandone il segreto simbolismo, a svelarne i raffinati riferimenti artistici e letterari: così il colore azzurro della bicicletta su cui Bärfuss vede montare il fratello nella sua ultima apparizione da vivo, un «azzurro cielo» in una «azzurra serata di primavera», o ancora il rosso della giacca di pelle che indossa dentro la vasca mentre attende l’effetto dell’iniezione mortale – immagine quest’ultima che lo perseguita perché gli è stata raccontata, e l’unico modo che ha per poterla vedere è attraverso il filtro dell’arte: vera e propria ecfrasi della Morte di Marat di David, la scena del suicidio del fratello, però, si contraddistingue per il colore rosso che diventa l’elemento predominante, quasi evocativo delle versioni successive firmate da Munch e Picasso. Del resto sin dall’inizio del libro l’appello all’arte e alla letteratura è molto presente, come a voler sfidare la medesima oscurità e insondabilità di ogni gesto suicida: «Il suicidio parlava per sé, non aveva bisogno di una voce, e non aveva bisogno di un narratore».
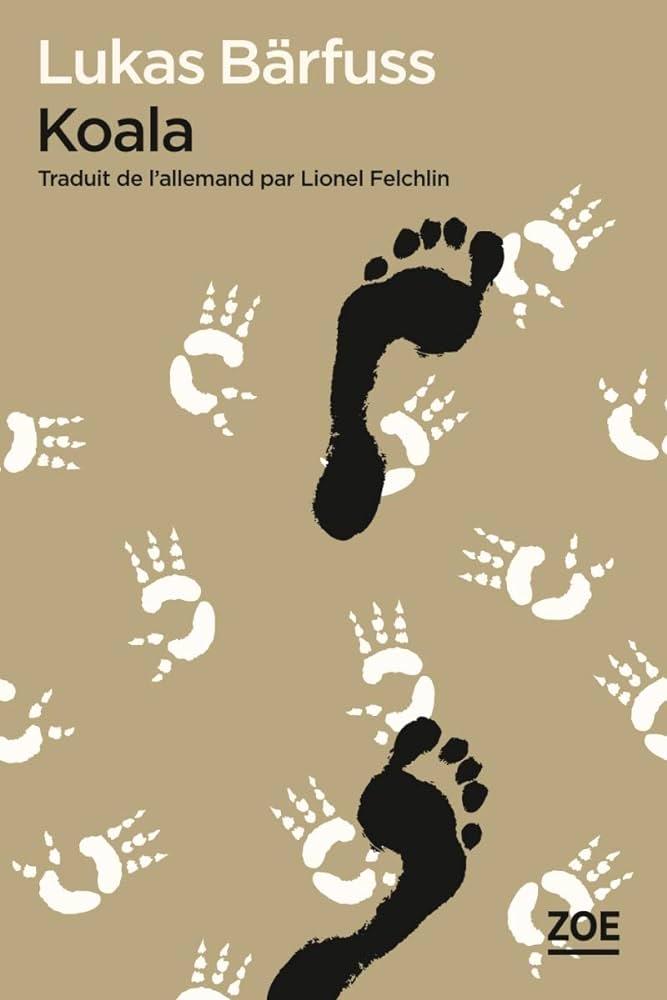
Di fronte alla morte del fratello, Bärfuss ripercorre, come in un copione, gli stati d’animo e le reazioni scatenate dal lutto di un suicida: la tirannia dell’immagine del morto che sovrasta quella del vivo, la violenza scatenata dalla sua presunta inettitudine, l’orrore e insieme la rabbia per quel gesto percepito come vigliacco e crudele in quanto getta inevitabilmente su chi resta l’ombra di una remota responsabilità, e la sensazione che con un suicida i conti non si chiudano mai.
Il suicidio strappa il velo di Maya rivelando la solitudine che si annida nella vita di ciascuno di noi, solitudine che lo scrittore riconosce come causa dell’infelicità, malattia del nostro tempo: «Alla fine ognuno era solo, lo avvertivo, e in tutti i giorni c’era una fine». Così, a partire da una questione privata, Bärfuss si sposta a considerare i meccanismi perversi e violenti che contraddistinguono la società contemporanea, e da romanzo autobiografico e indagine intima sull’esperienza della morte il Koala si trasforma in una lucida disamina della nostra storia attraverso un racconto – vero e proprio resoconto d’avventura – che ci conduce nel cuore della sanguinosa colonizzazione dell’Australia. Questo passaggio non sarebbe stato possibile senza la misteriosa figura del koala, «una creatura che bussava alla finestra e non mi lasciava dormire, con le orecchie coperte di pelo, stoico per non dire letargico, e che voleva dirmi qualcosa ma non sapevo cosa, non dava risposte, era semplicemente lì».
Con un colpo da prestigiatore, l’autore ci mette improvvisamente davanti agli occhi l’immagine del fratello sovrapposta a quella del koala che sin dalle prime apparizioni si intuisce essere molto di più di un semplice soprannome: il primo legame evidenziato è rappresentato da una ciotola, quella piena di veleno posta dai colonizzatori ai piedi di un albero per uccidere l’animale e quella di porcellana in cui il fratello conservava l’hashish, prima di tagliarla e pesarla per venderla; a questa prima associazione si aggiunge il ritrovamento di un quaderno di seconda elementare dello stesso Bärfuss, avvolto in una carta guarda caso ancora rossa, sulla cui copertina è stampata l’immagine dell’animale. Semplici coincidenze? Lo scrittore inizia così a interrogarsi sui motivi che avrebbero spinto i compagni scout del fratello a battezzarlo con quel soprannome, rivelando in questa scelta una sua natura segreta, «la sua autentica sorte». Quale però?
Spinto dalla curiosità di indagare questo legame, Bärfuss ripercorre la storia del koala che per venti milioni di anni, prima dell’incontro con i primi cacciatori, aveva vissuto senza un nome, intrecciando la sua esistenza agli struggimenti amorosi del tenente Ralph Clark e alle esplorazioni di Francis Barallier, l’uomo che per primo si impossessò di due zampe di koala e le mise sotto spirito.
«L’animale era una preda troppo facile. Non era necessario nessuno sforzo per cacciarlo, nessuna astuzia e nessun piano. L’animale non si difendeva, non correva via, i cacciatori scuotevano l’albero e quello gli cadeva ai piedi. Lo ammazzavano, lo mangiavano e provavano vergogna».
C’è qualcosa nell’indolenza e nell’inermità del koala che infastidisce gli esseri umani, autorizzandoli alla sopraffazione: «Chi non combatteva non aveva il diritto di vivere». Così, suggerisce Bärfuss, funziona anche la nostra società. Contro la retorica di un lavoro che ci sta rendendo sempre più miseri e malati, che colonizza ogni spazio della nostra vita, la pigrizia del koala (animale e fratello) ci indicherebbe una via diversa, contemplativa, di stare nel mondo che rappresenta «una difesa di un diritto all’ozio, al rifiuto del lavoro», come ribadisce Miguel Benasayag in L’epoca dell’intranquillità, citando a sua volta il filosofo italiano Giuseppe Rensi.
«Maestro di sapienza, anche di politica», come lo ha definito Alessandra Pigliaru, l’immagine del koala può inoltre offrirsi come un vero antidoto alla solitudine, consentendoci con il suo abbraccio rampicante e lanoso di «tornare all’osso dello scambio, prevedere la prossimità dell’incontro con l’altro […] considerare il benessere della vicinanza quando qualcuno si affida all’inermia dell’abbraccio».
