A parte le letture d’infanzia, fra cui il prodigioso Pinocchio che solo molti anni dopo mi è apparso per quello che è, ossia il capolavoro inarrivabile della narrativa italiana dell’Ottocento, il primo vero libro che ho ricevuto in regalo è stato Cuore.
Certi zii milanesi erano venuti in visita alla mia famiglia, alla vigilia del Natale del ’67, e mi avevano portato il pacco fatale. Tolta di mezzo la carta rimasi ammirato davanti alla copertina morbida del libro, che riproduceva il viso di un bambino molto bello e dolce. Fra parentesi non so dove sia finita quella copia, ora. Ho il sospetto che dorma da qualche parte nella cantina della casa dei miei genitori, sepolta sotto vecchi quaderni scolastici e altri volumi formativi come La Bibbia per il bambino, una strepitosa riduzione dei testi sacri a pura narrazione d’avventura, che anticipava il consiglio di Umberto Eco: buttare via salmi e prediche e reintitolare il tutto I disperati del Mar Rosso. Quel giorno, leggendo il risvolto, appresi che il protagonista si chiamava Enrico e che aveva la mia età: otto anni.
Ero ancora intento a sfogliare il libro quando voci squillanti mi convocarono davanti all’assemblea degli adulti. Lasciai Cuore in camera e raggiunsi il tinello che mia madre si ostinava a chiamare soggiorno, dove trovai tutti seduti intorno al tavolo.
«E allora?» chiese mia madre. «Sei contento del regalo degli zii?»
La mia ambiziosa mamma bergamasca veniva da una famiglia di Lumpenproletariat dove pestare i bambini era il meno, e riproduceva con impegno filologico gli scenari della sua infanzia, riempiendomi ogni giorno di schiaffi, quando andava bene, o valendosi di altri strumenti atti all’uopo. Ripensando ora alla struttura di Cuore e ai suoi leggendari racconti mensili, direi che a otto anni avevo già abbastanza materiale narrativo per aggiungere a Sangue romagnolo un titolo come, non so, Educazione bergamasca. Mia madre usava con me questa perversa pedagogia: in mia presenza minimizzava i miei successi scolastici e lavorava su insicurezze e ansia da prestazione; intanto, a mia insaputa, annoiava parenti e vicini di casa ripetendo che ero un genio destinato a orizzonti grandiosi. Il risultato era che si ritrovava in casa un disadattato, antipatico a tutti i genitori di figli “normali” e sogguardato con diffidenza dai coetanei.
«Sì,» borbottai.
«Hai detto grazie?»
«Sì.»
«Ti hanno regalato un bel libro, hai visto?»
«Eh, sì.»
«E come si intitola, questo libro?»
«Mmh… Il cuore degli amici.»
Sghignazzi fragorosi degli zii e sguardo incendiario di mia madre. Conoscevo bene quello sguardo: «I conti li facciamo dopo, io e te». Il genio in erba si rivelava un tontolone, o più esattamente un povero bambino che dimorava in un tale deserto relazionale da avere rielaborato in quel modo ridicolo la combinazione autore + titolo della copertina.
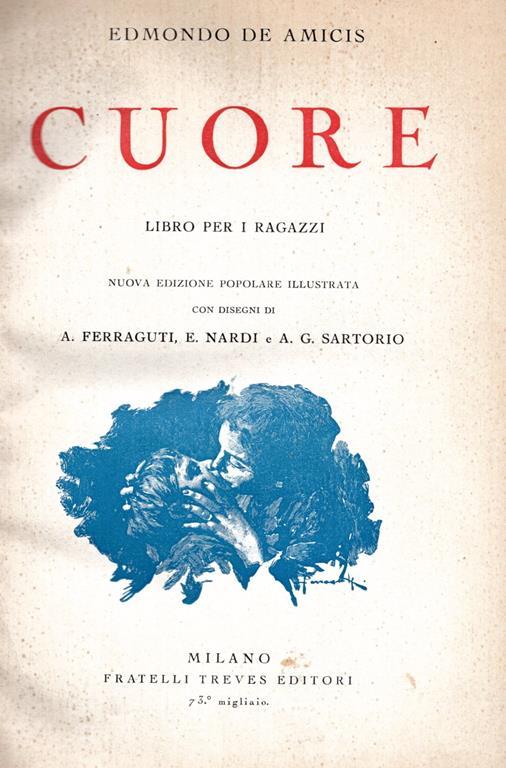
Alla lettura il libro mi piacque immensamente. Mi piace ancora oggi: si sa, i libri per ragazzi bisognerebbe leggerli da adulti, per capirli davvero. Infatti lo rileggo più o meno ogni sette o otto anni, come alternativa a Tre uomini in barca di Jerome. Jerome mi fa squartare dal ridere, mi riconcilia con la vita; De Amicis mi incanta con il suo infinito talento narrativo e drammaturgico.
Il libro infatti è pieno di scene potenti, incisive, giocate su conflitti esplosivi, rappresentate con un’icasticità che tende addirittura al visionario. La sequenza nella Torino invernale, imbiancata, di Garoffi che senza volerlo colpisce un vecchio con una palla di neve e si ritrova circondato da una folla inferocita. Quelle casupole, quegli appartamentini miserabili ma dignitosi di cui pare di sentire l’odore, dove i compagni di Enrico, tutti meno agiati e meno pigri di lui, studiano nei cantucci, sui tavoli da cucina. La visita all’Istituto dei Sordomuti, che mi impressionò moltissimo. La sequenza del teatro e in generale tutte le scene affollate, le più difficili da scrivere.
E naturalmente Franti, futuro beniamino del già citato professor Eco. Franti il violento, lo sbeffeggiatore digrignante, il giovane teppista sadico che potrebbe benissimo essere uno dei droogs di Arancia meccanica: l’irruzione precoce del male. La madre di Franti che piomba in classe per supplicare che il figlio non venga sospeso, lasciando intravedere uno scenario di violenze domestiche che bastano a spiegare tutto:
«…affannata, coi capelli grigi arruffati, tutta fradicia di neve, spingendo avanti il figliuolo che è stato sospeso dalla scuola per otto giorni… si gettò quasi in ginocchio davanti al Direttore giungendo le mani, e supplicando: – Oh signor Direttore, mi faccia la grazia, riammetta il ragazzo alla scuola! Son tre giorni che è a casa, l’ho tenuto nascosto, ma Dio ne guardi se suo padre scopre la cosa, lo ammazza…»
Mentre la madre, uscita dritta da Zola o dai fratelli Goncourt, supplica il direttore, Franti tiene «il viso basso, impassibile». Ma quanto è fico Franti? Quanto mi conturbava Franti, prima di leggere L’isola del tesoro e capire che il mio vero modello per il futuro sarebbe stato Long John Silver? Infine la povera donna se ne va, «raccogliendo lo scialle che strascicava, pallida, incurvata, con la testa tremante, e la sentimmo ancor tossire giù per le scale». E qui De Amicis trova nella chiusa una sintesi manzoniana, alla pari con epigrammi incisi nel marmo della memoria collettiva, quali «la sventurata rispose» o «l’uomo si vide perduto»:
«Il Direttore guardò fisso Franti, in mezzo al silenzio della classe, e gli disse con un accento da far tremare: – Franti, tu uccidi tua madre! – Tutti si voltarono a guardar Franti. E quell’infame sorrise.»
Già che ci siamo, all’epoca non ero in grado di capirlo ma solo di sentirlo: l’uso devastante che fa De Amicis dei nomi espressivi. Sono quei nomi che, oltre a designare un personaggio, ne suggeriscono la professione, il carattere, e che fin lì avevo incontrato leggendo Topolino: Pico de Paperis, Archimede Pitagorico e tutta una moltitudine di figure come Pietro Gambadilegno, l’entomologo dottor Ditterus, l’idraulico Tubi e così via.
Il lavoro di De Amicis è più sfumato, diremmo subliminale, ma irresistibile.
Precossi, anagramma di Percossi, il bambino malmenato dal padre. Nobis, il giovane aristocratico che avrebbe potuto chiamarsi Nobilis. Stardi, il testardo… o De Amicis aveva in mente l’inglese sturdy? Il buon maestro Perboni, che già introduce, a fianco dell’ammiccamento puramente lessicale (perbene, perbenoni) il tocco raffinato del fonosimbolico, del suono che evoca una forma: Votini, l’invidioso, è sì «vuoto», ma quel diminutivo plurale, quelle “i” puntute e aguzze, non suggeriscono un’angustia dell’animo e una magrezza sgradevole, un corpo e un viso scarnificati dal troppo spiare le fortune altrui? Che differenza non solo con Perboni ma soprattutto con Garrone, dal suono ampio, rotondo, vibrante di quella doppia “r” che evoca un gattone che fa le fusa o forse un cagnone che brontola, amichevole – e non a caso il maestro, passando accanto al suo banco, gli batte una mano sul collo «come a un buon torello». E appunto Franti: l’affranto, il franto, lo spezzato, il disarmonico; ma anche frantic. Come potrebbe uno che si chiama Franti avere i capelli a posto, con la scriminatura di lato o meglio ancora una patriottica pettinatura “all’umberta”?

I racconti del mese mi parvero naturalmente i picchi narrativi del libro, anche se alcuni erano in realtà le pagine più scontate, più deamicisiane (torneremo fra poco su questo aggettivo abominevole), semplici cartoline di virtù morali anche se ravvivate da quel senso infallibile del conflitto, che è il motore narrativo per eccellenza.
Mi ammaliò Dagli Appennini alle Ande, sebbene la sequenza di sfighe che si accaniscono sul piccolo protagonista mi sembrasse troppo intenzionale, più dimostrativa che convincente. È un racconto che ho imparato ad apprezzare più tardi per aspetti secondari come gli straordinari paesaggi argentini: quelle pampas riarse, quelle strade urbane dritte, vuote, metafisiche, che sembrano presagire Borges… e d’altronde il viaggio del bambino alla ricerca della madre, il suo avvicinarsi infinito a un amore che irradia da lontano e lascia tracce di sé a ogni tappa del percorso, non ha qualcosa dell’Accostamento ad Almotasim?
Ma quello che mi colpì di più e che ancora mi delizia fu invece Il piccolo scrivano fiorentino. Un racconto dal contenuto tragico, nell’accezione letteraria del termine. È la storia di Giulio, un ragazzino di famiglia immancabilmente modesta. Suo padre è sfinito dal lavoro di copista per una casa editrice (già allora gli editori pagavano poco!), lavoro che spesso è costretto a terminare la sera a casa per guadagnare qualche soldo in più. Il ragazzo impara a imitare la grafia del padre e prende l’abitudine di alzarsi nottetempo e aggiungere qualche pagina a quelle copiate dall’uomo. Il padre non si accorge dell’inganno, anzi si rincuora della propria rinnovata capacità di lavoro e anche le entrate di casa ne beneficiano; ma il figlio, stremato dallo sforzo notturno, comincia a peggiorare nel rendimento scolastico, addirittura ad addormentarsi in classe. Ecco la classica divaricazione della tragedia greca: il bivio aperto su due strade alternative, nessuna delle quali promette bene. Sì, perché nella ventata di serenità che grazie al suo sacrificio investe la famiglia, Giulio, proprio lui, è l’unica nota stonata, il cruccio, l’ingranaggio inceppato, al punto che quel babbeo del babbo finisce per ripudiarlo. Che fare?, si domanda il piccolo Edipo. Ricominciare a dormire il giusto e lasciare che mio padre si ammazzi di lavoro, purché riprenda ad amarmi come prima? O continuare a suicidarmi ai suoi occhi, apparendo il pessimo figlio che in realtà non sono?
Arriva l’ultima notte. Il ragazzo ha deciso di smettere di aiutare il padre, questo inganno deve finire! Eppure…
Qui De Amicis è grandissimo: la casa è immersa nel silenzio, pare di sentire il respiro dei dormienti. Scocca l’ora in cui Giulio tante volte si è alzato per adempiere il suo compito segreto. Ed ecco che il ragazzo lascia di nuovo il letto, spinto da un insieme di abitudine, di tenerezza per il genitore e per se stesso – una bellissima pagina di verità, perché è proprio così che succede nella vita! La virtù è diventata vizio. Si rimette al tavolo e scrive, scrive… e intanto il padre è alle sue spalle. Destato da un rumore, forse da un dubbio (è tonto ma non del tutto) si è alzato in silenzio. Sta guardando il figlio curvo sulle carte. Finalmente capisce.
Ecco: a questo punto, poche righe prima dell’abbraccio che farà sobbalzare il ragazzo, delle grida del padre, della famiglia svegliata in piena notte per redimere il piccolo eroe e restituirgli l’amore revocato, a me affiorano regolarmente le lacrime. Non mi vergogno ad ammetterlo, la trappola emotiva scatta. E una tragedia cos’è se non una trappola emotiva?
Dicevo del “deamicisiano”. Che pena l’abuso di questo aggettivo, nel quadro generale di una coazione al sarcasmo che è la vera legge non scritta del nostro comunicare. Ridiamo, ghigniamo per difenderci dalle emozioni, queste Erinni così temibili. Riempiamo i social di faccette ridacchianti e di commenti ironici. Oh, l’ironia, la nostra sovrana, benevola con i suoi sudditi al punto di farli sentire superiori agli affanni delle formiche umane! I cronisti sportivi, che fanno più danni di Attila, sono così lesti a definire deamicisiano l’abbraccio fra gli avversari, la mano tesa al nemico caduto a terra, le parole di pietas del vincitore e quelle umiliate e dignitose dello sconfitto. Tutto deamicisiano, tutto da seppellire sotto berci di derisione: l’immedesimazione nell’altro, la piccola generosità anonima, la mite aspirazione alla giustizia, l’aggettivo “buono” che quando è riferito a una persona e non al ragù si avvelena di scherno. Il buon Federico, quel bonaccione di Federico. Quello scemo di Federico.
Peccato che tutte le critiche e le lamentele che nel frattempo innalziamo, ogni giorno, sulle italiche magagne abbiano sullo sfondo, come modello ostinato e misconosciuto, un’idea deamicisiana della società.
De Amicis tratteggia un mondo in cui regnano la solidarietà nel bisogno, l’aspirazione a un’eguaglianza concreta, l’impegno nel lavoro e nello studio non come risorsa dei mediocri ma come strumento di riscatto sociale. Un mondo in cui i ricchi e potenti non si limitano a spassarsela offrendosi al voyeurismo famelico della plebe, ma al contrario vivono il privilegio come onere, invariabilmente severi, magri, silenziosi, un po’ pallidi, quasi incurvati sotto il peso della responsabilità, come il padre di Nobis che in aula infligge una girata epocale al figlio che ha dato dello straccione al genitore di un compagno. Noi vorremmo vivere nella società di De Amicis, eccome. Ma siamo troppo impegnati a sogghignare per accorgercene.
E questo mondo ideale – proprio nel senso di un ideale normativo kantiano, una strada da percorrere sapendo che non si giungerà mai alla meta ma che la direzione giusta è quella – ci arriva filtrato attraverso lo sguardo neutro del medioboy Enrico. Un narratore disarmato che non ha nulla di eroico. Un ragazzino qualsiasi che non ha niente da insegnare: sa solo osservare, ascoltare, raccontare.
Non è quello che fa?
Illustrazione di copertina: Valentina Merzi
