A pochi mesi dall’uscita di La metà del mio tempo (Einaudi), il libro più intimo e personale di Javier Marías, che raccoglie e rinnova l’eredità umana e artistica di uno degli scrittori più amati della letteratura in lingua spagnola dei nostri tempi, vale la pena tornare sui sentieri della sua narrativa. Esplorarne le corrispondenze e le suggestioni, seguire i fili che intrecciano le sue storie, avvicinare lo sguardo ai personaggi o allontanarlo per vederli meglio. Ora che Marías ci ha lasciato quest’ultimo, preziosissimo dono, la sua opera infatti continua a parlarci, perché se è vero che «le cose finiscono e ormai hanno un loro numero e il mondo dipende allora dai suoi relatori, […] gli altri non finiscono mai e c’è sempre qualcuno per cui si racchiude un mistero». E forse adesso più che mai si sente il bisogno di discendere verso il nucleo primigenio dei suoi romanzi, per ridare ascolto al coro di voci che in essi si affastellano, mossi, noi come loro, dal desiderio lacaniano di osservare per conoscere, di afferrare un senso che sempre ci sfugge.
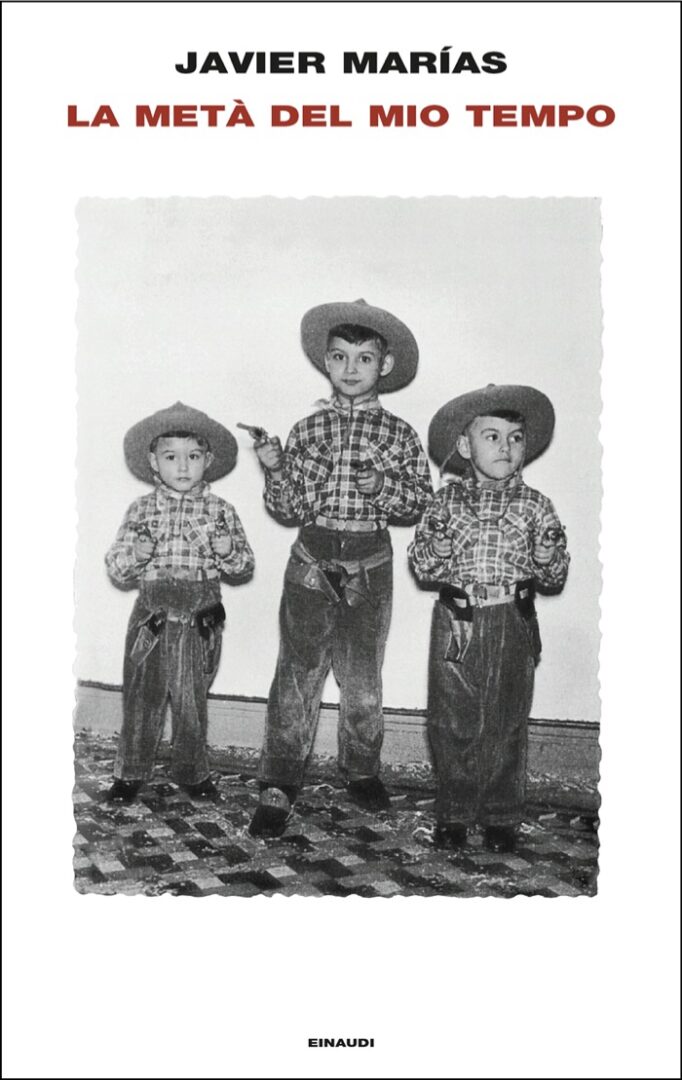
Nello stesso desiderio sembra inciampare María Dolz, la donna che siede ogni mattina in un bar di Madrid, sempre alla stessa ora, sempre allo stesso tavolino in fondo al locale. Davanti a lei, un uomo e una donna fanno colazione, parlano senza sosta e con gesti affiatati. Lei li osserva con attenzione crescente, fantastica sulla loro vita di coppia perfetta, fino a trasformare quell’appuntamento quotidiano in un rituale. Poi, una mattina, l’uomo non c’è più. È morto. E improvvisamente quella lente aperta su di loro diventa un’ossessione. Chi era quell’uomo? Chi era quella donna? E che fine ha fatto lei ora che non può più contare su di lui, «neppure per le cose più insignificanti, per una telefonata banale o una domanda sciocca, “me le hai lasciate lì le chiavi dell’auto?”».
È in questa sospensione, in questo sottile spazio interstiziale tra osservazione e interpretazione, tra immaginazione e conoscenza, che si gioca gran parte della narrativa di Javier Marías.
L’ultima volta che María vede quell’uomo al bar è l’ultima volta anche per la moglie di lui, Luisa, il che potrebbe apparire «strano e forse ingiusto, dal momento che lei era questo, sua moglie», e lei invece era una sconosciuta che non aveva mai scambiato con lui una sola parola. Eppure, lo aveva visto molte mattine, conosceva la sua voce e la sua risata, e la giornata di María non iniziava col piede giusto senza la visione che quei due le offrivano inconsapevoli.
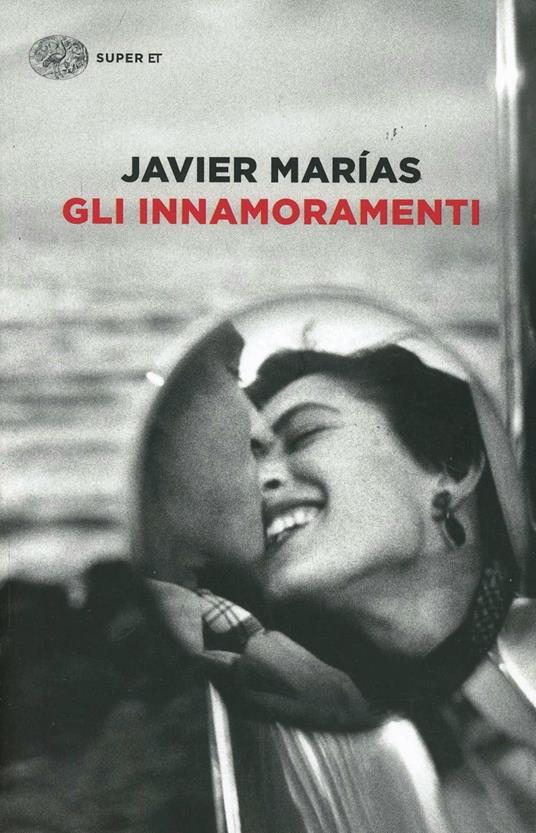
Se María Dolz, la protagonista di Gli innamoramenti, trova conforto nell’osservare quel frammento minuscolo del mondo prima di iniziare la giornata e finisce poi per indagare le ragioni di un omicidio che nulla avrebbe dovuto destare in lei se non quella compassione minima che risveglia in noi un titolo di cronaca nera sul giornale e che un attimo dopo già si dimentica, Juan De Vere, giovane assistente del grande regista Eduardo Muriel in Così ha inizio il male, viene incaricato da Muriel in persona di seguire i movimenti di sua moglie Beatriz. In questa dimensione programmatica e deliberata di “spionaggio”, De Vere, ospite dei Muriel, è guidato da un mandato preciso: scoprire se Beatriz intrattiene relazioni extraconiugali.
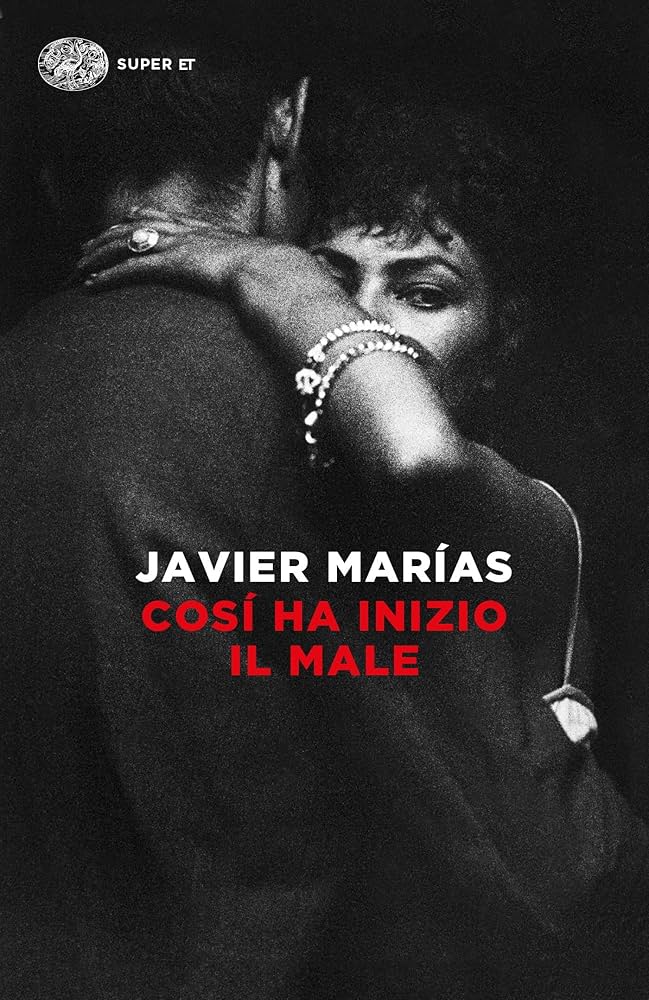
Ancora in casa, la sente prepararsi canticchiando, infilare gli stivali dal tacco sottile e girare la chiave nella serratura. Allora scende con cautela dietro di lei e inizia il pedinamento. Nulla gli sfugge della figura alta e vistosa di Beatriz, non il passo dritto e sicuro, non il modo in cui di tanto in tanto si ferma a osservare una vetrina, né l’ondeggiare sinuoso della sua gonna, spettacolo che Juan si gode con cura, ammirando «tutta la sua carne abbondante e soda». Ha accettato quell’incarico con leggerezza, non capendone fino in fondo le ragioni, ma più si insinua nella vita di Beatriz più viene inghiottito dal gorgo di ambiguità e strani giochi di potere che corrodono il matrimonio di Eduard e Beatriz dall’interno. Così, quando si fa testimone di un’intimità che non gli appartiene, Juan non riesce a rimanere neutrale: vorrebbe intervenire, modificare il corso degli eventi, caricarsi sulle spalle il peso di ciò che ha visto, ma capisce in fretta che quanto ha visto non lo conduce a nessuna scoperta e porta con sé soltanto nuove domande. Chi è la vittima, chi è il carnefice? Ammesso che ce ne sia uno. Juan vorrebbe conoscere la verità, ma la verità «ha un luogo e lì rimane; ha un tempo, e in quel tempo rimane. Se ne sta chiusa in quel luogo e in quel tempo e non c’è modo di riaprirli, di arrivarci per dare un’occhiata a quello che c’è dentro». A Juan non resta allora che andare a tentoni e azzardare approssimazioni, girare intorno alla verità, seguendo la gonna frusciante di Beatriz.
Probabilmente però la forza di questa prospettiva che guarda la realtà da una posizione di privilegio trova la sua espressione massima in Domani nella battaglia pensa a me, in cui il protagonista si ritrova testimone della morte di una donna appena conosciuta.
«Nessuno pensa mai che potrebbe ritrovarsi con una morta tra le braccia e non rivedere mai più il viso di cui ricorda il nome. Nessuno pensa mai che qualcuno possa morire nel momento più inopportuno anche se questo capita di continuo, e crediamo che nessuno se non chi sia previsto dovrà morire accanto a noi».
E invece Marta muore accanto a Victor Francés, inopportunamente tra le sue braccia, quasi senza conoscerlo, immeritatamente, perché non toccava a lui starle accanto. Lei lo aveva invitato a cena, si erano da poco spostati in camera da letto e avevano appena iniziato a spogliarsi, poi «non mi sento bene, non so che mi sta succedendo» gli dice Marta, e da quel momento, Victor, che ha raccolto gli ultimi sussurri di una donna di cui sapeva poco o niente, sarà costretto a diventare partecipe della vita e dei segreti di quella donna: del dolore del marito che stava per tradire e che ha perso sua moglie, del figlio piccolo che non sa che la madre sta morendo nella stanza accanto. Victor penetra nella loro esistenza come un’ombra silenziosa, e nella sua testa una frase risuona come una cantilena e lo perseguita, «non sono stato io a cercarlo, non volevo».
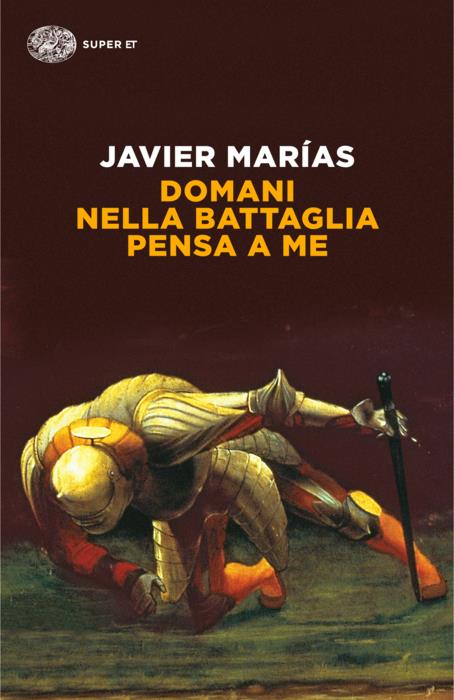
María Dolz, Victor Francés, il giovane Juan De Vere non sono mossi da un’inclinazione alla curiosità morbosa che in se stessa si consuma e si esaurisce né sono alla mercé di un narratore bramoso di generare tensione nell’intreccio. I personaggi dello scrittore spagnolo guardano, osservano, indagano la vita degli altri con pazienza scrupolosa per capire qualcosa in più su se stessi e finiscono per confrontarsi invece, inevitabilmente, con la natura elusiva della realtà. “Guardare” infatti non è mai sufficiente per comprendere: lo sguardo deforma, filtra, reinventa. E chi guarda diventa parte della scena che osserva, ne è coinvolto, attratto in una rete di significati mai davvero afferrabili.
Osservare senza comprendere, essere testimoni di un reale inconoscibile, abitare la soglia tra il visibile e l’invisibile: questa è la condizione esistenziale dei personaggi di Marías, ed è forse in questo modo che lo scrittore spagnolo rende il voyeurismo un paradigma della conoscenza contemporanea: una lente spietata che più ingrandisce l’immagine più mette a nudo la nostra precarietà interpretativa. Il voyeur, lungi dall’essere un semplice spettatore, ci condanna a inseguire un senso che, al momento della sua apparente rivelazione, si sottrae.
Oppure lo sguardo ossessivo e inquisitorio di Javier Marías è l’unico modo per vincere la battaglia contro la Morte, ridicola e orrenda, o contro la nera schiena del Tempo, perché «uno è vivo adesso e dopo è morto, e in mezzo niente, come se si passasse senza transizione e senza un motivo da una condizione all’altra». E se «poco rimane di ogni individuo nel tempo inutile come la neve scivolosa […] e di quel poco tanto si tace, e di quello che non si tace si ricorda dopo soltanto una parte minima, e per poco tempo», allora osservare è anche un tentativo di trattenere. Aprire una lente sul mondo con ossessivo rigore per tenere a bada la paura che ci «impallidiscano» o «ci vadano sfumando i volti, e che i fatti e le parole si facciano imprecisi e fluttuino nella memoria con lo scarso valore di quelli letti nei romanzi e visti e sentiti nei film», dove tutto ciò che accade «è indifferente e si dimentica, una volta che siano terminati, anche se hanno la facoltà di mostrarci quello che non conosciamo e quello che non accade».
Strumento epistemologico o dispositivo della memoria, la dimensione visuale nei romanzi di Marías, che in essi trova un così largo spazio, è un meccanismo che costringe i personaggi a confrontarsi con il limite dello sguardo e della nostra relazione col tempo, che incalza e continua a scorrere senza aspettarci. Guardare è sempre un atto incompleto, in perenne contrasto con l’opacità del reale, con la natura camaleontica della verità. Ma è anche un gesto di resistenza: un modo per trattenere, per rimandare l’oblio, per costruire un archivio fragile e personale di volti, di parole, di nomi e di gesti, consapevoli che «andiamo di inganno in inganno e su questo non ci inganniamo, e tuttavia ogni nuovo inganno che viviamo lo prendiamo per vero».
Photo Credits – Immagine di copertina. Foto di Javier Marías da Secondo Tempo
