In “Intervista alla sposa” (La Nave di Teseo) di Silvio Danese quello fra Dino e Stefania è l’incontro fra due solitudini. Lui, figlio “debole” di un grande nucleo patriarcale che più che una famiglia è un clan fortemente gerarchico, geometra che si finge ingegnere, incontra lei, ragazza fragile per sorte uguale e contraria: dove nella famiglia di Dino vige un sistema rigido, possessivo, pervasivo, quella di Stefania – padre, “padroncino” di una piccola azienda, depresso e morto in circostanze mai del tutto chiarite, e madre distante che non riesce a esserle mai davvero di sostegno – è una famiglia abitata da una profonda incomunicabilità.
Il fidanzamento è breve, il matrimonio quasi precipitoso, ma ben presto Dino diventa geloso, paranoico, violento.
“Le dispiaceva, capisci? Com’ero io. Anzi era, non so come dire, un errore.”
La tua bellezza.“Come si fa a mettere tutta quella… aggressività. In una cosa così. Però era di una violenza… Poi, ripensandoci dopo, ho capito: sei troppo bella per noi, sei diversa, sei troppo bella per stare con noi, per stare nella nostra famiglia senza, non so come dire.”
Inquinarla.
“Ecco. Proprio così. Ero qualcosa di minaccioso per loro, e questo Dino lo sentiva. Secondo me Dino ha sentito subito quanto mi volevano tenere fuori.”
C’è un posto per la sposa nella famiglia di origine e nell’immaginario di Dino, e Stefania non sa sta “stare al suo posto”. È bella, Stefania. Vuole addirittura lavorare in un’azienda diversa da quella di proprietà di Dino. È ingestibile. Arrivano due figli, a volte impermeabili per comprensibile autodifesa, a volte fin troppo coinvolti nelle vicende della madre, ma Stefania continua a sentirsi insicura e sola. Deve sopportare l’ulteriore umiliazione di scoprire che il marito ha un’amante, oltretutto incinta.
Poi, una sera come tante, una sera in cui Stefania potrebbe di nuovo finire in Pronto soccorso per le violenze subite, succede quello che lei chiama “il disastro”. E settimane dopo il corpo di Dino verrà ripescato dal fondo di un lago avvolto in tappeto.
A raccogliere, nel parlatorio di un carcere immerso in una sorta di rumore bianco quasi accogliente, questo lungo, a tratti stentato e a tratti fluviale racconto di Stefania, c’è un io narrante maschio: un maschio mite e scolarizzato, convinto per questo di poter essere un occhio neutrale e, soprattutto, di essere estraneo alle dinamiche che si agitano nel rapporto tra Dino e Stefania.
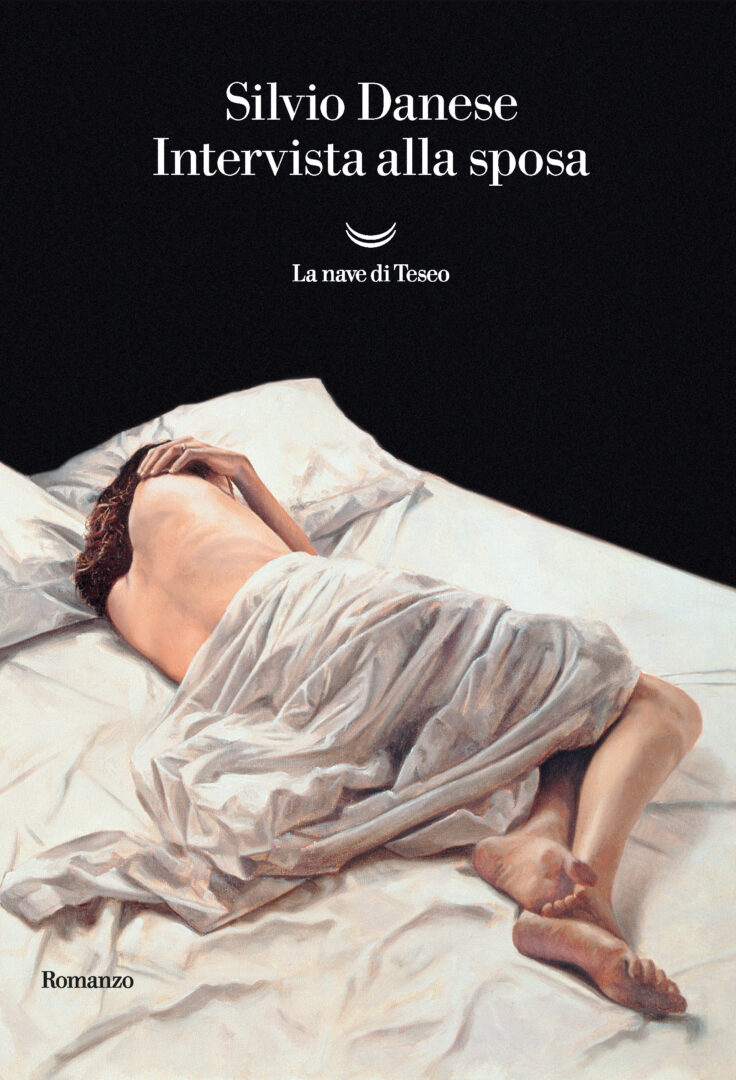
Stefania racconta vent’anni di violenze, riconciliazioni, regali, denunce sporte e poi ritirate, fughe nelle notti invernali con i bambini assonnati e di nuovo violenze e umiliazioni. Non è sicura, Stefania, di essere in grado di rendere quell’esperienza sconvolgente. Spiega, precisa, si corregge. È un personaggio in formazione e Silvio Danese le cuce addosso una lingua splendida, dal ritmo sincopato, a tratti ossessiva, dominata dai “voglio dire”, “prima non lo sapevo”, “ora capisco”. Stefania indulge a momenti di autocommiserazione, ma nel ricordo e nel racconto della propria storia acquista consapevolezza di sé e della abnorme, insopportabile verità che ci sia, magari travestita dal desiderio di salvare la sua famiglia, una componente di complicità con il carnefice anche nella vittima di un rapporto così sbilanciato come il suo con Dino.
E l’io narrante che maschio è? Si può davvero chiamare fuori dai giochi? Si analizza, rimastica sensazioni e pensieri, alcuni passaggi sono prossimi al monologo interiore. Anche lui è un personaggio in formazione, nella sua vita ha conosciuto gelosia e possessività. Indaga meticolosamente le origini culturali dell’identità maschile e femminile, si guarda allo specchio, scava nella natura più profonda della violenza che ogni famiglia si porta dentro. E la sua diventa pian piano una partecipazione discreta e dolente a una storia che è non solo quella di Stefania e Dino, ma è, con varie sfumature e declinazioni, quella di tante famiglie.
Solo i poveri di spirito, quelli a cui l’umiltà sembra una virtù, quelli orgogliosi di cadere nell’oscurità della mancanza di immaginazione, possono non-sapere. Gioia, perché sei mia. Dolore, perché ti porteranno via.
Straordinarie la pietas e la sobrietà con cui Danese gestisce questa storia, senza il tono sensazionalistico di tanti racconti che, pur nelle buone intenzioni di denunciare violenze domestiche e femminicidi, non riescono a uscire dalla “pornografia”.
Con un finale che sovverte le leggi del patriarcato.
