Molti scrittori invocano le muse e gli dei – fammi scrivere un buon libro e io crederò in te –, Tolstoj non aveva – non era – altro che se stesso, e il senso di ciò che lo aspettava e di ciò che la vita era giunta a significare per lui è di conseguenza più intimo e commovente. È difficile distinguere l’arte stessa di Tolstoj dalla Natura. Egli si muove tra i fili epistemici di epos che sa di essere il solo in grado di tessere, ha il potere di ordire una struttura intrinseca a ciò che la sua mente crea, di disfare la sua creazione, e talvolta sembra che la voce sia persino sovra-naturale: vede e sa ciò che nessun altro può. Ci vuole un briciolo di perversione per godere della lettura di Tolstoj, perché lui ci scuote, ci percuote, ci critica, ci distrugge nel tentativo di risvegliare le nostre coscienze, vuole punirci per il fatto che non siamo in grado di resistere al suo genio, non ha alcun perdono nei nostri confronti, e noi lo leggiamo lo stesso e godiamo ugualmente. C’è sempre un elemento di paura che ci fa desiderare di sfuggire lo sguardo di Tolstoj fisso su di noi.
Perché vivere? È la domanda che anima i libri di Tolstoj, che gira e rigira l’esperienza, il mondo, fra le sue mani, cercando di capire quali dovrebbero essere i nostri scopi. E quando non ne trova, ecco che il mondo diventa polvere e cenere sotto i nostri piedi. Il demone poetico che fa di Tolstoj un saggio era una personificazione della paura. È strano come la morte decida di rivelarsi ad alcune persone.
Tolstoj si stimava migliore di noi – di tutti – unico pioniere ad aver i visto i lumi di una vita vera. Egli si muove, come un vero aristocratico, dall’esterno verso l’interno. Per gran parte della sua vita è sempre stato dotato di un’energia potente, poteva lavorare i campi e scrivere per otto o nove ore al giorno senza risentirne minimamente. Non stupisce che un uomo così sano, dotato, e con immensa energia da incanalare, abbia potuto porsi quesiti tanto oziosi. Non stupisce che non riesca a perdonare gli altri, visto che non ha saputo perdonare se stesso. Quando gli si presentano delle domande egli dice «Le domande non aspettano. Bisogna rispondervi subito; se non si risponde non si può vivere. Sentivo che il suolo sul quale mi reggevo, mi fuggiva sotto, che non v’era più nulla a cui potessi aggrapparmi, che ciò di cui vivevo non era più, e che non mi rimaneva nulla».
Tolstoj compie un passo, la conversione, che non tutti riescono a perdonargli. Anche a lui restavano domande inesauste per tutte le sfumature dei clericali, dei protestanti, degli ortodossi, per i rituali, per i fasti, per le contraddizioni. Trovo curioso ricordare che Rousseau nelle Passeggiate di un sognatore solitario affermi che ai dubbi della sua vecchiaia lui rispondeva con le certezze della sua gioventù: poiché egli si era impegnato con tutte le sue forze a trovare delle risposte che lo pacificassero, lui si fermava a quello, alle epifanie ottenute al massimo delle possibilità. Da vecchio, diceva, oramai il suo intelletto non poteva più aiutarlo, quindi cercava di non curarsi del discutibile. Tolstoj invece, con la sua Confessione, abiura tutta la sua vita, e lo fa più per il terrore che per un vero sentimento comunitario. Solo i ricchi possono invidiare il povero. Solo i sani possono invidiare le malattie, e solo i veri snob possono credere nella purezza del popolo. Il popolo certamente contiene saperi preziosi e infiniti, ma questo non rende la loro vita giustificabile. Nella povertà non c’è alcun bene – o alcun male. Non è la cultura a decidere dell’animo di un uomo.
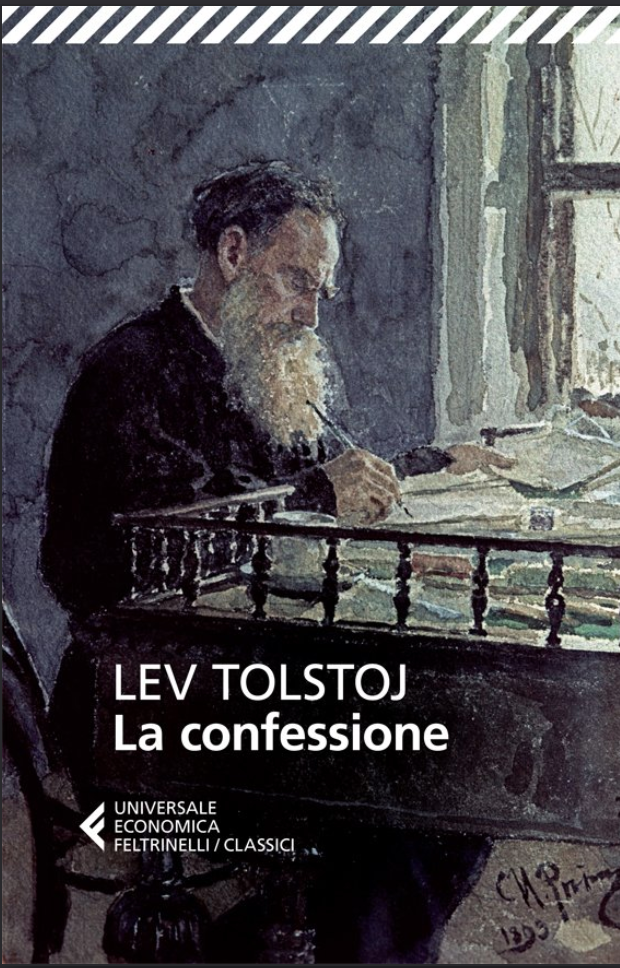
Ciò che Tolstoj andava a cercare nei bassifondi di Mosca non si trattava dei mendicanti della casa di Ljapin, ma di se stesso. Egli, nell’avvicinarsi a questi disgraziati, non cercava di dare loro qualcosa, ma di prendere da loro: le domande che poneva non le poneva per loro, ma per se stesso. Avrebbe potuto chiudere gli occhi, dimenticarli, ma oramai aveva bisogno dei poveri. Non di tutti, solo di alcuni. Essi erano il contraltare della sua vita, il polo dialettico del suo scrutinio morale. Quando è indispensabile ad un uomo l’essere virtuoso, qualsiasi cosa faccia egli avrà sempre ragione. Il bene verrà da lui. Tolstoj l’avrebbe forzato a farlo venire da lui, anche se questo avrebbe significato privare di esso tutti gli altri uomini. Ecco d’altronde le sue parole:
«Nella mia vita, che è stata particolarmente felice dal punto di vista del mondo, io potrei raccogliere tante di quelle sofferenze da me subite in nome degli insegnamenti del mondo che esse potrebbero bastare a un buon martire del Cristo. Tutti i momenti più penosi della mia vita, a cominciare dalla mia ubriachezza, dai miei stravizi di studente, fino alla malattia e alla condizioni contro natura nelle quali vivo oggi tutto questo è un martirio in nome del mondo.»
Tolstoj in nome della verità vuole inseguire il martirio. E la verità non è altro che il perfezionamento del sé, l’autopurificazione del suo essere che si propone da tutta la vita. Ora non parla che della crudeltà, della grossolanità, della bassezza della classe elevata. Per lui il benessere non è morale, e perso tra i tormenti, cerca di capire cosa insegnarci: perché questo gli interessa. Sente di avere una missione, di dovere insegnare qualcosa, ma non sa nemmeno lui cosa. Opta così per quello che gli pare il male minore. Ma una volta guardata in faccia, questa verità, si nasconde, torna indietro e continua a scrivere terrorizzato, pagine altissime in cui Tolstoj e la dama nera combattono costantemente. Pagine in cui lui cerca una via di uscita, un’ancora di salvezza. Perché c’è qualcosa di espiatorio nella sua funzione, tanto più che si offre come pietra di paragone. Dare se stesso – proiettarsi e immergersi – sentire fino a comprendere, e comprendere tanto bene da potersi esprimere, essere perspicaci quando si è al culmine della passione, essere infinitamente curiosi e incorreggibilmente pazienti, ma anche plastici e infiammabili, per vincere servendo e servendo per guidare – questo è certamente ammirabile – invidiabile – emulabile. In primo passo c’è la libertà dell’uomo di accettare la chiamata a partecipare del bene o del male a cui siamo originariamente destinati e nonostante Tolstoj sia vilmente convinto di avere operato nel male – lui è indubbiamente un testimone del bene. Il bene per Tolstoj, non è altro che Dio stesso. Seguendo l’insegnamento del Cristo nessun uomo può avere mai sofferto una sola volta. E cerca di tacere al mondo che egli non crede, del vuoto del cuore sul quale egli ha innalzato l’edificio così brillante della sua predicazione, diventando il martire di una finta fede, costringendo la sua idea di bene sul letto di Procuste dei suoi bisogni personali. Tolstoj identificava Dio con il desiderio di non morire. Tolstoj, che era immensamente coraggioso, era mosso non tanto da una banale paura di morire, bensì dalla sua vitalità e dal suo vitalismo straordinario, che non riuscivano ad accettare l’idea di non esistere più. Gorkij è molto preciso al riguardo: «Per tutta la vita ha temuto e odiato la morte. Per tutta la vita, nella sua anima, ha pulsato il terrore: devo proprio morire? Il mondo intero, tutta la terra volge lo sguardo nella sua direzione; la sua anima è per tutti e per sempre. Perché la natura non dovrebbe fare un’eccezione alla sua legge e concedere a un solo uomo l’immortalità fisica?»
Da bambino Tolstoj piangeva, e piangeva soprattutto quando doveva mentire ai grandi, e ancora di più quando i grandi cascavano nelle sue frottole. Si disperava e si sentiva cattivo ad approfittarsi degli altri e quindi piangeva inconsolabile. Se gli altri non fossero esistiti, sarebbe stato molto meglio – visto il suo incontro traumatico con l’abisso dell’Altro desiderante, con la terrificante figura di un Altro impenetrabile che pretende qualcosa da noi che lo accompagneranno per tutta la vita.
Il suo mondo di orfano è vuoto e così ha inizio la sua ricerca diasporica di qualunque altra persona viva al mondo, che lui possa considerare un suo pari e non un fantoccio da raggirare. Il suo forte era negare se stesso negando le cose che per lui erano importanti. Ci racconta che spesso gli era accaduto di avere delle crisi, fin dall’infanzia, in cui era improvvisamente assalito per futili motivi da terrori atroci. In momenti tranquilli, in cui è al sicuro, al caldo, sente per caso due voci che litigano ed ecco che «Sto male e ho paura, e non capisco più niente. Il terrore si impadronisce di me.» Racconta anche nel racconto postumo Diario di un demente, che durante un viaggio d’affari, a letto di notte mentre cercava di pensare alle sue incombenze, improvvisamente: «tutto non significava più niente per me. L’orrore della mia vita perduta mi nascondeva tutto. Appena a letto il terrore mi fa rizzare in piedi. È un’ansietà, simile a quella che precede il vomito, ma morale. Il timore, la paura, sembra che la morte sia terribile, ma quando si ricorda, si pensa alla vita, è la vita agonizzante che terrorizza. (…) qualche cosa si lacera, ma regge ancora». Tolstoj:
«Vorrebbe somigliare alla natura eterna,
Edgan Morin, L’uomo e la morte
Alla madre degli dei, la madre terribile,
Ah, è per questo, terra,
Che la sua presunzione lo allontana dal tuo seno.»
Sa di godere dei tributi che gli onorano in modo vergognoso. Non poteva più essere quello che gli altri ammiravano «Non è colpa mia se io vivo e se voglio vivere, e se voi adesso dopo aver preso dalla vita tutta la parte migliore, voi cercate qualcos’altro, forse di buono, forse di indispensabile per voi ma per me è estraneo, superfluo, incomprensibile». Tolstoj non comprendeva gli altri. Egli creava eroi, non individui. Ed è per questo che ci obbliga a tenere conto non di se stesso, ma della sua scuola. Non conversa con i suoi discepoli, si aspetta solamente gli omaggi che gli convengano.
Molti hanno paragonato Tolstoj a Socrate. Entrambi ebbero ammiratori e adepti che spesso li hanno fraintesi nel tentativo di emularli. Ma Socrate aveva una profonda indifferenza davanti alla morte. In primo piano Socrate ha l’orgoglio, la serenità, finanche il disprezzo: tuttavia non è questo che conta. Più straordinaria di un ateismo sicuro di sé è questa indifferenza davanti all’innominabile, che sia il nulla o l’immortalità. Quando un autore religioso condanna l’ateismo spesso costruisce una visione dell’universo senza Dio che è una proiezione del sottosuolo rimosso dalla religione stessa. Tolstoj si vedeva altrimenti: «Si considerava come il più gran peccatore che sia esistito. E non era solo la prima metà della sua vita che gli ispirava un profondo disgusto: la sua vecchiaia gli sembrava orribile quanto la sua giovinezza. La ragione ch’egli glorificava così pomposamente non riusciva a mantenerlo nel retto cammino. E se continuava ad andare avanti era perché tutte le vie di ritorno erano sbagliate.»
Tolstoj oramai esitava come un cieco davanti ai muri. Ma sono i ciechi a scoprire per primi la verità. Affermare che Io esisto, è l’impulso che palpita sotto la sua scrittura – e sotto tutta la buona scrittura . Quello che sembra però è che i suoi libri trascendano lo stesso Tolstoj – che sia il testo ad esistere e non Tolstoj come accade a Shakespeare, Montaigne, e lo incastrino in una doppia solitudine, in una produzione di parole che rendono ontologicamente sicure solo le parole in quanto tali. Così abbiamo una Anna Karenina, un Levin, un Chadzi Murat, più viventi di Tolstoj stesso, perché lui dà loro la sua vita, l’unica di cui gli importi davvero. In tutti i suoi libri è chiaro che Tolstoj, scrivendoli, aveva più odio che amicizia nel suo cuore. Non solamente gli uomini, ma la sua fede, i suoi principi gli sembrano falsi e menzogneri. È così che nascono Ivan I llic e Padre Sergej.
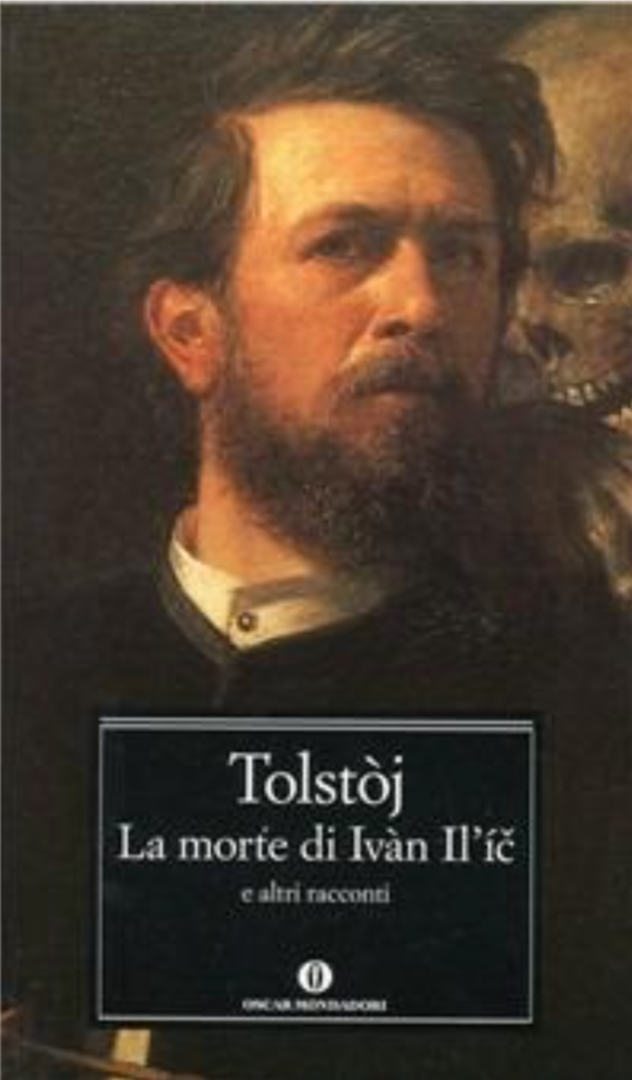
Platone dice che tutta la vita non è che un prepararsi a morire, è questo che fa Tolstoj per tutti noi: prova ad insegnarci a morire. Quello che rimane non è un Tolstoj vittorioso. Il pathos febbrile della sua ricerca gli assicura l’insoddisfazione.
Ma la predicazione non fa altro che svuotare di senso i concetti.
Egli fu più volte sul punto di suicidarsi ma alla fine era sempre la speranza a riportarlo indietro, a spingerlo a procedere tra il suo terrore.
Scrivere è divenire altro. E lui cercava di trasformarsi, di indossare ogni maschera, di concedersi ogni finale, camuffandosi un momento per assaporare i suoi trionfi, le punizioni, la sua stessa morte. Allestiva migliaia di pagine solamente per confrontarsi con la sua dipartita. Entrava così a fatica nell’eternità. Non era dato a Tolstoj dimenticare, per un genio simile tutto è costantemente presente. Deve scegliere ogni giorno di andare avanti. La individuazione preclude ab imis qualsiasi ipotesi di riscatto; nessun vivente può mai essere giustificato dall’esistenza di un altro vivente. Pochi possono gravarsi impunemente della contraddittorietà della condizione umana, ammetterne la pochezza senza per ciò stesso abdicare a un qualsivoglia progetto di vita.
È molto difficile, una volta riconosciuto l’errore, continuare a vivere tra le ombre, sapendo d’essersi sempre ingannati. Nel tentativo di dissetarsi alle sorgenti biologiche, beve in realtà alle fonti del suo secolo che porta con la sua vecchia civiltà e la sua individualità culturale, lo spettro della morte. Si tratta prima di tutto di sfuggire all’angoscia della morte. Ma in quanto uomo, la sua coscienza accompagnerà sempre i suoi tentativi più strenui di oblio. In qualche modo sa che cerca di dimenticare la morte, e questa consapevolezza che non può in alcun modo distruggere, resusciterà incessantemente lo spettro. Allora la vita si svuoterà, il gioco smetterà di divertire, allora l’eternità dell’istante si dissolverà nell’istante successivo: il tempo tirerà dritto per la sua strada e la morte compirà il suo lavoro. Quando Tolstoj capisce che effettivamente non ha che se stesso, che l’individuo è solo davanti all’irrazionalità è allora che sorge la più atroce angoscia. La rottura delle partecipazioni col mondo, con il generale, con gli altri uomini, rimanda all’angoscia di morte e l’angoscia di morte rimanda a sua volta alla rottura delle partecipazioni. La solitudine evoca l’ossessione della morte e l’ossessione della morte evoca la solitudine.
Tolstoj professa il solipsismo. Ormai vecchio e dopo aver ripetutamente tentato di amare il prossimo, è giunto alla conclusione che non solo amare il prossimo è impossibile, ma che il prossimo non c’è proprio, che in tutto l’universo c’è soltanto il conte Tolstoj. Il solipsismo è la fine di un uomo schiacciato dal peso della propria morale. Lui può rispondere solo per se stesso, non per tutti gli altri. Il tentativo di rendere felice l’umanità che aveva avuto da giovane, da vecchio, compreso che questo compito era superiore alle sue forze, si camuffò in rinuncia, rassegnazione. I moralisti scambierebbero volentieri i loro doni astratti con altri più reali «se solo potessero. Oggi,» egli ci dice «mi hanno condotto al consiglio provinciale per farmi subire un esame mentale. I pareri erano discorsi. Hanno discusso e hanno deciso infine che non ero pazzo. Ma è perché mi sono sforzato di non parlare sinceramente durante la visita medica. Non sono stato sincero perché ho paura del manicomio e voglio continuare con la mia opera di pazzo. (…) l’hanno certificato, ma io so che sono pazzo».
La sua pazzia è questa: che tutto quel che sembrava prima reale ed esistente gli sembra ora fantomatico, mentre tutto ciò che gli sembrava irreale, assurdo, appare come l’unica realtà.
Lui sa che vedere e sentire oltre tutti gli altri, più avanti di tutti gli altri, è follia ma è disposto a sopportarne il carico emozionale. Tutto per continuare con la sua opera di predicazione. Per trasformare il destino di persone che per lui nemmeno esistono, ma che tuttavia lo commuovono. Una proiezione di uomini felici di cui lui non riesce ad avere percezione, poiché per lui gli altri sono degli imbecilli, ma che è convinto detengano la verità. Tolstoj, come è detto nella Scrittura, dovette odiare suo padre, sua madre, sua moglie, i suoi figli e anche se stesso; non c’è altra vita per colui che è escluso dall’universo comune a tutti. Non bisogna permettere che l’idea della morte si impadronisca dell’anima umana, che tutta la vita sia un tentativo di sciogliere i legami che lo trattengono sulla riva e liberare la nave in mare aperto. Uomini del genere vivono tra noi solo per testimoniare. Ma l’universo esiste per Dio o per gli uomini? Per chi avrebbe dovuto scrivere Tolstoj?
Tolstoj non pensa a nient’altro che alla sua anima. Per lui tutto l’orrore delle sue azioni è riferito a questo: che ne deve rispondere, che esistano altri uomini attorno a lui. Ha perduto la sua anima, non può pregare, non può rispondere amen quando gli altri dicono Signore pietà. Eppure Tolstoj con tutte le sue battaglie ci prova che l’uomo è in sé stesso più grande e più forte di tutto ciò che è. È la grandezza il divenire e la morte della verità e delle cose di cui è anche la sorgente.
Immagine di copertina: Getty images
