Eppure la scrittura non è poi tanto diversa dalla fotografia.
Si scrive per rubare al più abile dei ladri, il tempo.
Tommaso Pincio, L’evento nell’epoca della sua riproducibilità tecnica.
Ciò che resta del Libro è la citazione (in senso molto generale):
il frammento, il rilievo che viene trasportato altrove.
Roland Barthes, La preparazione del romanzo.
La ripubblicazione, a febbraio 2023, con La nave di Teseo di Il museo della resa incondizionata di Dubravka Ugrešić, un mese prima della sua morte, si offre come un’occasione preziosa per immergersi nell’opera di una grandissima scrittrice – in Italia ancora troppo poco nota – e di farlo a partire da un testo centrale, forse il suo più importante, in cui la condizione dell’esilio diventa la condizione sine qua non della sua scrittura, della sua poetica, del suo modo di intendere la letteratura e, più in generale, l’arte.
Scritto nel 1996, pochi anni dopo l’esilio a cui il rifiuto della retorica nazionalista, successiva al crollo della Iugoslavia, l’aveva condannata, nonché pubblicato per la prima volta in Italia da Bompiani nel 2002 nell’attenta traduzione di Lara Cerruti (la stessa riproposta dalla Nave di Teseo), Il museo della resa incondizionata è un testo labirintico, in cui al lettore si chiede di fare esperienza dello smarrimento, di farsi testimone della vita di un altro essere umano, in questo caso Ugrešić, a sua volta testimone delle vite che racconta, delle voci che raccoglie, degli oggetti, delle case, delle fotografie che rievoca ed elenca, dei libri che cita. Come si legge in La Volpe, scritto molti anni dopo, precisamente nel 2017, e tradotto in Italia nel 2022 da Olja Perišić, sempre per la Nave di Teseo, «tutti noi siamo testi ambulanti, camminiamo per il mondo con le nostre copie invisibili incollate addosso […] portiamo sulla nostra pelle le biografie di altre persone delle quali non sappiamo niente […] siamo abitati da inquilini segreti, tutti noi occupiamo case di altri».
Questa riflessione, nata a commento di un passo di Fuoco Pallido, in cui Nabokov definisce la vita umana «una serie di note a piè di pagina a un vasto, oscuro e incompiuto capolavoro», descrive perfettamente la sensazione che prova chi legge il Museo della resa incondizionata, il cui andamento digressivo e aforistico sembrerebbe voler insidiare la definizione di romanzo che la stessa Ugrešić pur sceglie per il proprio libro nelle prime pagine del testo.

Ma qual è la trama e chi è la protagonista? Dubravka o la madre Veta, a cui non a caso è dedicato il libro? Quello che all’inizio sembrerebbe un romanzo autobiografico a due voci, in cui l’autrice in esilio, nel ruolo di figlia, ripercorre la vita della madre, emigrata dalla Bulgaria nel secondo dopoguerra, e dunque “prima esiliata” della famiglia, si allarga a macchia d’olio verso l’esterno in un vorticoso movimento di parole e immagini. La scrittura procede per accumulo, per stratificazioni: l’enumerazione caotica è la figura retorica a cui Ugrešić affida la sua poetica e ce lo fa sapere sin dall’inizio, scegliendo di aprire il romanzo con l’elenco degli oggetti recuperati nello stomaco dell’elefante marino Roland, che il visitatore del giardino zoologico di Berlino può osservare esposti in un’insolita vetrina, un “museo-mostra” determinato dal caso, di fronte al quale non si può che rimanere incantati e lasciarsi cullare dal «poetico pensiero che gli oggetti abbiano creato col tempo tra loro legami più sottili». Allo stesso modo del visitatore nel suo giardino zoologico – suggerisce Ugrešić – il lettore dovrebbe leggere così il romanzo: «se gli sembrerà che tra i capitoli non ci siano legami sensati e forti, abbia pazienza: i legami si instaureranno gradualmente da soli».
Ecco che in aiuto al lettore entra in scena la pazienza: valore e dote ormai inattuale, ma quanto mai importante nella comprensione e nel godimento di un testo; e viene in mente Mark Rotkho che con i suoi monocromi sfidava gli spettatori, invitandoli a una partecipazione diversa, scandita da un tempo lento e uno sguardo paziente. Lentezza e pazienza, appunto.
Le istruzioni per l’uso che aprono il romanzo non finiscono però qui, bensì si concludono con un importante avvertimento, una sorta di bugiardino, in cui il lettore viene messo in guardia da quella che potremmo definire una «tentazione autobiografica», anzitutto perché secondo Ugrešić chiedersi se un romanzo sia autobiografico rientra nelle «competenze della polizia» e non del lettore. Eppure, o proprio in virtù di quell’avvertimento, leggendo il romanzo ci si accorge quasi subito quanto l’autobiografismo sia presente. Perché allora quella precisazione? Perché il lettore sappia di dover far affidamento alla menzogna piuttosto che alla veridicità – a meno che non si tratti di quella veridicità “superiore” citata alla fine di La Volpe, ovvero quel «buon motivo perché proprio quella storia debba essere raccontata».
A tal proposito è opportuno dire che, sebbene il rapporto tra finzione e realtà sia indagato maggiormente in La Volpe, nel Museo c’è un’immagine che ci restituisce perfettamente il piacere della finzione: è un cuscino ricamato con delle gigantesche fragole rosse. Guardandolo Dubravka, allora bambina, giunse alla conclusione che «il falso è molto più bello del vero»: «Mi sdraiavo a pancia in giù sul letto della nonna e vagavo a lungo con lo sguardo su quella meravigliosa creazione di fili».
Tra i fili che Ugrešić intreccia mentre scrive il romanzo (l’immagine dei legami che si instaurano da soli è suggestiva, tuttavia è la maestria della scrittrice a suggerire le piste, a moltiplicarle: è lei Sherazade, è lei la Volpe) c’è la fotografia, un vero e proprio fil rouge che attraversa il libro, a partire da quella foto ingiallita che la scrittrice porta con sé come “una reliquia”, «come un lume acceso a una finestra buia». Di questa foto che ritrae tre bagnanti, scelta tra l’altro come immagine di copertina, l’autrice sa solo che è scattata a inizio Novecento sul fiume Parka, un fiume che scorre vicino al luogo in cui è nata e ha trascorso l’infanzia. È sufficiente questa indicazione topografica e le tre bagnanti sconosciute entrano a far parte della geografia del ricordo dell’autrice. O basta forse il suo «partecipare della mortalità, della vulnerabilità, della mutabilità di un’altra persona (o di un’altra cosa)» come scrive Susan Sontag, citata nel libro?
«I profughi si dividono in due categorie: quelli con le fotografie e quelli senza», dice un profugo bosniaco. Ugrešić riporta questa frase per ben due volte e in due momenti diversi del libro, come a voler sottolineare il potere della fotografia di dare consistenza alla realtà, di testimoniare la vita delle persone. Cosa accade a chi ha perso le proprie fotografie? Nel Museo della resa incondizionata Ugrešić racconta di quando, riguardando le fotografie scattate con un’automatica durante un soggiorno all’estero, si accorge che di quel viaggio ricorda solo le immagini fotografate: «mi chiesi che cosa e quanto avrei ricordato se non avessi fotografato».
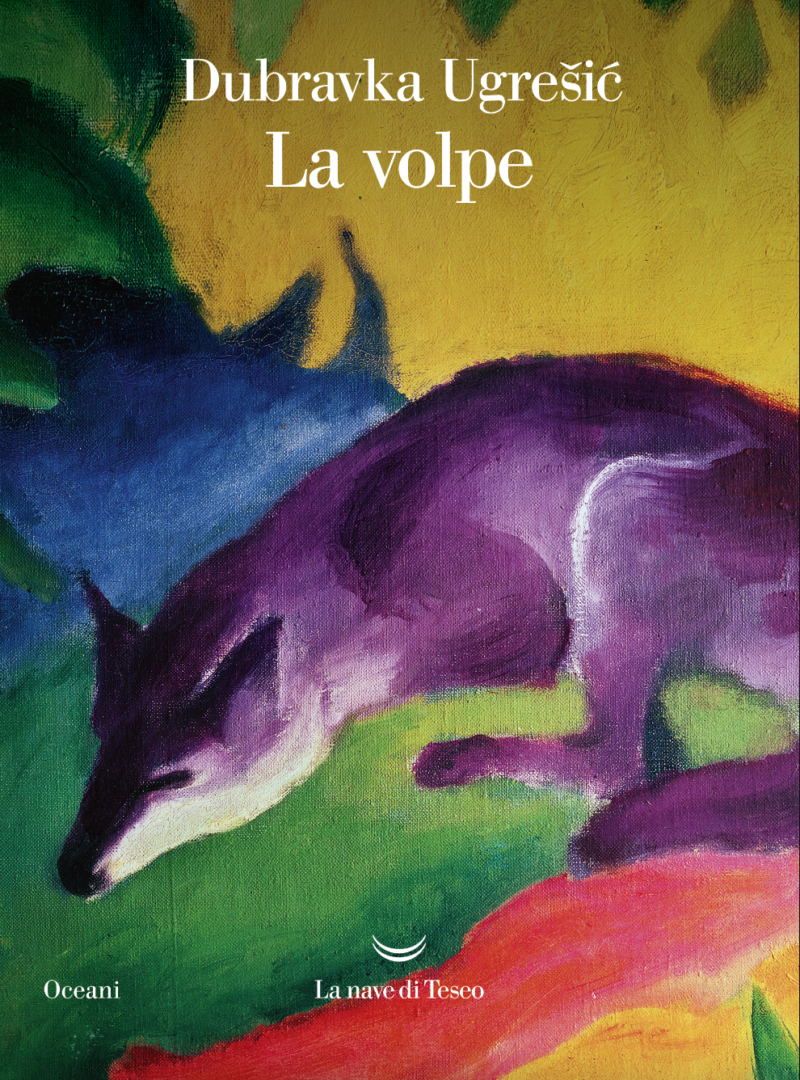
La fotografia ha anche questo potere: sostituirsi al ricordo. All’inizio di Cospira, raccolta densissima di appunti, riflessioni, scritture di viaggio pubblicata da Cronopio, il fotografo Patrizio Esposito, che per anni ha lavorato con i profughi del Sahara occidentale e del Libano, racconta di quando il palestinese Mohammed gli si avvicinò per mostrargli la propria foto e quella di sua madre, e di quando tentando di sfilarle dal porta-documenti di plastica, in cui erano custodite, si accorse che l’emulsione fotografica era rimasta incollata. Di Mohammed e la madre è rimasto solo un alone, «tanto delicato da non poter definire alcunché».
Il rapporto della fotografia con il tempo, e dunque anche con la morte, viene indagato sin dall’inizio del romanzo, a partire da una borsa in cui la madre, Veta, conserva oltre alle lettere del padre, un foulard di seta, una ciocca di capelli e tantissime fotografie, così tante da «fuoriuscire» e «colare», addirittura «passeggiare» per l’armadio in cui la borsa era riposta. Di fronte allo straripare letterale e metaforico dei ricordi la reazione della madre è quella di comprare un album per «ordinare per bene i fatti della vita». Ha infatti capito che è arrivato il momento di mettere le foto in fila, di cercare cioè una narrazione possibile: è successo quando, a un mese dalla morte del marito, «una sua fotografia, piccolina, di quelle per la carta dell’identità, sgusciò fuori da chissà dove» cadendo silenziosa ai piedi della figlia.
La costruzione e la riflessione sull’album di famiglia (insieme al taccuino a fiori che Dubravka regala alla madre rendendola per alcuni capitoli seconda voce narrante del libro) occupano tutta la prima parte del romanzo e anticipano uno dei temi fondamentali del libro, ovvero il rapporto tra arte e memoria, portando l’attenzione sul genere letterario: «Tra quei due generi, album di famiglia e autobiografia, il legame è indubbio. L’album è un’autobiografia materiale, l’autobiografia è un album verbale». È nella forma “album”, nel suo essere “circostanziale”, “rapsodico” e “sparpagliato” (per riprendere le riflessioni di Roland Barthes nel secondo volume della Preparazione del romanzo) che il romanzo di Ugrešić trova una giusta collocazione.
Non solo le fotografie, anche le cose hanno la capacità di attestare un passaggio nel mondo, e di durare, come Las cosas di Borges, più in là del nostro oblio: «Le cose durano più degli uomini. Gli album sopravvivono ai loro proprietari. Una vita prolungata si nasconde in un vecchio cappotto, in un semplice oggetto che per qualcuno ha avuto un certo valore e che avrà ancora per altri. Così viaggiano le anime».
Nella condizione di esilio, poi, che Ugrešić definisce uno «stato incommensurabile», il potere evocativo delle fotografie e delle cose è ancora più accentuato: l’esilio, scrive Ugrešić è la «storia delle cose che ci lasciamo alle spalle». È come se l’unico asilo possibile fosse in questi oggetti, persone, luoghi perduti che la lingua cerca faticosamente di rianimare: «Dei piatti della nonna sono rimaste solo le parole, la mia lingua le rigira volentieri, ma non ne ricorda più il gusto».
Se già la vita si dà come esperienza frammentaria, la vita in esilio è per eccellenza una vita di frammenti, una vita sparpagliata, in cui l’essere fuori dell’esiliato diviene un punto di vista privilegiato che consente al soggetto di intuire a distanza un disegno, il segreto legame tra le cose e le esperienze del nostro passato con quelle del nostro presente e, perché no, anche del nostro futuro. Potente mezzo di svelamento dei nessi sono proprio la letteratura, e l’arte tout court: perché c’è sì nello scrivere la volontà di trattenere le parole, ma anche di trattenere il tempo nelle parole.
Come nelle opere degli innumerevoli artisti citati da Ugrešić, in particolare in quella di Christian Boltanski, anche il Museo della resa condizionata archivia le vite degli altri, «ricicla l’immondizia della gente in un’opera d’arte, realizza il diritto a un prolungamento della vita, a un’ironica eternità». L’accumulo di cui si parlava all’inizio si offre come antidoto alla sparizione. Lo aveva già intuito Roland Barthes, là dove scriveva che «noi trascorriamo il tempo a creare delle rovine, e ad alimentarcene; ad alimentare la nostra immaginazione, il nostro pensiero». Ma forse c’è anche qualcosa di più: «Ricordare è in realtà una questione d’amore», come dice l’artista inglese Richard Wentorth nella quinta parte del Museo della resa condizionata dal titolo appunto Was ist Kunst? Ovvero: che cos’è l’arte?
Illustrazione copertina: dettaglio copertina edizione italiana, La nave di Teseo 2023
