«Io che sognavo di volare sopra i suoi respiri
Ma che i profili dei camini non li vedo mai
Perché tanti dei miei voli erano solo voli falliti
Come i primi tentativi dei fratelli Wright»
Murubutu, Dargen D’Amico, Ghemon, Levante
Il sogno, l’inestirpabile. Incubo, o desiderio? Li condensa entrambi. La vida es sueño, sentenziava Calderón de la Barca nel Seicento, già preceduto da Shakespeare e dal suo meditativo Prospero. «Ho sognato di vivere», scrisse tranchant Carmelo Bene in una delle sue poesie giovanili – adolescenza a cui faceva eco la maturità lacera di Theodor Adorno, secondo cui «i sogni felici, pienamente realizzati, si danno in realtà così poco come, secondo il detto di Schubert, la musica allegra». «Lo sai/ che il sogno/ è realtà/ un mondo/ inviolato» spirava Franco Battiato nella sua ultima canzone, Torneremo ancora, datata 2019 – ma già nel 1966 John Lennon avvertiva che vivere è fin troppo facile, ad occhi chiusi, proprio mentre si immergeva nella rievocazione della Strawberry Fields della sua infanzia.
Fedeli al sogno (Bollati Boringhieri) è il titolo del nuovo libro di Umberto Curi, prolifico saggista dall’alto profilo accademico. Il sottotitolo del volume, La sostanza onirica da Omero a Derrida, è promessa di una cavalcata piuttosto incalzante che il testo, nella sua discorsiva brevità, rispetta e mantiene. Dopo le immancabili cit. di occasione in apertura, celebri battute sul sogno di Borges e del Prospero shakespeariano, Fedeli al sogno affonda lo sguardo in prima battuta sul racconto di un presagio notturno che, nell’Odissea omerica, Penelope esponeva al misterioso visitatore che ancora non si era palesato come Ulisse; questo episodio di Omero ci porta subito al cuore del discorso di Curi, perché testimonia come sin dagli albori della cultura occidentale il sogno è stato interpretato come segno, rimando, messaggio cifrato, in una costante tensione ad escludersi, paradossalmente.

Bisognoso di spiegazione, di parafrasi, di interpretazione, il sogno occidentale non sogna mai sé stesso: tutt’al più è un Doppio sogno, quale era il titolo di una delle più importanti novelle di Schnitzler che Kubrick traspone al cinema come Eyes Wide Shut, “Occhi spalanchiusi”. Schnitzler che il suo concittadino Freud vedeva a sua volta come suo doppio: gemello di sguardo, impegnato a sua volta, in maniera indipendente ma con convergenze continue, in un’auscultazione abissale di tutte quelle zone della psiche e della fantasie umane che sfuggono al nostro diretto controllo. Eppure, è proprio Arthur Schnitzler uno dei numi tutelari a cui Curi si rivolge per condurre il suo discorso, che, per quanto possibile e senza risparmiare ammirazione, va proprio contro Freud, contro Omero e contro un millenario atteggiamento del pensiero occidentale, che – come sempre – Aristotele ha voluto mettere nero su bianco.
«L’animo, quando nel sonno è chiamato a sé stesso dall’unione e dal contagio col corpo, allora ricorda le cose passate, scorge quelle presenti, prevede quelle future», scrisse lo Stagirita in un suo dialogo giovanile, il Περὶφιλοσοφίας, per poi ritornare, in alcuni scritti della maturità, sulla questione, definendo il sogno come un ϕάντασμα, un’immagine, un’”apparizione”. E nell’Interpretazione dei sogni, Sigmund Freud indicò in Aristotele il primo ad affrontare “il sogno come un oggetto della psicologia”.
Da Omero, e dal sogno di Penelope, già autointerpretantesi; fino a Freud, alla sua Interpretazione volutamente postdatata dal 1899 al 1900 per rimarcarne il carattere epocale; passando per il carattere profetico ma cifrato dell’onirismo sancito da Aristotele, non per nulla il fatidico assertore del principio di non contraddizione – agli occhi degli occidentali il sogno è costante oggetto di indagine e di spiegazione. [Neanche i Romantici ne scampano, se la loro costante attenzione al sogno in fondo altro non è che la messa in scena di una dimensione altra, idealizzata, critica ma mai as-soluta nei confronti di un reale stantìo che, proprio perché criticato, rappresenta la conditio senza la quale la dimensione onirica nella temperie ottocentesca resterebbe lettera morta].

Nel fronteggiare questa duratura tradizione dell’Occidente nei confronti dei sogni, questo continuo bisogno di un’orinocritica, Curi chiama a sé come alleati un regista, che prevedibilmente è Fellini, uno scrittore, il già citato Schnitzler, e due pensatori volutamente e deleuzianamente “minoritari” rispetto alle usanze del pensiero dominante, Adorno e Derrida. Adorno che già aveva inserito un lacerante riferimento al sogno in un passaggio centrale della sua opera teoreticamente più impegnativa, la Dialettica negativa, parlando in un’ambigua terza persona di chi, ebreo come lui, era costretto a vivere dopo Auschwitz: «per espiazione lo visitano sogni come quello di non vivere più, ma di essere stato ucciso nelle camere a gas nel 1944 e di vivere da allora l’intera esistenza solo nell’immaginario, emanazione del folle desiderio di un assassino vent’anni or sono». Ma che sogni si saranno fatti nei Lager? Ci viene in soccorso, un po’ inaspettato, Primo Levi: «sognavamo nelle notti feroci/ sogni densi e violenti/ sognati con anima e corpo/ tornare; mangiare; raccontare», rievocava nella poesia che apre La tregua. Si sognava il futuro, in un certo senso – il futuro di chi effettivamente è riuscito a tornare; proprio come Adorno, esule per tempo in America, sognava al contrario di essere morto. Rivolti al passato sembrano invece essere i sogni dei malati terminali, secondo alcuni studi di psicologia della morte: sogni di riconciliazione, che rimuovono vecchi rancori, o sogni di riapparizione, in cui riaffiorano alla memoria parenti e amici morti da tempo, quasi volessero accompagnare il moribondo in ciò che lo attende dopo la vita.
Di Adorno, questo Fedeli al sogno di Curi recepisce soprattutto il suo personalissimo e a lungo privato diario onirico, la Traumprotokolle pubblicata per la prima volta nel 2006, ed edita in Italia come I miei sogni, e un singolo passaggio di un saggio adorniano su Walter Benjamin: nel commemorare l’amico morto suicida sulla frontiera spagnola pur di scampare alla persecuzione nazista, Adorno gli riconosceva di essere riuscito, incredibili dictu, a unire misticismo e Illuminismo, vale a dire “bandire il sogno senza tradirlo”. E così come Benjamin viene letto attraverso il Prisma di Adorno, allo stesso modo lo stesso Adorno viene letto attraverso gli occhi di Jacques Derrida che, vincitore nel 2001 del premio intitolato al filosofo tedesco, pronunciò un’orazione poi andata alle stampe sotto il titolo de Il sogno di Benjamin. Il cerchio si chiude, è una triangolazione: Benjamin, Adorno, Derrida, e poi di nuovo Benjamin, a mo’ di loop.
Il sogno di Benjamin prendeva spunto da un episodio di vita vissuta: Benjamin raccontò a Soma Morgenstern e Siegfried Kracauer un suo sogno che riguardava Karl Kraus, e Adorno al suo fianco rimpinguava il racconto di dettagli. «Hai notato che Teddy conosce perfino i miei sogni e mi ha aiutato a raccontare il mio?», pare che Benjamin, impressionato, commentò con la Morgenstern. «Lui mi segue fin dentro i sogni». Per Derrida, questo episodio non è altro che uno spunto per chiedersi se «un sognatore sarebbe in grado di parlare del suo sogno senza risvegliarsi… senza tradire il sonno». Se un filosofo variamente razionalista-illuminista negherebbe questa chance, le risposte «del poeta, dello scrittore o del saggista, del musicista, del pittore, dello sceneggiatore di teatro o di cinema» lascerebbero uno spiraglio aperto alla potenza autointerpretativa del sogno: «non direbbero no, ma sì, forse, talvolta». Thus spracht Derrida.
È inserendosi tra le maglie della triangolazione Benjamin-Adorno-Derrida che Curi declama apertamente la tesi del suo scritto, già abbondantemente echeggiata sin dalle pagine su Aristotele e Freud: al posto o perlomeno al fianco di ogni orinocritica e di ogni orinotecnica, di tutta quella smania interpretativa di cui s’è nutrito l’Occidente nei confronti del proprio bagaglio onirico, bisognerebbe far parlare il sogno in prima persona, dargli diritto di voce e di espressione. Non tanto come facevano i surrealisti, ci verrebbe da precisare, legati, [non meno dei romantici], a un’ansia di critica della realtà e della società tale per cui non sarebbero potuti esistere non ci fosse stata una struttura da violare, qualche Gioconda da parodiare: secondo Curi, rispetto al sogno bisogna “indugiare sulla soglia” e, se si ha la forza di uno Schnitzler o di un Kubrick, affidarsi alla sua forza. Una forza che risulta essere autonomamente – ma non per forza criticamente – Altra, rispetto a quella della veglia.
Pure sorprende che, in un testo bene o male così impregnato di una rilettura critica del primo Freud, citazioni a Jung siano invece praticamente assenti: Jung stesso aveva in parte criticato la teoria delle interpretazioni oniriche di Freud, pur avendo, dal canto suo e prima della loro lettura, ascoltato e interpretato freudianamente alcuni sogni di Freud, di cui non volle rivelare il contenuto neanche vent’anni dopo la morte del vecchio maestro; tuttavia, pur ritenendo eccessivamente causalistica l’Interpretazione dei sogni freudiana, a sua volta Jung visse più volte i propri stessi sogni come prefigurazioni e quindi rimandi ad eventi di là da venire. Di nuovo, contravvenendo alle speranze di Derrida, sui sogni si profila l’ombra lunga dell’interpretazione, sia pure d’altro segno rispetto a quella freudiana: per tutta la vita, Jung continuò a dire che aveva “predetto” lo scoppio di una guerra mondiale già con un sogno apocalittico del 1913, e, d’altro canto, per gli ultimi vent’anni della sua vita ripeté a più riprese che per essere sicuro dello scoppio di un secondo conflitto globale gli era bastato ascoltare i sogni dei suoi pazienti tedeschi.
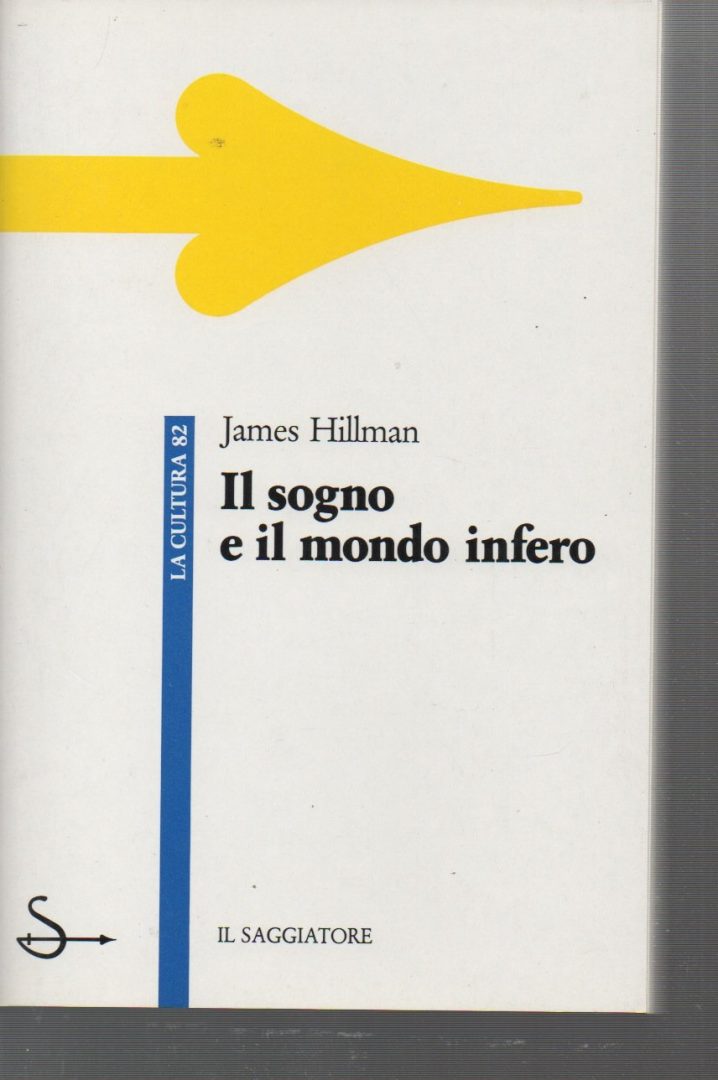
Altro assente, questo anche più sorprendente, dal testo di Curi è James Hillman, psicologo “post-junghiano”: il suo Il sogno e il mondo infero, datato 1979, dava spazio a un’interpretazione archetipica dei sogni. Hillman si rifiutava di analizzare i sogni secondo i “metodi opposti” di Freud e di Jung, asintoticamente protesi a concordare che, bene o male, ogni sogno «esige di essere tradotto nella lingua della veglia»; la tesi di Hillman invece «si oppone alla traduzione dei sogni nella lingua dell’io» per affermare che ogni sogno rappresenta «la psiche che parla a sé stessa nella propria lingua». Eppure secondo Hillman Freud aveva ragione a presentarsi come un novello Dante, un Dante dei concetti: se l’atteggiamento da tenere nei confronti dei sogni è quello di «andare loro incontro all’altro capo del ponte, nel loro territorio», la vita onirica apre a una dimensione originariamente ctonia. Hillman allora si sforza, non meno di Curi ma con una prosa più miticheggiante, di evidenziare l’autonomia e l’irriducibile specificità dei sogni, invitando i suoi pazienti e i suoi lettori a fare esperienza lì, nella vita onirica, dell’autenticità della loro anima. Forse i proponimenti finali de Il sogno e il mondo infero non hanno una chiarissima applicazione in sede di analisi, e infatti Hillman è passato alla storia della disciplina più come saggista che come terapeuta, ma rappresentano un’esperienza letteraria ed esistenziale non meno densa di quella provata dai milioni di persone che, dal 1899-1900 ad oggi, hanno sfogliato la freudiana Traumdeutung.
«L’abisso in cui mi spingi è già dentro di te», annunciava la Sfinge ad Edipo nell’adattamento cinematografico, firmato da Pasolini, della più freudiana delle tragedie. Film che non a caso si apriva con un sogno, o un ricordo, un sognare di vivere, un sognare di nascere, che contravveniva al tempo mitico riambientando le vicende della nascita di Edipo nella Bologna degli anni venti, la Bologna che aveva dato i natali anche al regista. Tutto strabocca di senso, fino a perderlo: gioco di specchi, lungo una linea d’ombra, dal momento che il sogno non mente mai, eppure il sogno non mente niente. Il sogno non dice nulla, il sogno dice tutto. Il sogno, per una buona volta, eccede il significato, trasmigra ogni piano del discorso par de-là ogni principio di non contraddizione e ogni venia di identità. È per questo che, al netto di ogni surrealismo, tornare al sogno sa essere vitale: vitale, eppure anche mortifero. Tanto Chagall quanto Kirchner sono pittori “onirici”, eppure è abissale la loro distanza di toni. Allora, forse, più di tutti aveva ragione un Tarkovskij: che senza dimenticare che ogni sogno è sintomo di stanchezza, anche e soprattutto i sogni fatti ad occhi aperti, non mancava ad ogni inquadratura di rimemorarne il valore redentivo. Orfeo vi avrà pure perduto Euridice, ma dal “mondo infero” di cui parlava Hillman lui ha saputo finanche ritornare – alla luce.
