L’attualità di un intellettuale non più del nostro tempo è spesso un accorgimento di comodo, l’armamentario più alla mano per piegare il suo sistema di pensiero alle nostre, vere o presunte, necessità. Dire che un certo pensiero del passato s’attaglia alla perfezione al nostro presente, quasi che il suo autore avesse avuto occulte facoltà profetiche, è spesso un luogo comune, e in quanto tale vuoto di senso.
Per questo ci ho pensato su bene, prima di formulare la frase che mi accingo a deporre sulla pagina, a costo di contraddirmi platealmente… Ecco, molte delle parole contenute in questo breve saggio La nostra fede (Aras edizioni) dedicato alla “fede”, ma non in senso stretto, convenzionale, di Piero Gobetti, paiono fatte apposta per questo presente. Per i tanti mesi che abbiamo trascorso confinati e impauriti, smarriti dentro la pandemia ma anche dentro i tanti vuoti di senso che il virus ha portato con sé, per tutti noi.
Questo saggio è in fondo proprio una ricerca del senso vero, profondo, spesso, che alcune parole hanno perso, strada facendo. Allora, quando lui scriveva. E ora, dentro il nostro presente. Così, voglio provare a ridare profondità, vorrei dire tridimensionalità ad alcune di queste parole, ascoltando quelle di Giorgio Fontana, che ha frequentato questo saggio, l’ha curato e direi anche, senza tema di smentite, amato.
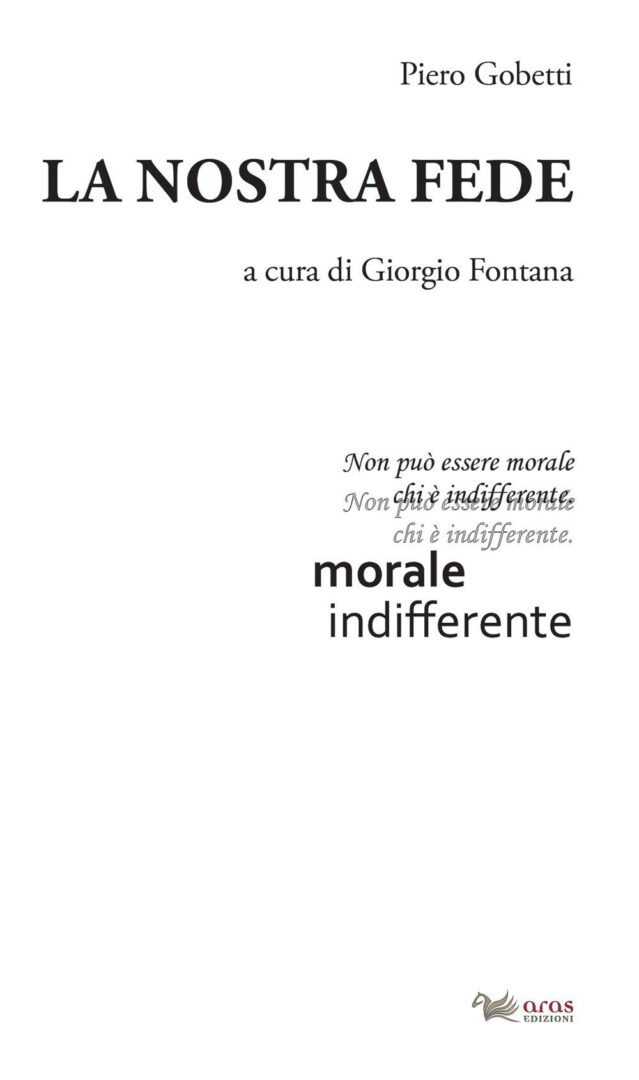
Piero Gobetti esprime a un certo punto il suo «scetticismo per le idee generali (generiche)» e ci spiega che se in «filosofia c’è la coincidenza perfetta di pensiero e azione» bisogna stare molto attenti a non confondere politica e filosofia. Una buona politica, ci dice, «è sempre morale». Se capisco bene, questa sua avversione per le idee generali è quella di chi è sempre attento a riconoscere i “vuoti d’aria” del discorso. È così? Se è così, più attuale di così…
Sì, Gobetti ha una profonda allergia verso le idee generali, figlie di quella che lui chiama politica deduttiva: si immaginano schemi buoni per ogni occasione, “idee toccasana”, che saranno magari graziosamente disposte in un sistema filosofico, ma non hanno presa alcuna sulla complessità del reale. Lo spiega molto chiaramente nelle righe successive, quando sottolinea che in politica intervengono sempre nuovi elementi, e questo richiede di effettuare delle previsioni pratiche — campo in cui appunto «non si ragiona di filosofia». A ciò si lega un’altra fondamentale cautela: la moralità della politica non nasconde che vi siano «uomini che cercano il benessere universale ed altri no».
Quindi nessuna visione irenica o contemplativa delle cose, nessuna soluzione preconfezionata da applicare comodamente alla realtà a suon di slogan, bensì un chiaro riconoscimento del conflitto di desideri e interessi che anima la società reale. È in mezzo a questo conflitto, e non al di fuori di esso, che si deve praticare la militanza: e la critica gobettiana qui tocca un nervo scoperto anche oggi. Le sue parole sullo svuotamento di senso dei partiti e sulla loro deriva astratta, puntellata da formule ripetute a macchinetta, andrebbero meditate a lungo da chiunque voglia fare politica attiva.
Come dicevo, in questo saggio mi pare di riconoscere alcune parole guida. Una è certamente “libertà”. Questa parola ha assunto negli ultimi mesi una accezione – o meglio una distorsione – inedita: quella di chi la professa in nome dell’indifferenza al virus e alla salute (propria e altrui). Così la libertà ha perso un suo componente essenziale: la responsabilità. È una cosa cui faccio spesso riferimento, perché mi pare molto calzante: in ebraico la parola “responsabilità” è calcata sulla radice che significa “altro”. La responsabilità è di fatto il riconoscimento del nostro prossimo. Anche in Gobetti c’è il principio di un «rigido senso di responsabilità». Qual è per lui il nesso fra libertà e responsabilità?
La libertà resta certo il tema fondamentale per Gobetti: l’assenza di autonomia è per lui l’ostacolo principe alla crescita di una nazione autenticamente moderna. Ma è lontanissimo dal proporre un’immagine della libertà come irresponsabilità o negazione del prossimo; anzi, è nello scontro aperto fra diverse volontà che si formano cittadini coscienti e consapevoli, che sappiano verificare l’autentico peso delle proprie scelte. Senza il riconoscimento radicale dell’altro, essere liberi si ridurrebbe a una forma di tirannide.
Così l’umanesimo gobettiano offre una perfetta definizione di democrazia, alla cui base sta «l’affermazione della legittimità di ogni forma di pensiero, e la negazione di tutte le rivelazioni di verità», e che trova nella sua parte sana la «parità di diritti e di doveri, dell’uguaglianza di possibilità». Nella Rivoluzione liberale, qualche anno dopo, parlerà di Mussolini come di una «prova sperimentale dell’unanimità»: nel cosmo violento della dittatura ogni minoranza viene repressa, così come ogni eresia — e intenderei qui la parola andando alla radice greca, airesis, scelta. L’autonomia viene cancellata dalla promessa del grande capo che si occuperà di tutta la tua vita: non è soltanto un osceno svilimento dei diritti individuali; è anche una completa diseducazione alla politica, un invito all’indifferenza e al più alla delazione.
Ora, tutta la vita di Gobetti — fino alla tragica fine — sono una testimonianza della sua querela contro questo modo di pensare, e insieme della sua altissima responsabilità. A tal proposito, nel 1934 Carlo Rosselli fece un’osservazione che mi ha sempre colpito: «Era fatale che morisse l’antifascista-tipo, Matteotti, eroe tutto prosa. Come dovevano morire nello stesso torno di tempo Amendola e Gobetti. Come dovranno morire, se non li salveremo, Rossi, Gramsci, Bauer e molti altri Matteotti che si sono formati in questi anni. Tutti caratteri, psicologie che sono l’opposto del carattere e della sensibilità mussoliniane. Mussolini sente, sa quali sono i suoi autentici avversari. Ha il fiuto dell’oppositore. Imbattibile con uomini del suo tempo, singolarmente impotente con uomini che sfuggono al suo orizzonte mentale. Perciò li sopprime. Uccidendo Matteotti ha indicato all’antifascismo quali debbono essere le sue preoccupazioni costanti e supreme: il carattere; l’antiretorica; l’azione.» Come purtroppo sappiamo, Gramsci e Rosselli stesso pagarono fino in fondo le conseguenze della loro militanza. Certo i tempi sono cambiati e fortunatamente non viviamo più in un regime dittatoriale; ma quest’idea di un antifascismo fondato su «carattere, antiretorica e azione» — tre parole che si attagliano benissimo all’esperienza gobettiana — mi pare quanto mai attuale.
Mi è piaciuto molto anche quello che spieghi nella tua prefazione e che dipana nel testo il cuore del testo stesso, e cioè la fede intesa non tanto come un muto rimettersi a una volontà superiore in parte palesatasi e in parte imperscrutabile, ma come un «atteggiamento spirituale che dà sostanza all’atto di sperare». La fede è insomma la cognizione del futuro, e la consapevolezza che il futuro può essere molto diverso dal presente e dal passato. In queste pagine Gobetti ci parla in realtà della fede politica: è così che chiede alla politica uno sforzo di immaginazione? Atto di fede cioè atto di sperare cioè capacità di immaginare e provare a costruire ciò che ancora non è?
Senza l’elemento fideistico, la politica si ridurrebbe ad amministrazione del presente; una visione implicitamente conservatrice, che si priva della dimensione di rischio. La pandemia ha provocato una crisi globale senza precedenti, o per meglio dire è stata l’esplosione di una crisi climatica e sociale in corso da tempo: i segnali d’allarme c’erano, ma sono stati ignorati; un esempio davvero evidente di politica non solo priva di fede, ma anche di una qualunque lungimiranza. Gli editoriali ripetono che dopo questo anno dovrà cambiare tutto, che non potremo più vivere come prima; ma la verità è che non è stata presa nessuna decisione autenticamente radicale (e necessariamente impopolare), sia per opportunismo sia per pigrizia immaginativa.
E non si tratta soltanto di mutare il proprio stile di vita individuale — una scelta certo importante ma insufficiente, tanto quanto il vittimismo o la sterile lamentazione. Del resto La nostra fede è tutta declinata alla prima plurale, fin dal titolo: in gioco non ci sono soltanto le credenze e le speranze di un io, ma la volontà di un noi che deve ancora farsi, e coinvolgere il maggior numero di persone possibili.
A mio avviso, con tale scelta grammaticale Gobetti lancia una sfida alla sua generazione e propone anche una chiamata che attraversa i decenni. Come ho già detto, è ovvio constatare le differenze politiche e sociali fra l’Italia d’oggi e l’Italia di allora: e come dicevi bene tu, attribuire a un autore facoltà profetiche è rischioso; eppure anche con tutte le cautele del caso, mi pare impossibile leggere La nostra fede quale mero reperto storico. Questo testo ci parla direttamente, soprattutto per la sua viva idealità: una fede tutta laica che è capacità di immaginare e passione, profonda passione per le sorti dell’uomo; un idealismo pratico che spinge a «realizzare tutta la nostra possibilità di azione per noi e per gli altri in ogni istante». Proposito difficilissimo, certo: e anche per questo nella prefazione mi permetto di affermare che non ci si può dire gobettiani con leggerezza.
«Almeno metà di tutto Gobetti» scrivi ancora, «sta nel verbo studiare». Altra parola bellissima! Gobetti si riserva la “presunzione” di studiare. Prima studiare e poi decidere, fare. Ribellarsi. Dobbiamo allora trovare un modo nuovo di studiare o sarebbe ora di ritornare a studiare come si è sempre fatto? Se posso aggiungere una nota personale, quello che più mi manca del mio tempo passato è studiare: il resto ha fatto il suo tempo, e come dice il Qohelet, ogni cosa a suo tempo… ma studiare come studiavo allora, da giovane, non c’è più. E manca. Manca quella sete. Gobetti è morto a 25 anni, e di quella sete ne aveva ancora tanta.
Sì, quella è una riga davvero illuminante e, direi, confortante: contro le pretese spicce del rivoluzionarismo o del conservatorismo, egli rivendica di inquadrare il problema con «la presunzione di studiarne gli elementi per vederne la soluzione». È un compito che parte innanzitutto da se stessi, con umiltà: come preciserà nella Rivoluzione liberale, «educando noi, avremo educato gli altri» (ancora l’uso della prima plurale!).
Credo che uno dei pericoli maggiori del discorso pubblico contemporaneo sia la fretta che lo permea, il bisogno continuo di mettere in circolo opinioni male argomentate. La sincerità anche brutale della reazione e la pretesa buona fede sembrano più importanti di un’attenta riflessione e di proposte concrete, ma è difficile che conducano da qualche parte: al più alimenteranno il mare di indignazione e sarcasmo in cui ci dibattiamo.
A tal proposito Gobetti parla di «normalità intensa»: un’espressione che mi è molto cara, perché combina due aspetti tipici del suo metodo e della sua vita. Da un lato l’idea di un impegno quotidiano — lo studio e l’analisi come «conquista progressiva», che non si disperde in frammenti né scoppia in azioni inconsulte. Dall’altro l’intensità e l’ardore dell’impegno, che pulsano con forza nello stile della Nostra fede: un elemento emotivo senza cui è facile diventare meri burocrati, o vedere nell’essere umano un mezzo e non un fine. Una normalità senza fede è grigia; una fede senza studio e lavoro è cieca.
Nell’Apologia della storia, Marc Bloch scrisse: «Un motto, in sintesi, domina e illumina i nostri studi: “comprendere”. Non diciamo che il bravo storico è estraneo alle passioni; ha per lo meno quella. Motto, non nascondiamocelo, carico di difficoltà, ma anche di speranze. Soprattutto, motto carico di amicizia. Persino, nell’azione, noi giudichiamo troppo. È comodo gridare “a morte!” Non comprendiamo mai abbastanza.» Già.
