Un uomo trascorre le giornate in veranda, seduto su una sedia a dondolo. Si muove a fatica, tanto che spesso ha bisogno dell’aiuto degli altri.
Da una casa di fronte un vicino lo spia. Studia i suoi movimenti, le abitudini.
L’uomo che spia non sa di preciso cosa lo attragga dell’altro, ma ne è così ossessionato da accarezzare addirittura l’idea di contattare un’agenzia immobiliare e traslocare in un appartamento con una visuale migliore, che gli permetta di osservare quell’uomo malato, di cui non sa nulla, anche quando è in casa.
Spiare la prima persona non è solo l’ultimo libro scritto da Sam Shepard prima di morire, è la lucida descrizione del rapido avanzare della SLA, la terribile malattia neurodegenerativa che lo ha prima ridotto su una sedia a rotelle e poi ucciso.
«La situazione è cambiata di nuovo. Cambiata. Adesso lui deve chiedere agli altri. Adesso non può fare a meno degli altri. La situazione è davvero cambiata». L’impossibilità a eseguire i movimenti più banali, un tempo affidati all’istinto, lo gettano nel panico.
Potete immaginare, per esempio, qualcosa che vi striscia in un orecchio? Immaginarlo è facile. Vi striscia nell’orecchio. E in breve fa solletico. Immaginarlo è facile. Che vi striscia tra i capelli. C’è qualcosa che mi striscia tra i capelli? C’è una formica, per esempio. Un verme? Una mosca? Un insetto alato? Una zanzara? Un insetto con molte zampe. Un insetto con molti tentacoli che mi sta frugando tra i capelli in cerca di una cosa immaginata? Voi immaginate e poi continuate a immaginare il prurito e in breve lo sentite. E in breve chiedete aiuto.
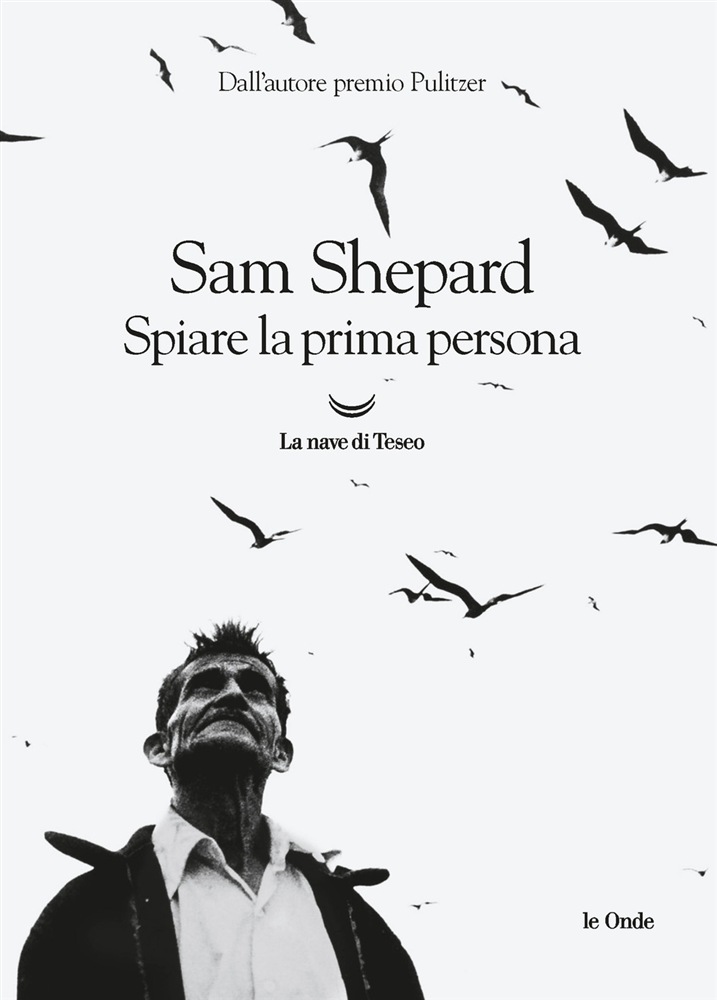
Se l’uomo seduto in veranda, l’uomo paralizzato, è facile identificarlo con l’autore – o piuttosto con una sua proiezione letteraria – chi conosce la scrittura di Shepard si accorgerà però che è suo anche lo sguardo dell’uomo che spia.
È lo stesso Shepard, a un certo punto del libro, a sovrapporre i due personaggi:
Non posso non avvertire una somiglianza tra lui e me. Non so di che si tratta. A volte sembra che siamo la stessa persona. Un gemello perduto. Le soppracciglia. Il mento. Il fremito di un orecchio. Le mani in tasca. Questo modo degli occhi di sembrare insieme sicuri e smarriti.
Abituato a osservare la realtà libero dai pregiudizi dell’abitudine, l’impressione è che Shepard abbia avvertito il bisogno di trattare l’avvicinarsi della propria morte come se riguardasse un altro. La malattia lo mette alla prova, ma attraverso lo sguardo dell’uomo che spia riesce a descriverla, ne accetta l’esperienza, forse l’unica forma di salvezza a cui – non solo uno scrittore – ma ogni essere umano può ambire.
Il libro procede con l’andatura rapsodica tipica della prosa di Shepard. Un mosaico che solo al termine del libro si compone – non so se sia giusto dire in un tutto – ma in qualcosa di vivido e ipnotico, con le sue ripetizioni, i suoi inciampi, il ritmo incalzante, proprio di un drammaturgo. Brevi capitoli in cui viene narrata l’uscita di scena e la morte di Pancho Villa si alternano a quelli dell’arrivo in America dei nonni, ad altri che raccontano dell’omicidio di un cavallo durante un rodeo e l’evasione di tre detenuti dal carcere di Alcatraz. Senza dimenticare le pagine autobiografiche, le più struggenti e inattese. Perché Spiare la prima persona è anche il libro in cui l’immagine solitaria di Shepard si scioglie nell’affetto verso i figli e i parenti più stretti, al suo fianco fino agli ultimi istanti di vita e che, dopo la morte, si prenderanno cura della revisione finale del testo.
Saranno state le sei o le sette. Io ero su una sedia a rotelle, con una pecora di pelle a brandelli sul sedile e una coperta navajo sulle ginocchia, e ai lati i miei due figli. Due dei miei figli, Jesse e Walker, mi spingevano al centro di East Water Street. Non dimenticherò mai la forza che sentivo nei miei due ragazzi alle mie spalle. Dietro di noi veniva mia figlia Hannah, due amici suoi, le mie due sorelle e mia nuora, noi nove tutti insieme.
A legare insieme spunti così distanti tra loro è la stessa inquietudine di fondo, lo stesso refrain, che muove la poetica di Shepard sin dagli esordi: la realtà è piena di insidie e di trame incomprensibili, e così il passato e il futuro. A ogni fase dell’esistenza manca sempre un pezzo in grado di risolverla o perlomeno di comprenderla. Non resta altro allora che disseminare la pagina di punti interrogativi. Non serve contarli per rendersi conto del loro peso specifico all’interno del libro. Anche questa è una delle peculiarità della scrittura di Shepard, forse la più lampante.
In Motel Chronicles, la sua prima prova da narratore (ma nel ’79 aveva già vinto un Pulitzer con il dramma Il bambino sepolto), uno dei frammenti più belli e stranianti racconta del ritrovamento di un uccello acquatico sull’asfalto di un parcheggio. Un uccello arrivato da chissà dove e misteriosamente precipitato al suolo. Insieme al padre il narratore raccoglie l’uccello e – per saperne di più – lo porta nel laboratorio di un tassidermista. Il tassidermista però non fa che confermare quello che padre e figlio già sanno: si tratta proprio di un uccello acquatico, ma di una specie sconosciuta. La storia potrebbe terminare a quel punto. Ma Shepard non può fare a meno di immedesimarsi nell’uccello e di farsi domande su quella morte inspiegabile:
Continuavo a mettermi nei panni dell’uccello, che volava alto sopra il parcheggio, diretto verso un lago. Perché un uccello come quello avrebbe dovuto essere così lontano da una regione di laghi innanzitutto. E poi come poteva perdersi un uccello?
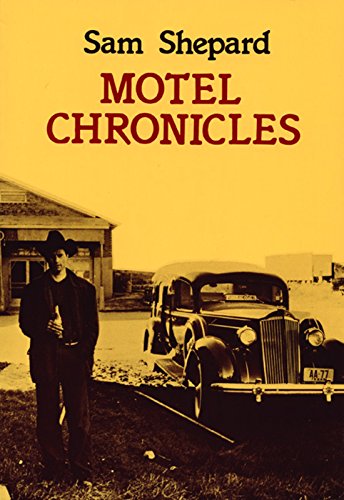
È lo stesso effetto di smarrimento che si avverte in Haskell, Arkansas, uno dei racconti di Diario di lavorazione (come i punti interrogativi anche i nomi dei luoghi, insieme alle date, sono una caratteristica della prosa di Shepard). Stavolta a giacere sull’asfalto è una testa mozzata, trovata da un automobilista lungo una delle tante statali che collegano l’interno degli Stati Uniti. La testa parla e cerca di convincere l’uomo a esaudire il suo unico desiderio, quello di essere trasportata in un laghetto non lontano da lì.
«Non credo di avere la forza fisica per farlo», le risponde l’uomo. Ma nel frattempo tra i due si instaura un misterioso rapporto di dipendenza, che costringe l’uomo a caricarsi la testa parlante sopra la sua e a dirigersi verso il punto indicato.
«È come avevi sperato?» chiede l’uomo una volta arrivati in prossimità del lago.
«Lo sapremo quando saremo lì» gli risponde laconica la testa.
Senso di smarrimento che muove – inesorabile – anche i ricordi d’infanzia.
Gli enormi dinosauri disposti in cerchio nella prateria, durante un viaggio in macchina nel Sud Dakota insieme alla madre, sempre in Motel Chronicles:
Sgusciammo lentamente fuori e dentro i dinosauri. Tra le loro gambe. Sotto le loro pance. Girammo intorno al Brontosauro. Alzammo gli occhi sui denti del Tyrannosarus Rex. Avevano tutti delle lucette azzurre al posto degli occhi.
Non c’era nessuno in giro. Solo noi e i dinosauri.
Per non dire del legame morboso tra May ed Eddie in Pazzo d’amore, la pièce teatrale adattata al grande schermo da Robert Altman con Shepard nel ruolo di protagonista, disseminata di rimandi a un passato oscuro e ineludibile, segnato da un incesto.
«Siamo legati, May, noi saremo sempre legati. È stato deciso molto tempo fa».
Non c’è mai una visione d’insieme capace di riscattare il proprio vissuto.
«Il passato non arriva mai tutto intero. Arriva sempre a pezzi. (…). Si presenta come se fosse stato vissuto in frammenti».
Lo stile disorganico di Shepard sembra allora rispondere a un’esigenza ontologica ancora prima che di forma, come se solo attraverso l’accumulo di particolari sia possibile intuire quella verità che ci sarà comunque negata.
La brevità dei suoi libri appare oggi meravigliosamente inattuale al cospetto di un mercato editoriale sempre più ostinato a pubblicare narrativa di una prolissità scoraggiante, che qualsiasi editore accorto sfronderebbe di parecchie centinaia di pagine.
Le storie di Shepard, nella loro chirurgica concisione, hanno invece il dono di riverberare nel tempo, continuano a espandersi, fino a penetrare in quello spazio comune che comprende il vissuto di ognuno di noi.
Le 99 pagine di Spiare la prima persona, seppure siano le ultime, non hanno nulla dell’epitaffio. Suonano al contrario come la prova di uno scrittore vivo fino all’ultimo e ancora in cerca, non di quelle risposte che sa di non poter ottenere, ma di altre domande.
Foto di copertina: Graciela Iturbide
