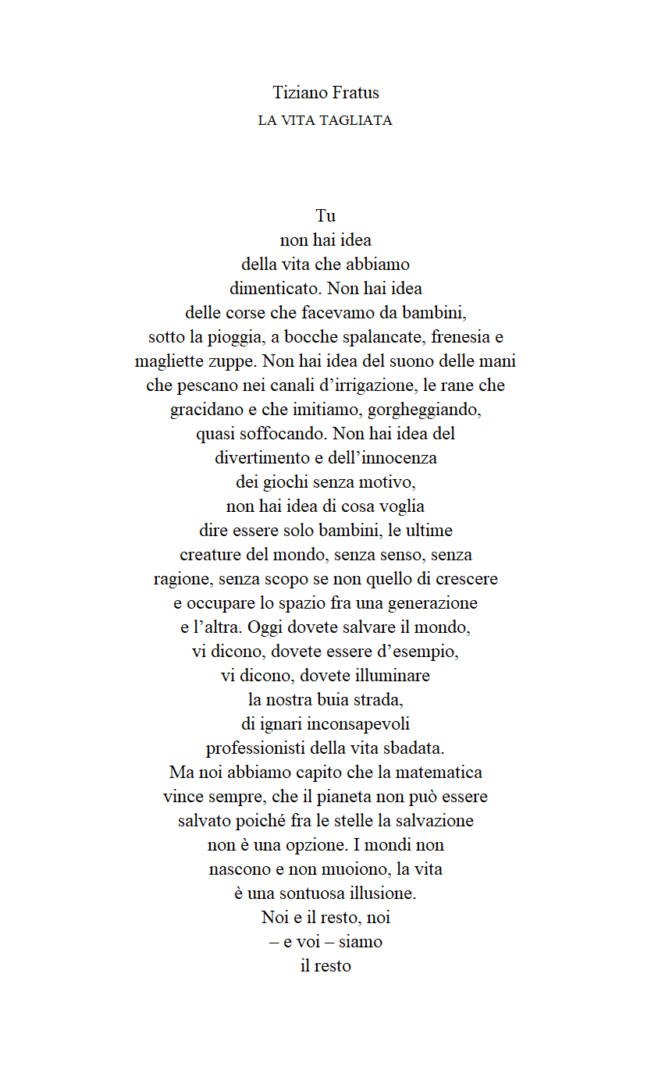In quest’ultima manciata di anni mi sono spesso imbattuto in testi che declamano la magnificenza dell’abbandono in una foresta. È uno dei temi a me cari, ma vedo, al contempo, che sempre più spesso si incontrano autori, in ogni parte del mondo, che si misurano e scrivono di fughe, di ritiri, di eremitaggi laici sparsi nelle profonde province del mondo o, su montagne, in boschi, nelle vastità dei grandi settentrioni. Fino a pochi anni fa imbattersi in opere del genere – riflessive, spirituali, contemplative – era codificato e abituale se si trattava di personalità religiose, si pensi ad esempio al caso dei romanzi e dei testi e delle poesie di Thomas Merton, padre trappista, piuttosto che ad una figura a me cara e che cito così spesso, Adriana Zarri, o ancora agli asceti indiani, agli americani ottocenteschi in cerca di un Dio a forma di corteccia – Thoreau, über alles – i maestri buddisti moderni e contemporanei. Ma da un decennio in qua nella mia generazione, nella generazione più avanti della mia, quanto nelle generazioni più giovani della mia, c’è un’epidemia di ritiri, abbandoni, allontanamenti, crisi, fughe, cedimenti, rifiuti della società e delle sue norme. Ne era stata sentinella l’esperienza di Chris McCandless e del film che ne descriveva l’avventura, l’epico e tragico Into The Wild diretto da Sean Penn. Quella che era una modalità di comunicazione tipica di coloro che abbracciavano una vita monastica, o dei pochi, coraggiosi, o forse anche presuntuosi, spiriti solitari, oggi è diventata una forma molto battuta e ripetuta. Esistono addirittura collane editoriali che ne “incartano” le parole, i pensieri, le citazioni, le esperienze. Piccola filosofia di viaggio della Ediciclo, collana vendutissima, formato preso in prestito dalla parigina Transboréal. Ma oramai di narrazioni di questo tipo se ne incontra in tutti i cataloghi, dagli editori più diffusi e rilevanti, per così dire, agli indipendenti di vario ordine e grado, da Feltrinelli, Einaudi e Mondadori a Laterza e Ponte alle Grazie, da La nave di Teseo a Sperling & Kupfer, da SE a Casagrande, da Piano B e Bolis ad Adelphi e Neri Pozza. Un florilègio di canti solipsistici che incontrano verità in un tempo altro, familiarità e casa in luoghi remoti, uno scopo di vita cucito nella distanza dal resto degli umani. Quanti autori, e quante opere! C’è forse da preoccuparsi di questa fuga così copiosa, composta da persone spesso che hanno studiato nelle università, che hanno anche avuto occasioni per infiltrarsi nei meccanismi sociali e professionali, eppure si scappa, si fugge, ci si inforesta per cercare altro. È un meccanismo macroscopico anche nelle pagine dei profili Facebook o Instagram: quante persone si fotografano in luoghi desolati e naturali, quanti alberi, quante cascate, quante baite sognate alla fine del mondo!

Fra i tanti esempi che potrei fare pesco nel mucchio il breve romanzo Nella tana (2018, Lindau, titolo originale Encabanéè, che fa il verso, credo inconsapevolmente, alla succinta esplorazione La vie en cabane del francese David Lefèvre, classe 1973, da noi edito da Ediciclo) della giovane canadese Gabrielle Filteau-Chiba, québéquoise, classe 1985. L’incipit: «Me la sono svignata. Saint-Bruno-de-Kamouraska non è proprio dietro l’angolo, ma mi lascio alle spalle la malinconia della metropoli e degli automi dai conti in sofferenza. Ogni chilometro che mi allontana da Montréal è un passo in più nel pellegrinaggio verso l’unica cattedrale che mi ispiri la fede, una foresta profonda che accoglie tutte le mie confessioni. Questa piantagione di abeti rossi, cresciuti rigogliosi e fieri come montagne, è il tempio del silenzio in cui si erge la mia capanna. Un rifugio a lungo sognato, fin dai tepee che costruivo coi rami, da piccola.» Queste righe le avrei potute scrivere io stesso, o le avrebbe potute scrivere Paolo Cognetti, o ancora Davide Sapienza, Luigi Nacci, Franco Michieli, Cristina Noacco, Antonio Moresco, Nanni Cagnone, Laura Pugno e quanti poeti e narratori e viaggiatori e camminatori che ho incontrato in questi vent’anni di parole e boschi. Inizialmente mi infastidiva – lo so, è sciocco, è cretino, ma era così – perché cadevo nel tranello che il silenzio e la solitudine spesso ti imbrogliano, e quando te ne accorgi è spesso già troppo tardi: ovvero che la qualità del mio silenzio conquistato e poi tradotto, in qualche modo, su carta, in versi o in prosa, era ineguagliabile, che nessuno, in questi stessi anni potesse fare o sentire allo stesso modo, o addirittura meglio. Purtroppo un inciampo in cui siamo caduti e cadiamo in molti. E serve leggere, o se serve! Quanto è preziosa l’esperienza degli eremiti con una matita sempre in mano, nei secoli passati, per comprendere quanto certe traiettorie siano legittime, affascinanti e difficili, severe, formative, ma comunque già percorse, già vissute, già incarnate, che siano i maestri buddisti dell’anno Millecento, che siano i journals del grande Thoreau (la prima edizione italiana sta, finalmente, per uscire), le poesie di Emerson o le nostre recenti battiture su carta e su tablet.
Se molti sono coloro, soprattutto fra le menti più intellettualistiche, che respingono la società e i meccanismi ordinari di convivenza, dall’altra si assiste ad un desiderio di protagonismo che investe le nuovissime generazioni, come testimonia il movimento delle cosiddette Sardine, che in questi ultimi mesi ha riempito le piazze d’Italia. Sono in parte preoccupato per questo costante desiderio di esibizionismo, che i giovani hanno e ambiscono a vivere, come se l’esser cresciuti anche dentro uno schermo li avesse resi avvezzi a doversi rapportare con un pubblico. Poche sono le idee, ma molte le rivendicazioni. La mia generazione non si sarebbe mai sognata di protestare così presto, nel proprio percorso, e quando mi confronto con persone più mature di me il primo grado di sconcerto nasce proprio dalla più semplice delle domande: ma cos’hanno da pretendere se sono così giovani e oltremodo hanno avuto tutto dalla vita, mica conoscono la miseria, la povertà, gli ostacoli che conoscevamo noi? Eppure, è anche vero che ogni generazione si confronta con i propri limiti, con i tabù e le crisi del proprio tempo. Ma qui ci si allontana e preferisco tornare all’argomento iniziale.
Sempre dal romanzo di Gabrielle Filteau-Chiba: «All’inizio del mio esilio alla capanna mantenevo la cognizione del tempo come fosse un filo di Arianna. Un censimento delle ore, quasi fossi trattenuta qui contro la mia volontà. I miei scarabocchi serali sul diario erano come i segni tracciati da un prigioniero sul muro della cella, la routine d’un naufrago su un’isola inospitale. Poi, una sera, a fine febbraio, le mie idee più cupe sono state sconvolte. Lei era lì, fuori dalla mia finestra. Tanto attesa […] la mia prima aurora boreale di quebecchese – appunto mio al traduttore: ma Dio! Lasciamolo in originale, quebecchese è un pugno negli occhi – ammessa nel cerchio sacro del Grande Spirito Manitù. Il tempo aveva uno spirito dilatato. Avrei voluto trovare le parole giuste per descrivere la mia pelle d’oca di ragazzina seduta alla finestra davanti a quella danza di benvenuto nella tua nuova dimora, grande donna boreale. Ma non c’erano parole abbastanza flessuose e variopinte.» E dunque il tempo e le parole. Il diventare partecipi di un tempo diverso, che non si conta(bilizza), che non cerca bilanci costanti e progressivi, che ti consenta di setacciare le parole migliori, le più esatte, in grado di operare in profondità, più che in lunghezza o in accumulo. Insomma di trovare il passe-partout per raggiungere quella stanza-Eden che ogni scrittore degno di questo titolo ambisce a scovare e meritarsi. Ma sarà davvero necessario coprire tutta questa distanza e fissare negli occhi gli alberi? Sostituire il vicinato di un sobborgo di città con le tane delle volpi? Lo strombazzare delle automobili con l’ululato dei lupi? Non basterebbe una piccola stanza tutta per sé di woolfiana memoria? Il bosco avanza con la bocca del lupo.