Les plages d’Agnès, la place d’Agnès
Les plages d’Agnès
«Lo sai che i miei nipoti mi chiamano “Mamita Punk”? È come il nome di una stripper. Lo adoro. Sono felice di essere ancora capace di comportamenti punk» (Kline 2014, p. 194): la dichiarazione risale al 2009 ed è tratta da un’intervista rilasciata da Agnès Varda a proposito di Les plage d’Agnès, uscito un anno prima, film che è anche, per l’appunto, l’opera di una “nonna” punk (non solo per via di quel caschetto a due colori), il progetto di una persona che, compiuti gli ottant’anni («quand’ero giovane non avrei mai immaginato di poter diventare un’ottantenne!»), desidera “fare il punto”. Anche se poi, per Varda, fare il punto significa comunque rivolgere lo sguardo verso gli altri: perché «sono gli altri che amo filmare. Gli altri ad incuriosirmi, a motivarmi, a sfidarmi, a sconvolgermi, ad appassionarmi».
L’operazione memoriale e di ripasso di Les plages d’Agnès è in realtà cominciata già da qualche anno e anzi, per certi versi, il film del 2008 rappresenta il punto d’arrivo (e di rilancio) di un’attitudine alla riflessione autobiografica e al ritorno, attraverso l’immagine, sulle immagini già fotografate, riprese, montate, narrate, collezionate, archiviate, che attraversa buona parte della carriera di Varda e che però prende quota, e si precisa, soprattutto nel nuovo millennio. Sospinta dall’anagrafe, certo, ma anche dal fondamentale passaggio al digitale, questa attitudine si ritrova, per esempio, nei rispecchiamenti e negli ingrandimenti di Les glaneurs et la glaneuse (2000) – il film spartiacque della carriera di Varda, prolungato in Les glaneurs et la glaneuse… deux ans après (2002) –, nel diarismo di Hommage à Zgougou (2003), nel divertissement/remake Le Lion volatil (2003), nei commenti/aggiornamenti Cléo de 5 à 7, souvenirs et anecdotes (2005) e Rue Daguerre en 2005 (2005), nella conclusione di racconti iniziati decenni prima come La petite histoire de Gwen la bretonne (2008).
Stupore dell’essere vissuti tanto a lungo e autobiografia a parte, Les plages d’Agnès è in effetti anche, se non soprattutto, questo: un esercizio di lettura delle immagini da parte di una persona che alle immagini ha consegnato la propria vita perché crede nel loro potere di raccogliere, dare e conservare la vita. Compiuti gli ottant’anni, per “fare il punto” Varda non può insomma non mettersi a giocare con le immagini, ben al di là di qualsiasi disciplinato progetto autoritrattistico; l’autobiografia, semmai, è ciò che dicono le carte. Come rivela un progetto affascinante come Une minute pour une image (1983), Varda è anche, se non soprattutto e da sempre (Jean Vilar la sceglie nel 1947 per tradurre il teatro in fotografa), una grande osservatrice e interprete di immagini, una medium, esattamente come le chiromanti che montano e smontano sequenze di tarocchi all’inizio di Cléo e di Le Lion volatil. E, di conseguenza, la forma non può che essere il collage, e cioè, in tutti i casi, una sorpresa, sia che si tratti di «un puzzle nel quale si deve individuare una figura reale o un paesaggio», sia che si tratti di «un collage che è semplicemente un collage e non rappresenta una figura riconoscibile» (Kline 2014, p. 195).
Se nel percorso di questa nonna punk Les plages d’Agnès “fa il punto” è dunque proprio perché non si limita a mettere ordine in una vita (e del resto, appassionata degli “altri”, Varda non fa che scappare da se stessa), ma perché racconta, senza fare teoria, di un’estetica: di una relazione artistica, di una forma di pensiero, di una risposta emotiva. Varda di fronte alle immagini: che ride, si commuove, si sorprende, si incuriosisce, in tutti i casi indicando qualcosa che va ben al di là del loro potere, di servizio, di trattenere il tempo o di ricordare il passato – «fare questo film è un modo di continuare a vivere, vivere e ricordare» (Kline 2014, p. 194); ma, anche, Varda dentro le immagini: Les plages d’Agnès ha due finali, ed entrambi ritraggono la regista inserita in un’immagine, mescolata a un’immagine: prima La Cabane de l’Echec, la capanna di fotogrammi realizzata con le bobine del suo più sonoro insuccesso, Les Créatures (1965) – «J’habite le cinéma. C’est ma maison»; poi, un quadro digitale tenuto dalla stessa Varda, che contiene, in movimento e in raddoppiamento, il suo ritratto e parte delle ottanta scope con le quali amici e conoscenti hanno festeggiato il suo ottantesimo compleanno – «La sensation s’est mélangée à l’image qui en restera».
Infine: se Les plages d’Agnès è il film che nel lungo, appassionato, divagante percorso di questa autrice fuori dalle mode, dalle tendenze e dai raggruppamenti (primo tra tutti la Nouvelle Vague) “fa il punto”, è anche perché – e si tratta forse dell’attributo principale – ha definitivamente spiegato come parlare del cinema di Varda. Non solo che cosa dire (e che cosa smettere di dire), ma proprio come dirlo: con quale tono, con quale forma, con quale passione. E se così si finisce per compromettere qualcosa in termini di rigore analitico, beh: per fortuna. Impossibile scrivere di Varda senza far risuonare nella parola la sua voce, che col suo incedere dolce e costante ha accompagnato e letteralmente musicato i suoi film prima in qualità di narratrice, poi, appunto, in qualità di interprete (chi)romantica. E che Les plages d’Agnès sia anche una serie di “istruzioni per l’uso” (il buon uso) dell’arte di Varda, lo suggerisce piuttosto esplicitamente il fatto che tra le domande alle quali la regista prova a rispondere – domande quasi sempre innescate dal confronto con l’immagine – vi sia anche la più difficile (e però, compiuti gli ottant’anni, non più rimandabile): «Che cos’è il cinema?». «Avrei potuto dire le stesse cose che sono nel film parlandoti per sei ore. Ma ho preferito trovare delle forme» (Kline 2014, p. 197): per esempio, l’happening/rituale in omaggio al pescatore che ha recitato in La Pointe courte e che i cinque figli non hanno mai conosciuto, oppure Varda che guida, e prova a parcheggiare, una macchina di cartone o, ancora, il volto di Demy che compare improvvisamente – un bagliore, un’allucinazione, un film – su una parete della casa di rue Daguerre nel momento in cui la regista solleva lo sguardo dai fogli sui quali sta scrivendo.
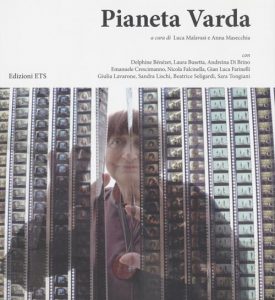
La place d’Agnès
Nel 2008 Les plages d’Agnès era dunque già apparso come un commiato-testamento lasciato in eredità al suo pubblico, al cinema e all’arte tutta da un’artista per immagini che aveva attraversato a grandi falcate il secolo breve, affacciandosi alla vita adulta dopo la fine della Seconda guerra mondiale e prendendo in mano con coraggio e con costante rilancio le redini della sua vita, in un’epoca di profondi cambiamenti culturali, sociali, economici, di valori. Il fatto che questa “giovane ottantenne” non si fosse assolutamente fermata ma avesse invece continuato a progettare e realizzare programmi televisivi (Agnès de ci de là Varda, 2011), esposizioni, videoinstallazioni e mostre (L’Île et Elle, 2006; Patate & Compagnie, 2016, per citarne solo due) e il sorprendente e utopico Visages Villages con JR (2017), aveva fugato ogni dubbio: Agnès Varda era una supereroina. Tutti credevamo ormai nella sua immortalità, ma non avevamo preso abbastanza sul serio, tra le sue doti soprannaturali, la divinazione, cosa evidente vista la frequenza con cui maghi e cartomanti appaiono nel suo cinema: avremmo dovuto sapere che Varda par Agnès, presentato al Festival di Berlino nel febbraio 2019, sarebbe stato davvero la sua ultima chiacchierata con noi, visto che, nella locandina del film, è seduta di spalle, rivolta verso il mare, e invita a guardare al futuro portando con noi tutto ciò che ci ha mostrato e di cui, grazie alla registrazione audiovisiva, saremo per sempre spettatori. In questo modo voleva forse anche dirci che, sì, un po’ immortale lo era davvero.
A proposito di tempo, di relazione tra passato, presente e futuro, Varda par Agnès era già stato il titolo di un oggetto prezioso, un libro pubblicato nel 1994 grazie alla complicità di Bertrand Bastide e dei “Cahiers du Cinéma”. Mentre il lutto per la perdita di Jacques Demy è ancora in elaborazione, Varda rimette insieme i pezzi del percorso fatto nei suoi primi cinquant’anni di carriera, con un libro a metà tra un’enciclopedia per voci, un album fotografico e il diario intimo di un’artista. Le immagini, accompagnate da un testo scritto, mettono in movimento la memoria e restituiscono le tappe di un viaggio artistico ma innanzitutto esistenziale, perché in Varda arte e vita sono tutt’uno, e procedono intersecandosi, mettendo in essere una precisa idea di cinema e di esperienza vissuta, che per lei significano quasi sempre la stessa cosa.
Del resto per lei, originariamente storica dell’arte e fotografa, il cinema è davvero la messa in movimento dell’immagine fissa: un istante che si dispiega nel tempo e nello spazio, percorso e costruito attraverso le immagini e soprattutto l’immaginazione, la rêverie che dal reale prende spunto per disegnare quello che potrebbe esserci e ancora non c’è, un racconto di finzione che assomiglia alla vita – Cléo dalle 5 alle 7 (Cléo de 5 à 7, 1961), L’une chante l’autre pas (1976), Kung-fu Master (1987) – oppure lo spazio utopico di una nuova comunità, legato a un fatto storico preciso, come in Salut les Cubains (1962-1963) e Black Panthers (1968), o a un orizzonte di lunga durata, anch’esso storicizzabile, come nel caso di Les glaneurs et la glaneuse e Visages Villages. In tutti i casi i luoghi (Parigi, le spiagge, i villaggi) diventano, tra immagini e processo immaginativo, spazi simbolici, sfondi attivi, come quelli di un videogioco in 3D, in cui essere se stessi ma anche inventarsi diversi, aprire scenari possibili ancorandoli al reale, per rendere viva l’esperienza, per fare esperienza condividendola. Ma in fondo non è stato anche questo lo schermo cinematografico quando è apparso nel 1895? La cinécriture di Varda allestisce schermi ovunque, utilizzando diverse superfici (tele, specchi, finestre, facciate di palazzi), supporti di varia natura (dalla pellicola al digitale) e dispositivi vari (la sala, il museo, la strada).
Ma i suoi sono schermi che diventano finestre perché, osservandoli, lo sguardo scappa verso il fuori, come quando si apre una finestra. I suoni, i colori, la vita oltre i margini del quadro catturano lo spettatore. Così, come viene ricordato in apertura della prima chiacchierata con il pubblico di Varda par Agnès, ritroviamo le tre parole fondamentali attorno a cui nasce e si sviluppa il suo percorso artistico: ispirazione, creazione e condivisione. Nel suo lavoro, una porzione di realtà (luoghi, persone, fatti storici), un sentimento (amore, paura, ribellione) catturano la sua attenzione, ispirano, e stimolano l’immaginazione, il processo creativo. Lo stile Varda mette infatti in movimento inquadrature che sono insieme cornici e finestre sul mondo, che partono da uno sguardo oggettivo per sollecitarne uno soggettivo. Così facendo, grazie al filtro sentimentale e soggettivo dell’io di chi filma, creano un dialogo con lo spettatore, innescando un meccanismo di condivisione. Del resto gli incontri sono un elemento centrale nella sua prassi poietica e poetica. In una conversazione con Nurith Aviv presente in Varda par Agnès si parla esplicitamente di durata in riferimento alle lunghe inquadrature attente a catturare le attività quotidiane dei commercianti in Daguerréotypes: il commento, in chiusura, è che «niente è banale se innanzitutto si prova empatia, amore per le persone che si filmano, se si trovano straordinarie, e io le trovo tali, come il panettiere». I travelling e più in generale le riprese in continuità nel film servono appunto ad amplificare una durata che diventa uno stare con gli altri, un essere nel tempo collettivamente.
Un tempo anche storico, raccontato con uno sguardo critico e con un intento memoriale: ritrarre i commercianti, i vicini, gli amici di rue Daguerre è anche un modo di archiviare, di “fermare” attraverso le immagini una realtà che sta scomparendo in una fase in cui Parigi sta cambiando di nuovo, sia urbanisticamente che culturalmente. Secondo Rebecca J. DeRoo, in questo film Varda non destruttura i codici del documentario per procedere ad un ritratto “sentimentale e apolitico” ma, al contrario, per esplorare la “controversa modernizzazione” messa in atto da Georges Pompidou tra gli anni sessanta e settanta.
La storia, l’evoluzione dei tempi e dei costumi sempre guardata con acuta curiosità e con profonda leggerezza. Varda amava definirsi una femminista gioiosa ed è con gioia militante che ha sempre raccontato le donne, personaggi o figure storiche, innanzitutto come esseri umani consapevoli, sempre calate nell’azione, mai passive. Se la sua voce è sempre stata presenza viva dentro le sue immagini, il corpo le ha progressivamente occupate sempre di più, imponendosi man mano che gli anni passavano, e proprio per questo. I segni del tempo e dell’età avanzata sui quali insiste, a settantadue anni, autoritraendosi in Les glaneurs et la glaneuse, sono il rilancio del discorso aperto negli anni settanta con Réponse de femmes. Notre corps, notre sex (1975) e già ripreso con Les dites cariatides (1984) e Jane B. par Agnès V. (1987). Se il suo cinema ha dato voce e spazio a tanti invisibili, alla/e donna/e, ha avuto poi l’ardire di darlo, precorrendo i tempi, non solo anche alla terza età ma al corpo anziano di una donna.
Pianeta Varda
Questo volume si ispira alle “istruzioni per l’uso” che Varda ha lasciato, a tutto ciò che lei stessa ha suggerito di fare e non fare con il suo cinema e le sue immagini. Nasce, quindi, dal desiderio di dare un’altra forma al discorso critico sull’opera della regista (e fotografa e artista visuale e nonna punk), a partire dalla struttura: una serie di parole, in tutto ventidue, le lettere del nostro alfabeto più una. Non vuole essere infatti un sistematico abécédaire Varda, operazione che, nel suo modo fantasioso e libero, aveva già fatto lei nel libro Varda par Agnès, ma una selezione di oggetti, campi del pensare e del fare nati, come le sue immagini, da impressioni passate al setaccio dalla ragione. Alcune parole sono insegne che da sempre lampeggiano sulla sua filmografa (Cinema, Donne, Fotografa, Nouvelle Vague, Voce, Volto, Colore), altre parolechiave e guida del suo lavoro (Arte, Archivio, Autoritratto, Incontri, Memoria, Petite caméra, Tempo), altre ancora pezzetti di poetica (America, Cinécriture, Demy, Parigi, Rêverie, Spiagge, Villaggi). Una serie di parole che vogliono dunque assecondare, esattamente come suggerisce il film del 2008, gli imprevisti e le sorprese del collage. Del resto, anche nell’autoritrarsi Varda si è fatta “a pezzi” per poi riassemblare la sua immagine, come accade nel 1949 con l’Autoportrait in forma di mosaico, in cui il volto è sminuzzato in decine di tessere, e, a distanza di cinquant’anni, nel 2009, con l’Autoportrait morcelé (riprodotto a p. 149), in cui il volto si rompe, riflettendosi in una serie di frammenti di specchi.
Opera di “smontaggio”, dunque, più che di schedatura, questo libro è nato nella speranza di somigliare a Varda e ai suoi film (le sarebbe piaciuto?), e si ispira esplicitamente al suo metodo di lavoro (che è poi, a monte, un metodo di vita), fatto di incontri, inciampi, rimandi più o meno sorprendenti, dialoghi a distanza, emergenze impreviste, incroci indisciplinati. Per questo non poteva che essere frutto di uno sforzo collettivo, di sguardi molteplici che nascono da orizzonti di esperienze diverse, sia da un punto di vista disciplinare e metodologico, sia da un punto di vista generazionale. Sandra Lischi, pioniera degli studi sulla videoarte in Italia e tra le prime a seguire il lavoro di Varda facendone conoscere l’importanza, ha ragionato su Arte e Schermi. Delphine Bénézet, autrice di una delle poche monografie interamente dedicate a lei, ha proposto le letture di Donne e Rêverie, mentre il curatore di uno dei due volumi su Varda finora pubblicati in Italia, Nicola Falcinella, non poteva che dedicarsi alla voce Cinema. Laura Busetta, Giulia Lavarone, Sara Tongiani e Beatrice Seligardi hanno saputo declinare i loro studi, rispettivamente, sulle narrazioni audiovisive dell’io (Autoritratto, Tempo), sulla configurazione dello spazio nel cinema della modernità (Nouvelle Vague, Parigi, Spiagge, Villaggi), sulla cultura visuale (Colore) e sull’eredità della teoria delle immagini warburgiana (Memoria) dentro la cinécriture di Varda. Attraverso gli strumenti della riflessione estetica e filosofica, Andreina Di Brino ed Emanuele Crescimanno hanno percorso le profonda superficie dei Volti e la casuale profondità degli incontri nel lavoro vardiano. I due curatori, studiosi di lungo corso e spettatori appassionati del cinema di Varda, si sono assunti il compito di sviluppare ulteriormente i loro ragionamenti su alcuni aspetti del suo cinema, con la speranza di arricchire il mosaico, armonizzando le tessere e aggiungendo i percorsi trasversali di America, Petite caméra, da un lato, e Archivio, Cinécriture, Demy, Fotografa e Voce, dall’altro.
Volutamente morcelé, questo libro può essere letto dall’inizio – la A di America – alla fne – la V di Volto –, ma può anche essere percorso liberamente da un punto all’altro o, ancora, attraversato facendosi guidare dalle parole stesse, che si parlano incessantemente e che, in molti casi, usano le stesse parole per dire cose diverse, oppure di queste stesse parole rivelano sfaccettature ulteriori. E assieme alle parole tornano e rimbalzano da un punto all’altro del volume i nomi che hanno segnato la vita, la formazione e la carriera di Varda: Bachelard, Birkin, Breton, Vilar, Dali, Godard, Resnais, JR, Picasso, i due Renoir, Valéry… e poi, sopra tutti, Demy. Nomi che disegnano la trama di un altro possibile libro che esplori ulteriormente la prospettiva, solo suggerita in questa introduzione ma di fondamentale importanza, di Agnès Varda pensatrice e filosofia delle immagini. Come recita il titolo della postfazione di Gian Luca Farinelli: Evviva Varda!
Riferimenti
D. Bénézet, The Cinema of Agnès Varda: Resistance and Eclecticism, Wallflower Press, London-New York 2014.
T.J. Kline (ed.), Agnès Varda. Interviews, University Press of Mississippi, Jackson 2014.
***
Introduzione al libro Pianeta Varda, a cura di Luca Malavasi e Anna Masecchia, edito da Edizioni ETS.
Si ringraziano gli autori e l’editore per la gentile concessione.
