C’è un aneddoto che dà l’aire a questa analisi: nella mia libreria, il libro mancante più curioso che mi sia capitato di leggere è senz’altro La più recondita memoria degli uomini (Edizioni E\O, traduzione di Alberto Bracci Testasecca) dell’africano Mohamed Mbougar Sarr, premio Goncourt 2021. Avevo letto il primo capitolo distrattamente su internet e ne sono rimasta impressionata fin da subito, rapita dall’esergo. In quel momento ho capito che avrei dovuto leggerlo ma non avendo soldi per comprarlo sono rimasta ossessionata per mesi dall’idea di doverlo leggere. Era un periodo in cui non potevo nemmeno recarmi in biblioteca, per cui non avevo soluzioni, se non aspettare, con la pacata e fiduciosa convinzione con cui si aspetta un piacere ineluttabile. Non ho mai dubitato per un momento che la mia pazienza, o corteggiamento, o speranze, sarebbero stati ripagati. Quando finalmente sono riuscita a procurarmi una copia sono rimasta sorpresa nello scoprire che ero stata ossessionata da un’ossessione. Questo è il libro di Sarr, una divorante e coinvolgente ossessione, l’epopea di uno scrittore africano francofono Diégane Latyr Faye, che segue in diversi continenti il miraggio di uno scrittore eremita, Elimane, autore di un libro-plagio eccezionale Il labirinto del disumano, con il desiderio di ritrovarlo. A pochi passi, attraverso indagini, testimonianze, racconti di chi lo ha conosciuto, scoprirà tutto di lui, la sua storia, le origini, l’infanzia, la giovinezza, e anche la sua fine, senza riuscire ad incontrarlo mai. Lo scrittore è morto pochi anni prima che lui potesse raggiungerlo, ma questo non gli impedirà di comunicare con lui.
Tre passaggi che nutrono le ossessioni ricorrenti del libro:
il protagonista rifiuta del sesso facile che gli si propone in nome di un “giuramento della notte” fatto a una donna, Aida, tempo prima. Capita che a un certo livello di alchimia l’amore fisico diventi un giuramento tragico, una solenne promessa a un’ideale, un qualcosa che anche quando l’amore finisce ci obbliga a restare fedeli alla nostra parola e al nostro cuore, anche quando siamo stati i soli a fare quel giuramento. L’idea fissa di quel corpo è troppo vivida in noi e occorre essere fedeli a se stessi. C’è una famosa favola cinese in cui un uomo per mantenere una promessa e arrivare in tempo a un incontro fissato un anno prima, decide di uccidersi perché “l’anima viaggia più veloce di un uomo”. Esistono uomini, e sono rari, disposti a morire per non tradire la parola data. E chi non crede nell’animismo e non arriva a tanto, riesce comunque a non tradire un ricordo pur di onorare un amore, riesce a promettere la fedeltà della sua anima a un’altra persona. Diégane è sicuro che mai nessuno attenuerà la verità luminosa della sua prima notte con Aida, tanto meno ci riuscirà il velo del tempo.
Il secondo passaggio è il ricordo di Ousseynou Koumakh della sua Mossane, la donna che ha amato tragicamente per tutta la vita, madre di Elimane. Mossane, diventata pazza per la perdita del figlio, che una volta partito per la Francia non le ha mai più scritto, o così almeno crede lei, siede tutti i giorni sotto un albero del cimitero. Un giorno sparisce nel nulla senza lasciare tracce. Ousseynou le sopravvive di tantissimi anni, morirà infatti centenario. Passato del tempo prenderà in sposa altre tre donne, donne a cui ha voluto bene, come ricorda, ma continuando tutte le notti a sognare solo Mossane, che ha segnato tutta la sua vita. Ousseynou è un altro uomo saggio e colmo d’orgoglio che è rimasto ferito dall’amore, eppure ha sempre vissuto con dignità, senza però mai riuscire a dimenticare. Ha cresciuto il figlio di Mossane e di suo fratello gemello, sua profonda nemesi, come fosse suo figlio, lasciando in lui l’impronta dell’Africa magica e rituale. Iddio e il sovrannaturale sono celati e senza forma nell’universo. È bene che siano celati e senza nome nell’anima. Quando Ousseynou, nel suo ipnotico racconto, rivela che nonostante i tradimenti di Mossane e del tempo il suo amore per lei non ha mai vacillato, ossessionandolo per tutte le sue notti, non si può far altro che compiangerlo e capirlo.
Il terzo passaggio è tratto da una lunga lettera che Diégane riceve dal suo amico Musimbwa, scrittore anche lui e vittima di guerra, in cui gli rivela il massacro dei genitori che ha dovuto “ascoltare” da piccolo rinchiuso in un pozzo, il pozzo che “è ancora qui” proprio come anche lui è qui e che lo ha tormentato per tutta la sua vita, nelle sue orecchie, dove sente ancora e sempre le loro grida. Anche Musimbwa è rimasto profondamente colpito dalle pagine del Labirinto del disumano, ma ne ha tratto una lezione diversa, che è poi la lezione che il libro ha lasciato anche a me oltre alla curiosa catena di ossessioni che mi si sono presentate e che parevano nascondere qualcosa di più di una coincidenza, qualcosa che assomigliava a un segno e che pertanto mi faceva divorare le pagine alla ricerca di un’agnizione qualsiasi pronta a divorarmi anch’essa. Questa lezione è che il luogo del male più profondo conserva sempre un frammento di verità. Che bisogna sedersi in cerchio coi propri fantasmi, intorno a un fuoco, e appena la vita spezza il cerchio bisogna essere pronti a tracciarlo di nuovo. Che non c’è consolazione – Musimbwa non consola né si consola. Che la verità va desiderata anche quando la verità è morte – forse soprattutto allora. Non curare né consolare, ma mostrare la nostra ferita stando eretti. Mostrarla solamente, in silenzio. Io ci sono e con la mia vita, in silenzio, mostro il mio dolore.
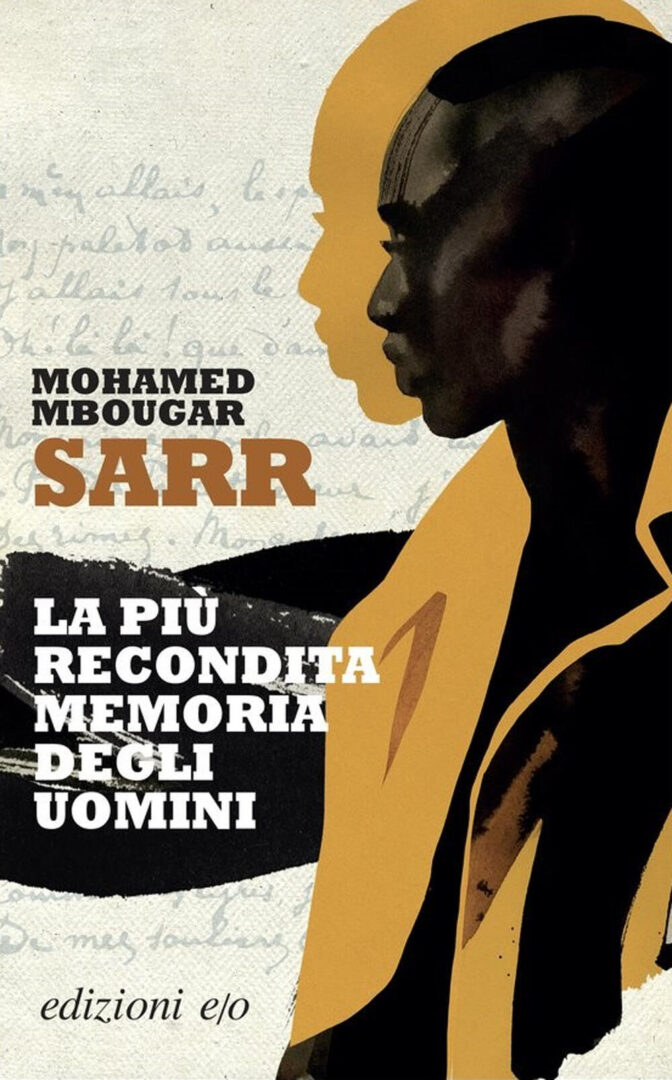
Il libro è un ottimo meccanismo di stampo bolaniano, un giallo letterario. Sarr scongiura il suo terrore di non scriverlo mai, questo libro epico, questa summa di vita e letteratura, ma può comunque, evocandolo, porsi tutte le domande giuste. Ganglio del libro è: “perché scrivere?”.
È effettivamente molto più difficile rispondere a questa domanda anziché al “perché leggere?”. Una cosa sembra un arricchimento, un’altra una deprivazione, un atto di fede, un gesto arrogante. È chiaro che a Diégane interessa il destino di Elimane, e di riflesso il suo, molto più che del destino di tutti. Quando si rende conto che la sua ricerca umana viene prima delle lotte politiche che animano le sue terre si sente profondamente in colpa e in imbarazzo, tanto che non riesce a dichiarare a nessuno le sue vere intenzioni. È una ricerca solitaria, che quindi ognuno deve compiere in solitudine; ciò che emerge è che l’uomo, e in particolar modo lo scrittore, è una creatura immensamente sola. Rispondere al “perché scrivere? Scrivere o non scrivere?” è difficile quanto rispondere al vivere o non vivere, credere o non credere, amare o non amare. Ogni quesito è intriso di anedonia, di sopito stupore, di senso di vanità del tutto. È sempre un gesto di fede e motivazione. Conta eccome il nostro umore, il nostro lasciarsi sopraffare dalla noia, le nostre distrazioni. Il corpo deve essere pronto, perché scrivere è anche un vigoroso esercizio fisico. Chiara l’idea che ogni uomo sia chiamato a dare il meglio di sé, a compiere la sua migliore opera. Alcuni la scrivono, altri la suonano, altri la creano e si creano nei rapporti con gli altri o la natura. Certi altri, molti, sono vite mancate. Mancare alla propria vita è anch’esso un diritto, seppur forse non protetto dalla grazia. Ma ai più non interessa niente della grazia.
Non è un caso che la vera narrazione sia tramandata a voce, fatta di ricordi e leggende che diversi personaggi riportano a Diégane. Nella cultura africana inoltre, in accordo con la tradizione orale precoloniale, lo scrittore si pone idealmente come guida e maestro della sua gente. Nel contesto del declino del colonialismo, questa funzione ha assunto naturalmente, quasi ovunque, connotazioni politiche. Davanti a queste responsabilità, alle implicazioni di essere uno scrittore africano che vive in un paese europeo e deve scegliere di cosa scrivere e in che lingua farlo, Diégane è chiaramente limitato e disinteressato, perché sono altri i moti dell’anima ad interessarlo. Tutte le incitazioni dei suoi amici impegnati affinché partecipi e combatta anche lui per la loro causa creano in lui una sorta di ribellione in senso opposto. Sarr è convinto che soltanto sapendo scrivere si può far uso in letteratura di sé stessi; di quell’identità che, mentre è essenziale alla letteratura ne è anche l’antagonista più pericoloso. Lo scrittore è una monade pericolosamente chiusa in se stessa. Non essere mai sé stessi eppure esserlo sempre – ecco il problema. Non importa essere incantevoli, virtuosi, colti e brillanti per soprammercato, se non assolvete alla prima condizione: saper scrivere, e questa è un’ossessione che scavalca tutte le altre. L’agognato stile e la sua ricerca creano un solipsismo diasporico, un apoliticità acritica, una lotta vana contro il mondo, esaurisce tutte le forze dello scrittore, che si impegna solamente a creare bellezza. Sarr intuisce che c’è una stretta relazione tra lo scrivere e il combattere, che in un’epoca come la sua, quando il combattente non scrive e lo scrittore non combatte, tale frattura è una disgrazia. Per questo la domanda è “scrivere o non scrivere?”, perché occorre calarsi nelle prime domande, quelle da cui nascono tutte le altre.
Inoltre, dire la verità sulle esperienze con il proprio corpo, credo sia una sfida ancora importante per la razza nera. Ci sono pochi scrittori neri a esserci riusciti, oggi. Gli ostacoli con cui si scontrano sono ancora indicibilmente potenti, tuttavia così difficili da definire. Hanno ancora molti fantasmi da combattere, molti pregiudizi da superare. In verità dovrà passare ancora molto tempo prima che lo scrittore nero possa sedere al suo tavolo a scrivere un libro senza scoprire un fantasma da uccidere, una pietra da scagliare con rabbia. Elimane è un uomo diviso tra l’Africa e l’Europa, e rappresenta il destino di moltissimi scrittori africani, incluso quello di Diégane. Sembra che per certi versi non sia concesso a delle categorie – come alle donne o ai neri – di riflettere su se stesse anziché interessarsi della lotta comune. Più che il desiderio di essere bianchi, o come i bianchi – desiderio che noi proiettiamo su di loro -, c’è un desiderio di non esserci, di non essere al mondo. Gli scrittori sono spesso infelici e turbati. Non sono mai stati esaminati con tanta cura come accade oggi. Spesso in passato la loro vita veniva ritenuta irrilevante. Oggi invece ci sono molte persone che si dedicano in via esclusiva a studiarli sottoponendoli a un’indagine serrata – che è poi il giallo di Elimane che si dipana nel libro colpo di scena dopo colpo di scena. Si cercano oramai risposte ovunque, persino nei luoghi più impensati e sbagliati. Tutti cercano di ficcare il naso in qualunque cosa sia connessa alla felicità, e si spera che gli scrittori abbiano trucchi da rivelarci. Perchè scrivere? Non ce ne sono già abbastanza di libri, nel mondo? Lo diceva già Re Salomone che bastavano e avanzavano.
Bisogna chiedersi se sia possibile essere veramente apolitici, in questa vita. La volontà di combattere un pregiudizio è segno certo che se ne è impregnati. Quella volontà procede necessariamente da una ossessione. In questi casi non ce ne si può sbarazzare, solo la luce dell’attenzione è efficace, ed è incompatibile con una intenzione polemica. Diégane sente di avere una storia adeguata in grado di dar voce all’intuizione che la sua vita ha un particolare significato. L’artista, come ha scritto Nietzsche, tenta di accrescere a dismisura il valore della personalità umana. La sensazione che la sua vita abbia un significato continua a ossessionarlo, ma non è in grado di dimostrarne l’autenticità. Il punto allora è probabilmente proprio questo: forse non sappiamo più cosa sia un uomo, né per cosa sia giusto o sensato vivere, ma dobbiamo continuare a domandarcelo, e dobbiamo fare di questa domanda insistita, ripetuta, che a tratti sconfina nella mania, la ragione ultima della scrittura. Gli scrittori nel libro di Sarr trovano ognuno di loro una propria risposta. Forse la risposta che trova Diégane è la più criptica. È lui a rimanere il più deluso. È lui che deve ancora trovare la sua strada. Il suo è un tentativo di accettare e far proprio fino alle estreme conseguenze il processo di smitizzazione dell’io operato dalla modernità, cercando di far dialogare, in perenne e faticosa comunicazione con la complessità del mondo, le sue radici africane e la trasmigrazione francese. In questo Elimane incarna il “Rimbaud negro”, perché come lui veggente. «Il sacerdote lascia la scena e al suo posto subentra il divino letterato» diceva Whitman, convinto che le funzioni di poeta e sacerdote dovessero compenetrarsi. Per Elimane il cieco più infelice è colui che è costretto a ricordare il mondo per come era quando ancora poteva vedere, senza capire e cogliere la bellezza del mondo che cambia. Più infelice è l’uomo senza immaginazione. L’eros, di cui è ricchissimo e addensato tutto il libro, riesce sempre a sopravvivere alla psicoanalisi, e in qualche modo l’immaginazione sopravvive alle critiche. In entrambi i casi, una pulsione imperiosa finisce per abolire ogni interrogativo.
Dice Agamben:
«La filosofia nasce nel momento in cui alcuni uomini si rendono conto di non potersi più sentire parte di un popolo, che un popolo come quello a cui i poeti credevano di potersi rivolgere non esiste o è diventato qualcosa di estraneo o di ostile. La filosofia è innanzitutto questo esilio di un uomo fra gli uomini, questo essere straniero nella città in cui il filosofo si trova a vivere e nella quale, tuttavia, continua a dimorare, ostinatamente apostrofando un popolo assente.»
Elimane rappresenta il tentativo di uscire dalla dialettica del tragico e dalla sua falsa conciliazione degli estremi. Alla mistica sacrificale, all’unione nella morte tragica dei poli scissi dell’arte e della natura, si contrappone una diversa possibilità, di togliere il conflitto in modo finito ed eccentrico.
Un’ultima questione da trattare: la presenza di un libro sacro, leggendario, capolavoro di una vita. Ci sono numerosi libri leggendari nella storia degli uomini, dal libro di Toth degli Egizi fino a numerosi altri libri maledetti come Le stanze di Dzyan, il segreto dell’abate Tritemio, Excalibur – il libro di Hubbard su cui si sostiene la scientologia di cui si dice che chiunque l’abbia letto sia impazzito. Tutti ci dicono che lo spirito che alberga in un libro sia qualcosa che si trova a metà tra la nostra coscienza e il mistero della potenzialità. La lotta che si può scatenare tra noi e alcuni libri è letteralmente epica e personale. Chi in un libro non trova nulla per cui combattere ha un animo necessariamente misero. Se è anche vero che la realtà alla fine vince sempre sull’idea è anche vero che ciò avviene dopo una lunghissima, logorante battaglia, che modifica per sempre anche il reale. Ciò che può contare, come diceva Eckhart, è che la nostra costitutiva insufficienza che di fatto resta ci pesa e ci tormenta, tuttavia al livello dell’ideale svanisca, purché la volontà, l’intenzione sia pura. Questo può scagionarci. Ogni libro è una riconferma di ciò che siamo, e contiene anche la scrittura del nostro destino. I libri possono tradirci o abbandonarci. E noi possiamo farlo con loro. Ma di tutti questi libri dalle storie magiche, travagliate, che dimostrano che anche gli oggetti per sopravvivere devono combattere e contare sulla loro forza – che in processo riflettente doniamo noi loro – rimane anche una terra di nessuno sorprendentemente vasta. In essa oltre ai libri maledetti tanto pericolosi per il loro contenuto da venire messi al bando, dimora tutta una serie di opere: libri non finiti, libri perduti, libri apocrifi e pseudoepigrafi, ed inoltre testi dimenticati, non riconosciuti, libri celati in altri libri. Tutti fanno parte, nel loro minuscolo contributo, del Libro Totale racchiuso nella mitica Biblioteca di Babele di Borges, il massimo degli pseudobiblia, il culmine dell’evoluzione di tutto ciò che è stato scritto, esiste, ed esisterà. Borges li raccoglie in infiniti volumi rilegati, ma può benissimo essere un’unica pagina che supera il concetto di tempo e spazio. Chi sappia frugare tra le infinite sale della biblioteca di Babele – o chiudere gli occhi per un istante e immergersi nello scibile – troverà il libro che lo proteggeva da bambino nel suo mondo impenetrabile agli adulti, ma anche il terribile Necronomicon, un testo di magia nera redatto dall'”arabo pazzo” Abdul Alhazred, la decifrazione del manoscritto Voynich, il testo delle tavole di Nascal. La biblioteca di Babele è la rappresentazione simbolica dell’universo fantastico. È la sapienza totale immersa nel caos totale, l’essere e la negazione dell’essere, dove qualsiasi libro ha anche la dimostrazione del suo contrario, una cosmica coincidenza oppositorum. I libri non ci aiutano; se letti nel modo giusto e con onestà, essi ci ostacolano, ed è allora – quando li finiamo, abbandoniamo, rileggiamo, dimentichiamo – che sappiamo qualcosa in più su chi siamo: forse l’unica conoscenza che serva a qualcosa. E ci sono anche libri che hanno la funzione di guide, per le anime dei vivi e dei defunti, nelle nostre fasi di passaggio. Alcuni libri servono per orientarci, come se seguissimo la stella del mattino al nostro Oriente: una scintilla di infanzia e candore che torna a brillare alla fine di tutte le cose. Per Diégane è questo il valore del Labirinto del disumano. Di ogni vita, persino della più trasfigurata, persino di quella dell’uomo più esemplare è questo che resta: ricordi, lettere, testimonianze, memorie recondite, e, infine, silenzio.
Immagine di copertina: Getty images
