«Fingebant simul credebantque»
«Credevano in ciò che
avevano appena immaginato»
Tacito, Annales
In un’intervista pubblicata sul Messaggero del 20 gennaio 1990, in occasione del suo settantesimo compleanno, Federico Fellini, alla domanda del giornalista se credesse in Dio e come se lo immaginasse, aveva risposto che fino all’età di cinque anni era convinto che si trattasse del suo proprietario di casa, il Conte Gualtiero Ripa. Barbetta bianca, smilzo, vestito di celeste, il panciotto e una catenina d’oro che «mandava lampi». Ti passava accanto senza degnarti di uno sguardo al punto che sua madre, romana, incrociandolo in cortile aveva detto a mezza voce: «E chi sarà mai, il Padreterno?». Continuando in questa strana genealogia dell’idea di Dio, Fellini confessa che in seguito l’immagine di Dio sarebbe stata quella di un atomo di plutonio o uranio che irradiava milioni di raggi di luce intorno a sé, proprio come l’aveva vista rappresentata in una rivista di fumetti di fantascienza, Métal Hurlant. Il filo che unisce epoche e poetiche apparentemente molto distanti, di Fellini e del fumettaro Mœbius, per esempio, mi sembra corrispondere in pieno a quel che rappresenta il tratto distintivo dell’ εἴδωλα romanesque. Quella dei simulacri in realtà è una tradizione filosofica che lega l’antichità di Democrito, Platone, Lucrezio e che passando per Dante, Hobbes, Spinoza, Berkeley, Kant; è giunta fino a noi trovando proprio nella forma romanzo il luogo in cui porre un interrogativo fondamentale: esiste una verità ultima, universale, in grado di restituire un senso alla vita, alla morte, di rivelarci la natura profonda del mondo, di questo mondo?
«Il simulacro non è mai ciò che nasconde la verità ma è la verità che nasconde il fatto che non c’è alcuna verità. Il simulacro è vero» ha scritto il filosofo Baudrillard e credo che proprio tale paradigma giochi un ruolo fondante in Philip K. Dick e particolarmente in un romanzo del 1964, La penultima verità (Fanucci editore).
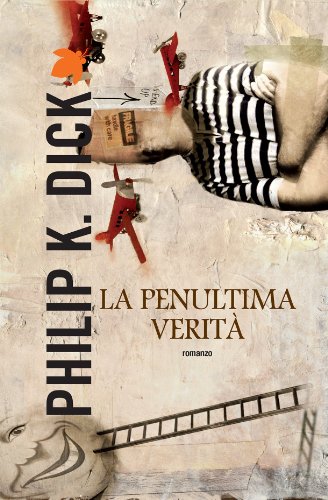
Qui si realizza l’utopia annunciata in un racconto pubblicato da Dick nel 1953, I difensori della Terra, da cui la fabula della Penultima verità attinge i temi maggiori, il senso stesso dell’Utopia: «È il fine della storia quello di unificare il mondo. Dalla famiglia alla tribù, alla città-stato, alla nazione e all’emisfero, la direzione è sempre stata verso l’unificazione. Ora gli emisferi saranno uniti e…» solo allora esploderà la pace.
Per realizzare questo sogno bisognerà ovviamente addormentare intere folle, popoli, veri artefici della guerra, costringendoli a credere a una penultima verità assolutamente inventata dal potere: la terra devastata dalla radioattività ha reso impossibile la vita in superficie dove l’aria è irrespirabile e mortale. L’unico modo di sopravvivere è abitare nei rifugi del sottosuolo, formicai organizzati in modo da garantire la vita. Sopra alle loro teste truppe di soldati robot dei due campi, Dem-Occ e Bloc-pop, veglieranno sulle rovine di una civiltà ormai distrutta. Ma non è questo il solo compito, la loro missione sarà infatti anche quella di catturare eventuali umani evasi dal sottosuolo per impedire loro di scoprire la grande impostura costruita a mezzo di bombardamenti mediatici da parte dei nuovi signori del mondo. La guerra è terminata da un pezzo, la vita in superficie per quanto convalescente è ormai sulla strada della guarigione. Una élite politica e militare americana e sovietica, divenuti alleati, gode di tutti quei beni che non dovranno condividere con il resto dell’umanità, ma solo in minima parte con una minoranza di ex abitanti dei formicai, evasi ma lasciati in vita seppure confinati in complessi residenziali, quartieri di case popolari, sotto sorveglianza speciale perché non comunichino con quelli rimasti nel sottosuolo. Potranno uscire per le strade? Magari con un permesso speciale simile a quelli che abbiamo compilato in piena pandemia? E siamo sicuri che la loro vita sia migliore di quella di chi è rimasto all’oscuro di tutto?
«Perché – e noi lo sappiamo, è davanti ai nostri occhi – tutti quelli che vivono negli appartamenti condominiali di Runcible sono dei prigionieri e gli appartamenti sono come delle riserve… anzi, detto in modo più moderno, dei campi di concentramento. Preferibili ai formicai del sottosuolo, ma pur sempre campi dai quali non possono allontanarsi neppure per breve tempo… a termini di legge.»
Il lettore scoprirà da sé la storia che si tesse intorno ai due protagonisti, Nicola Saint-James, a capo di uno degli immensi rifugi e Joseph Adams, autore dei dispacci del governo destinati ai sepolti vivi. Di loro possiamo dire soltanto che non si tratta affatto di eroi in senso classico, e del resto in tutta l’opera di Dick per lo più sono persone ordinarie a far esplodere la verità in una polveriera, il mondo, costruita sulla menzogna. Non si tratta di eroi ma di persone che si comportano in modo eroico nell’esatto momento in cui non cedendo alle trappole del potere assecondano la propria natura umana. Un esempio su tutti, Blade Runner, che nella versione cinematografica vide il ruolo del protagonista Rick Deckard, affidato al più ordinario degli attori hollywoodiani, Harrison Ford, secondo soltanto a Gregory Peck l’attore che Philip K. Dick avrebbe voluto come interprete. Common people dunque che si batte in un mondo ormai dominato dalle macchine per quanto pensanti esse possano essere.

In un testo profetico scritto in occasione di una conferenza del 1977, Se vi pare che questo mondo sia brutto (provatene un altro), Philip K. Dick ci ricorda cosa vuol dire pensare:
«Che cosa voglio intendere dicendo che un’idea o un pensiero sono letteralmente vivi? Che si aggrappa agli uomini qua e là e li usa per attualizzarsi nel corso della storia umana? Che, forse, i filosofi presocratici avevano ragione; il cosmo è una vasta entità che pensa. Non fa nient’altro che pensare. In questo caso, o quello che chiamiamo universo è semplicemente una forma di travestimento che assume, o in qualche modo è l’universo – ci sono diverse variazioni di questa visione panteista, la mia preferita è che imita abilmente il mondo che sperimentiamo quotidianamente, e noi ne veniamo ingannati.»
Ma cosa succederebbe se un altro ordine, questa volta dettato dalle macchine, s’imponesse all’universo. Ho da pochi anni scoperto, per esempio, che la parola francese ordinateur per dire computer fu introdotta in Francia nel 1955 da IBM quando Jacques Perret, rispondendo all’appello rivoltogli da un suo ex-allievo in Lettere, François Girard, responsabile della comunicazione per il colosso americano, aveva proposto per la nuova macchina un nome affiliato a un altro di natura ecclesiastica e che significava sostanzialmente Dio, colui che mette ordine nel caos.
Allora come qualificare il disordine con altre parole che la vita e la morte? Con sentimenti diversi dalla paura? Come vincere la paura?
Il filosofo Gilles Deleuze, lettore di Dick – che considerava tra l’altro un libro di filosofia simile a un’opera di fantascienza – in Mille Plateaux, insieme a Félix Guattari, a proposito della paura aveva descritto, in un magnifico capitolo-saggio sul ritornello, in che modo «un bambino nel buio, colto dalla paura, si rassicura canticchiando. Cammina, si ferma al ritmo della sua canzone. Sperduto, si mette al sicuro come può o si orienta alla meno peggio con la sua canzoncina che è come uno schizzo, nel caos, di un centro stabile e calmo, stabilizzante e calmante. Può accadere che il bambino si metta a saltare, mentre canta, che acceleri o rallenti la sua andatura; ma la canzone stessa è già un salto: salta dal caos a un principio di ordine nel caos, e rischia di smembrarsi a ogni istante. C’è sempre una sonorità nel filo d’Arianna. O nel canto di Orfeo.»
Come non ravvedere in tale immagine universale – chi non è stato bambino? Chi non ha ma avuto paura del buio? – lo stesso movimento di fuga dal labirinto dei personaggi di Dick, che proprio per vincere la paura del buio ripetono incessantemente un ritornello in grado di guidare i loro passi nel Caos. Li seguiamo nella disperata ricerca del motivo, del tema, delle parole dimenticate e che tentano di riportare alla mente attraverso una lallazione infantile ma rassicurante come una marcia militare. La letteratura del resto si nutre di queste ossessioni, come quando Gregor Samsa si ripete all’inizio della sua metamorfosi che deve assolutamente non arrivare in ritardo in ufficio, o il ritornello di Bartleby lo scrivano, «I would prefer not to», e «il così va la vita», il mantra che Billy Pilgrim, protagonista di Mattatoio n°5 ripete a conclusione di fatti che altrimenti resterebbero inspiegabili. I personaggi romanzeschi, che si tratti di Joseph K o David Copperfield, Don Quichotte o Ferdydurke, non si servono di astrazioni per salvare la pelle ma affidano a cose concrete, reali, vere, la possibilità di nascondere dietro di sé qualcosa di ben più terribile e impossibile da sostenere.
C’è un passaggio in La penultima verità che riassume bene lo spirito di tale ricerca senza fine, refrain che è un urlo provocato da una ferita profonda, un solco che separa l’uomo dal mondo e dalla sua realtà, quando le parole sono ormai diventate simulacri. Come quando Joseph Adams che sta per finire la redazione del discorso che il Presidente consegnerà agli abitanti dei formicai, s’imbatte su una parola che gli evoca un’esperienza recente:
«”Colleen”, la interruppe lui “un giorno ho guardato fuori dalla finestra e ho visto uno scoiattolo.”
Lei lo fissò e disse: “No.”
“La coda. La coda è inconfondibile. È tonda e gonfia e grigia come uno spazzolino per bottiglie. E saltano così.” Fece un gesto con la mano, per farle capire, e per tentare di ricordarlo anche a sé stesso. Mi sono messo a strillare, ho fatto uscire quattro dei miei plumbei con…” Si strinse nelle spalle. “Insomma, alla fine sono tornati e mi hanno detto: ‘Là fuori non c’è nessuna creatura come quella, dominus’, o qualche altra stramaledetta affermazione.”»
Sua moglie gli consiglia allora di descrivere a modo suo quel che gli era apparso come un’allucinazione, un ricordo affiorato dal passato. «Scrivi con parole tue quello che hai provato. A mano e su un foglio… non dettandolo a un computer. Che cosa avrebbe significato per te trovare uno scoiattolo in carne e ossa.» Un’idea che poco dopo il nostro protagonista riprenderà formulando in modo chiaro e preciso il da farsi.
« …erano giunte alla conclusione che la strategia migliore fosse qualcosa che i fenici avevano appreso cinquemila anni prima. Un concetto tutto riassunto nel Mikado, pensò Adams. Se affermare semplicemente che un uomo era stato giustiziato bastava a soddisfare tutti, perché non limitarsi a dirlo, invece di farlo davvero?»
Ogni esperienza della realtà, ci insegna Philip K. Dick, è ormai ridotta alla semplice evocazione della stessa attraverso la parola e la sua verità sarà indiscutibile perché per vincere la paura vale forse la pena credere alle storie che noi stessi ci siamo inventati, questa canzone, e il suo ritornello, la conosciamo bene. Eppure.
Uno dei momenti più commoventi della nostra lettura sarà quando Nicolas Saint James riesce a perforare la parete che lo separa dalla superficie. Ha deciso di evadere perché quello sarà l’unico modo di procurarsi l’organo da trapiantare a un amico in fin di vita. Sa che corre seri pericoli, di vita o di morte, ma nulla lo ha trattenuto dal tentare quest’ultima chance. Il lettore seguirà passo dopo passo la sua ascesa dall’inferno, l’evasione dal formicaio e le sue metamorfosi. Dick ci racconta come si sia aggrappato alle pareti come un insetto, abbia lottato contro l’ultima zolla di terra alla stregua di uno scarabeo che si faccia strada da sé e quando riesce a issarsi all’estremità del buco cosa succede?
«Qualcosa di vivo gli sgambettò sulla mano; era una forma di vita chitinosa che comunque ammirò, solo perché la ricordava e ne sapeva qualcosa.» Nessuna delle metamorfosi citate potrà allora valere l’ultima verità di quella semplice formica. «La formica stringeva fra le mandibole una briciola bianca e lui la seguì con lo sguardo; le formiche non erano una razza intelligente, ma almeno non si erano estinte. Ed erano rimaste lì; quindici anni prima non erano scappate, avevano affrontato il Dies Irae, il giorno dell’ira, ed erano ancora lì. Come testimoniava quell’esemplare, quel rappresentante; lui vi aveva visto non una formica, ma tutte le formiche, per l’eternità, come se gli si fosse presentata sbucando da oltre i confini del tempo.»
In questa immagine risuonano allora i versi del canto XXVIII del Paradiso di Dante, il cui viaggio nel non-tempo aveva a lungo stregato l’immaginario di Philip K. Dick, e come non ravvedere in questa immagine lo scintillio della catenina d’oro del felliniano conte Gualtiero di Ripa, una breccia nel muro di menzogne che ci ostiniamo a chiamare storia.
«un punto vidi che raggiava lume acuto
sì, che ‘l viso ch’elli affoca
chiuder conviensi per lo forte acume;
e quale stella par quinci più poca,
parrebbe luna, locata con esso
come stella con stella si collòca.»
Questo articolo, precedentemente apparso su L’Atelier du roman, è stato tradotto dal francese all’italiano dall’autore stesso.
