
Ognuno è un’anima. Intervista a Ottessa Moshfegh
È possibile fare dell’isolamento un genere a parte? Un genere così potente che rimane se stesso anche quando ne intreccia altri, come il thriller psicologico o il noir? Ottessa Moshfegh sembra avere la ricetta perfetta: prende tutto ciò che conosciamo e lo infila in un essiccatoio, lo tiene lì per giorni, al caldo e al silenzio, e quando è tempo di riprenderlo non è rimasto altro che l’idea, l’essenza. Del genere riconosciamo alcuni elementi, altri sono evaporati. Ciò che resta è qualcosa che si trova in profondità, tra le pieghe dell’anima e la mente, depositato in una serie di personaggi che, come unico credo, pratica l’isolamento. È una ricetta che va bene per tutte le storie, siano romanzi storici, di formazione, storie brevi o crime: una volta passate dalle mani di Mosfhegh, diventeranno altro rispetto a ciò che siamo abituati a conoscere. E questa, a mio parere, è ciò che più di ogni altra cosa definisce lo stile di un autore.
Ottessa Moshfegh è una delle poche scrittrici viventi – una dei pochi scrittori viventi – per cui nutro una vera e propria venerazione. L’ho conosciuta attraverso i suoi racconti, riuniti poi in una raccolta pubblicata in Italia nel 2017 (Nostalgia di un altro mondo, Feltrinelli), che mi hanno invischiato in un luogo popolato da personaggi solitari, sporcizia, fast food, piccole consolazioni e oggetti totemici. La mia ammirazione per questa autrice si è cristallizzata una volta recuperati il suo esordio, la novella McGlue, il romanzo Eileen (Mondadori), vincitore del PEN/Hemingway Award e finalista al Booker Prizee, soprattutto, Il mio anno di riposo e oblio (Feltrinelli), storia di una ragazza newyorkese ricca, bionda e bellissima e del suo progetto di ibernazione come fuga da un mondo che detesta.
L’amore di Ottessa Moshfegh per la dimensione psicologica, i personaggi disillusi, il loro sguardo cinico su una realtà che osservano da lontano, dalle finestre di casa, nascosti, e le tendenze masochistiche, le dipendenze, tornano nel suo ultimo romanzo, La morte in mano, uscito per Feltrinelli nella traduzione di Gioia Guerzoni. La protagonista, questa volta, è una settantenne, Vesta Gul, che, rimasta da poco vedova, vende la casa dove ha vissuto insieme al marito per acquistare uno chalet sul lago, completamente isolato. Insieme al suo cane Charlie si trasferisce a Levant, in Maine – un’ambientazione che ricorda quelle di Stephen King – per ricominciare una vita fatta di silenzio, lettura, passeggiate, piccoli rituali e abitudini metodiche. Questa nuova monotonia viene però rotta dal ritrovamento di un biglietto, nel bosco che circonda lo chalet. Il biglietto riporta quattro frasi:
«Si chiamava Magda. Nessuno saprà mai chi è stato. Non l’ho uccisa io. Qui giace il suo cadavere.»
Eppure, del cadavere di Magda non c’è traccia. Vesta, allora, comincia a indagare: chi è Magda, perché è stata uccisa, e da chi? Un’indagine senza corpo del reato, senza indiziati: se bisogna partire da zero, non resta che inventare tutto. E così Vesta, in un campo da gioco mentale, come mentale era l’ambientazione di McGlue, crea il suo personale thriller: vittima, movente, colpevoli. E piano piano, mentre Magda, nei pensieri di Vesta, sembra tornare in vita, emergono dettagli del passato della donna, e il rapporto con il marito, oltre la morte, viene rimesso in discussione, approfondito, compreso.
La morte in mano è un’ode alla creazione e all’immaginazione, una fiction a scatole cinesi. La protagonista di un romanzo che si fa a sua volta autrice: dall’osservazione di Levant e dei suoi abitanti Vesta crea una narrazione, una storia per ognuno di loro. Di questo, e di altro, ho potuto parlare con Ottessa Moshfegh.

Vesta Gul, come altri protagonisti delle tue opere precedenti, è un personaggio solitario, che porta con sé traumi e perdite, che ha difficoltà a vivere nella realtà così come nei ricordi, e allora si rifugia nell’immaginazione, nell’alterazione, nella follia. Questo fa di lei un narratore inaffidabile. Che valore aggiunto ha un narratore di questo tipo, rispetto a un punto di vista più esterno e attendibile?
Un narratore inaffidabile è per definizione più libero di uno affidabile, a mio parere. Vesta non è costretta a dire la verità, e nemmeno ad agire in un mondo reale. Può andare dove le pare, e noi possiamo seguire i suoi pensieri ovunque. Può contraddirsi, sbagliare, avere ragione, oppure nessuna di queste cose, e creare per noi un’esperienza che, di fatto, esiste solo nella sua immaginazione e in quella dei lettori. Allo stesso modo, il lettore è libero di usare la propria mente come criterio per definire integrità mentale e stabilità.
I personaggi delle tue storie condividono molti tratti e peculiarità, ma sono anche profondamente diversi, come estrazione sociale, età, pensiero. Allo stesso modo in questo romanzo, i personaggi – anche quelli di contorno – offrono uno spaccato molto realistico e sfaccettato dell’umanità, presente soprattutto in alcuni luoghi isolati e periferici. Come si riesce a raccontare da vicino personalità e vite così divergenti (spesso dai tratti caratteriali spigolosi, respingenti, se non addirittura violenti ed egoisti) ricalcando il loro modo di pensare, di agire e di parlare, senza cadere nella trappola del giudizio morale?
Ad essere sincera, non mi preoccupo troppo del rischio di giudicare moralmente qualcuno. Sono una pensatrice abbastanza amorale. Sono affascinata dalle persone in generale, di qualsiasi tipo, e non faccio confronti: semplicemente, apprezzo le peculiarità di ognuno. Quando metto in campo un personaggio, per prima cosa cerco di calarmi nel punto di vista dal quale sto scrivendo. Nel caso di Vesta, quando scrivo dal suo punto di vista, osservo i personaggi secondari solamente attraverso i suoi occhi. Dal momento che il narratore è lei, non ha alcuna importanza cosa penso io: contano solo i pensieri e le considerazioni di Vesta. Se ho necessità di alterare il suo racconto ai fini della trama, della suspense o di qualsiasi altra cosa, posso tranquillamente aggiungere qualche elemento al personaggio: questo perché non sono persone reali, ovviamente. Sono create e costruite dalla mia mente per il romanzo che sto scrivendo. Per quanto riguarda lo spettro dei personaggi di cui mi occupo, credo semplicemente che ognuno sia un’anima. Le persone non sono davvero così diverse l’una dall’altra. L’unica maniera per comprendere davvero i personaggi è rapportarsi a loro nel modo più elementare, umano e spirituale possibile. Il trucco è cominciare da lì. I dettagli di una personalità non sono altro che abiti a rivestire lo spirito.

La morte in mano è un romanzo che a prima vista sembra un thriller. Del thriller, in realtà, mantiene solo gli stilemi e un certo tipo di costruzione, per spogliarlo di tutti gli elementi essenziali. Che rapporto hai con questo genere narrativo?
Come nel caso di Eileen, che era una sorta di noir del New England, ho rapporti con il thriller solo grazie ai film. Davvero, non ho nessun riferimento letterario in testa mentre scrivo. Detto questo, adoro Patricia Highsmith. Ma anche lei si interessava parecchio di narrazione cinematografica.
Come scrivi? Sei una pianificatrice, come Vesta fai le schede dei personaggi e le scalette, oppure come prima cosa ti siedi davanti alla pagina e ti lasci trasportare dal flusso della creazione (e, in questo caso, dai pensieri di un personaggio a sua volta ‘creatore’)?
Scrivo ogni libro in maniera diversa. Death in her hands è stato composto molto velocemente, con nessuna pianificazione e nessuna aspettativa, e poi è stato seguito da un editing piuttosto corposo. Per la prima stesura, semplicemente, mi sono messa a sedere e ho obbligato me stessa a scrivere mille parole al giorno: “finché non raggiungo la fine di qualcosa”, mi dicevo. Il processo si riflette sempre sul progetto, o almeno spero! Vesta, quindi, è una mente che esiste solo nel tempo presente, anche quando sta ricordando qualcosa: non ha programmi, insegue i propri pensieri così come le arrivano.
Sul perché scrivi, credo ti abbiano interrogato in qualsiasi maniera. A me interessa sapere il tuo parere su un’altra questione, invece: perché si legge?
Secondo me leggiamo per diverse ragioni. Io, personalmente, leggo romanzi perché mi piace. Per puro piacere. È bello abbandonare la mente su un libro, è rilassante ed è come se potessi scollegarmi da me stessa ed essere nella testa del narratore, o nel mondo della storia. È quasi un’esperienza paranormale, tipo essere posseduti o viaggiare in un’altra dimensione. Un po’ come scrivere!
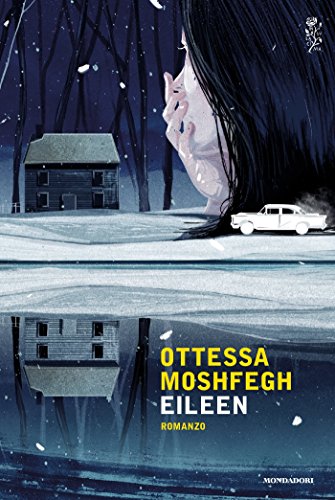
Una personalissima curiosità: come reagisci al lettore insoddisfatto e morbosamente curioso, quello che ti chiede di riempire quelle lacune di cui nel corso della narrazione ti servi, quei vuoti che volutamente lasci insondati? Il lettore che ti domanda: “ma quindi cos’è successo davvero, come va a finire? Non ce l’hai detto”?
Bella domanda! Mi viene da ridere perché è una specie di stranissimo miracolo quando il lettore reagisce come se il tuo personaggio fosse una persona vera. È fuori dalla mia comprensione, davvero. Il pensiero che possa esserci più storia di quella che sta dentro il libro, di quella che può essere letta, è esilarante. “Che cos’è successo davvero?” – non ho risposte a questa domanda.
L’ultima domanda è sull’argomento all’ordine del giorno – ormai da troppi giorni, purtroppo. Nell’ambiente editoriale già da mesi si fanno largo narrazioni della pandemia – o narrazioni influenzate dalla pandemia, o con la pandemia sullo sfondo. Molti si interrogano sulla precocità e precarietà di racconti di questo tipo: riconoscono una certa ripetitività, e avanzano dubbi sul trattare una materia così attuale, ancora in svolgimento, ancora non assimilata né del tutto compresa. Altri rispondono con l’inevitabilità del processo: sono cambiati i nostri gesti quotidiani, le nostre consuetudini, la nostra percezione del pericolo, e la nostra rappresentazione del mondo si adatta di conseguenza. Tu cosa ne pensi? Sono già in atto cambiamenti irreversibili e impossibili da eludere, o è presto per parlarne?
Non posso dire di avere familiarità con questo tipo di questione in ambito editoriale, ma credo che nulla sia reversibile. Nulla. Il tempo non scorre all’indietro. Però non vedo nessun problema nello scrivere della pandemia in questo momento. Nel caso ne uscissero fuori dei bei libri, be’, magnifico. Se invece non fossero interessanti, a quel punto, a chi interessa? Penso che se gli scrittori dovessero lasciare che un fatto sia terminato prima di scriverne, attendere di comprenderlo appieno, allora dovremmo aspettare in eterno…
Copertina: Ottessa Moshfegh, 2020. Courtesy: Penguin





